Variazioni
1 - Brother
Altro autore da sempre legato al mondo della yakuza, ma un po’ a corrente alterna e mai unicamente focalizzato sul tema del crimine organizzato in favore di un’analisi più universale di sentimenti e persone, è Takeshi Kitano. Qui in Brother, il tema da lui trattato si avvicina di più a quello più classico della criminalità spicciola, abbandonando dunque il suo autorialismo elitario o anche solo una scarsità di interesse verso la quale si focalizza gran parte dell’esercito di cassetta giapponese.
Ovviamente è lecito aspettarsi che Kitano non si avvicini alla massa in maniera facile, immediata e priva di sfaccettature fuori di testa come solo il Beat Takeshi di Takeshis’ Castle (in Italia, Mai dire Banzai) saprebbe fare. Innanzi tutto la yakuza è più presente al centro della scena per mere necessità di sceneggiatura: al centro della scena c’è il rapporto di amicizia che arriva fino alla fratellanza. Quella condivisione totale di fiducia e rispetto reciproco che si sente fortissimo nelle file del crimine organizzato come quelle di commilitoni in una guerra in cui l’importante è guardare sempre le spalle a chi combatte al tuo fianco. Non fa eccezione la storia narrata da Kitano.
Dove esce fuori prorompente la sua carica eversiva sta nella furia iconoclasta con cui Kitano disintegra tutto il mondo culturale dedito alla chiusura a riccio e all’annientamento di una condivisione che farebbe più ricca l’umanità. Perché il rapportio fraterno che lega i protagonisti della vicenda di Brother, non è fra due pari Yakuza. Non è nemmeno fra due impari yakuza. Ma è tra un mafioso giapponese che si trova ben lontano dalla terra del sol levante e approda negli Stati Uniti. E qui lega con narcotrafficanti di colore, rappresentanti di un ghetto sporco e violento che mal si addice alla raffinatezza giapponese della via della spada. Ma in questo accostamento ardito sta tutta la forza di un film, che sa davvero mettere al posto e allo squallore giusto pretese di superiorità ed elitarismo, sia di una cultura su un’altra che di una persona su un’altra.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
2 - Yakuza paper: Battles Without Honour and Humanity
Primo episodio della lunghissima serie degli Yakuza paper, questo Battles Without Honour and Humanity può senza dubbio contendere all’angelo ubriaco di Kurosawa lo scettro di capostipite e generatore del dizionario minimo della yakuza cinematografica. E’ vero che il film porta la data ben più tarda del 1973, ma è anche vero che la serie kult diretta dal grandissimo e compianto Kinji Fukasaku (non confondetelo col figlio Kenta, per carità!) si può tranquillamente considerare come un punto di svolta di questa infinita epopea.
L’ambientazione è infatti inconfondibile: quel crogiolo giapponese dell’immediato dopo guerra, quelgli anni 40 in cui ruggenti emergevano gang e famiglie. Ed è proprio nell’emersione contemporanea di poteri illegali che Yakuza paper getta le sue mani e i suoi occhi. Ad essere analizzato è quel feroce e autodistruttivo desiderio del vedere una torta bella, immensa e disponibile, ma accessibile a tutti. E vederne progressivamente staccarsi delle fette da parte degli altri. Ingordigia, gelosia, feroce volontà di essere gli unici sul trono più alto, che questo costi sangue e la perfetta consapevolezza che un potere del genere, per le stesse meccaniche con cui è stato guadagnato, non possa durare (insomma un po’ quanto Saviano stesso scrive in Gomorra).
D’altronde è il rovescio della medaglia di tutte le organizzazioni, criminali e non, che non si fondano sul merito e la competenza, ma solo su astuzia, ferocia e appartenenza a un gruppo che taglia fuori gli altri. Una volta arrivati in cima si può solo cadere perché si perde la forza e i collaboratori migliori in favore di un branco di scagnozzi il cui solo merito è l’ubbidienza. Fukasaku pone una pietra miliare, senza la quale probabilmente non avremmo nemmeno Miike, per dirne uno. E, nel caso che ve lo stiate chiedendo, questo film è ampiamente citato dal Tarantino di Kill Bill, anche nel titolo del famoso brano di Tomoyasu Hotei, sottofondo del trailer.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
3 - Ichi the killer
Non poteva certo mancare Takashi Miike a dire la sua sul tema della yakuza. Perché su di essa Miike ha fondato praticamente la parte più importante della sua poetica, soprattutto nella primissima fase della sua carriera, quella degli esordi da videotape (Fudoh, Dead or alive, Full metal Yakuza, Blues harp, The bird people in China) ma anche gran parte della sua transizione al commerciale, come questo Ichi the killer.
 In Ichi the killer, Miike si scatena, lasciando libero sfogarsi ai suoi istinti peggiori. C’è un gore e uno spatter senza ritengo, con persone tagliate di netto in due, mani mangiate fino allo scheletro, e la scena dello yakuza appeso al soffitto con i ganci, giusto per citarne tre tra le più celebri (ma ce n’è altre…). A questo incontrollato spargimento di sangue, Miike aggiunge anche la gratuità che da sempre lo caratterizza, nel peggiore dei modi (il rapporto fin troppo semplice che lega la libido del protagonista Ichi alla violenza, chiaro e disgustoso fin da come compare il titolo del film a schermo).
In Ichi the killer, Miike si scatena, lasciando libero sfogarsi ai suoi istinti peggiori. C’è un gore e uno spatter senza ritengo, con persone tagliate di netto in due, mani mangiate fino allo scheletro, e la scena dello yakuza appeso al soffitto con i ganci, giusto per citarne tre tra le più celebri (ma ce n’è altre…). A questo incontrollato spargimento di sangue, Miike aggiunge anche la gratuità che da sempre lo caratterizza, nel peggiore dei modi (il rapporto fin troppo semplice che lega la libido del protagonista Ichi alla violenza, chiaro e disgustoso fin da come compare il titolo del film a schermo).
Tuttavia non si sottovaluti la pellicola come un mero esercizio di soddisfazione di un pubblico da cassetta voyeur. Con un colpo di coda finale, ma ben anticipato da un’atmosfera onirica e narcotizzata, Miike racchiude interrogativi e dubbi disseminati nella pellicola in un unico grande punto difficilmente spiegabile, testimonie del complesso rapporto tra potere, sadismo e, appunto, voyeurismo. Imperiali, in questo, le interpretazioni di Tadanobu Asano nel ruolo di Kakihara, ma soprattutto del Jijii di Shinya Tsukamoto.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
4 - Drunken Angel
In tutta l’epopea yakuza nel cinema, che conterà ormai centinaia di film, si può dire che gran parte del lavoro di iconicizzazione e canonizzazione di stile e topoi letterari sia stato svolto proprio dall’angelo ubriaco di Akira Kurosawa. D’altronde si parla di un film uscito nel 1948, ben prima che esplodesse la popolarità del tema, soprattutto all’esterno del Giappone.
Di fatto il tema è la rappresentazione di due personalità prevalenti e strabordanti nella scena. Da una parte il giovane, idealista, assetato di fama, soldi, potere e donne. Dall’altra una persona ormai vecchia, che dovrebbe essere saggia e rappresentare la serenità della consocenza. Ma che da questa è tormentata e questo tormento la rende incapace di trovare le swcelte giuste per sé. Dall’alcool passa la sua bocca, dalla distruzione e annientazione totale del sè. Ma in questo nichilismo emerge la voglia di migliorare il mondo, di fare molto più di quanto sarebbe richiesto (comportarsi a modo) investendo la propria incolumità per salvare una vita da un baratro senza fondo.
Un rapporto dottore-paziente che evolve sempre più. Diviene al contempo amicizia, rapporto padre-figlio e oltre. Kurosawa poi esprime la sua arte al meglio. Dirige a tratti lucidamente, a tratti in stato di trance, come dopo una sbornia (celeberrima la scena nel locale notturno, con un Kurosawa quasi tarantolato e ipnotizzato dalle performance delle cantanti e della band).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
5 - The others
E’ impressionante notare all’interno di un film girato con tanto garbo classico come questo di Amenabar tanta innovazione e rottura col passato. Perchè la casa posseduta dipinta dal cileno, in questo caso, è in realtà un alveo materno: il male sta dappertutto fuori (la nebbia, la luce, i nazisti), il bene è dentro, è l’amore della madre, il caldo, il buio senza sorprese. Ma per quanto la vita possa sembrare eterna e fuori dal tempo le cose cambiano e senza rendersene conto bisogna affrontare l’esterno, gli Altri (The others, appunto).
E’ un orrore reale e credibile: non mostra una goccia di sangue, ma è tensione e paura che tocca nell’intimo le cose a cui più teniamo e vogliamo tenere inviolate dagli estranei. La crescita in questo caso è accettare la sorte dei propri cari, nel capire che chi spaventa è a sua volta spaventato, che prima o poi diventeremo noi gli intrusi e dovremo farci da parte. L’occhio di Amenabar è perfetto nel catturare questi aspetti, con uno stile difficile da vedere ancora all’opera nel ventunesimo secolo.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
6 - La casa 2
Quando si parla di case possedute negli anni ’80 l’elenco è interminabile (il vero incubo in quegli anni deve essere stato fare il rappresentante immobiliare). Ma difficilmente si troverà una pellicola che ha lasciato il segno più de La casa 2.
Sequel-remake del primo capitolo, il terzo film di Raimi presenta una situazione molto simile a quella già trattata rielaborandola sia sotto l’aspetto tecnico (le famose sequenze in soggettiva che in Evil dead chiudevano il film, ma anche l’uso della stop motion, nuovi effetti visivi molto più ricchi), sia sotto quello dei contenuti. La novità è infatti un’ironia decisamente più esplicita, e riuscita, di quella sussurrata nel capitolo precedente.
Dentro alla casa posseduta vengono fatti a pezzi dei giovanotti. Il perchè non è importante. Perchè tutto il plotone di cloni degli horror anni ’80 non ha quello che c’è in questo film: il carisma. Ovvero sua maestà Bruce Campbell. Il re infatti è l’eroe tipico di quel momento di storia americana: non ha importanza contro cosa si combatte, né come si faccia a distruggerlo, l’eroe lo farà a pezzi senza alcun dubbio. Per quanto possa essere demolito, decostruito e sanguinante lui ammiccherà sempre alla telecamera con la sua immortale ironia (come McLane, o come addirittura Lionel di Splatters, con tutte le differenze del caso). Alla facciazza del culto dell’aspetto perfetto del corpo che regnava in quegli anni.
| Voto (4/5): |  |
7 - Funny Games
Questo è il film che più di tutti si adatta alla definizione “Violenza domestica”. Con “domestico” inteso nel senso di “intimo”. Il cinema di Haneke è un’esplosione di violenza, non è una novità. Come non lo è che questa violenza raramente viene espressa in tutta la sua cattiveria sullo schermo, rimane anzi sussurrata a tinte espressionistiche rosso sangue, ma senza zampilli o concessioni al voyeurismo.
Quello che scandalizza in Funny Games è a che livello può giungere la violenza psicologica. La scena delle uova, per dirne una, mette alla prova per primi i nervi dello spettatore, che avrebbe voglia di avventarsi contro lo schermo per farlo a pezzi. E Haneke lo sa bene, gioca con il suo compagno di visione che inerme deve assistere a tutto, anche all’ammiccamento sfacciato dei carnefici alla macchina da presa. Perchè noi siamo lì e siamo vittime.
E le reazioni di pianti esagerate sono la summa massima di quello che diventano le persone nei nostri tempi: fortissime e temibilissime fino a quando la minaccia è lontana, ma basta una carezza e uno spintone per una reazione isterica di terrore. Vedersi violati impunemente è un affronto che difficilmente ormai riusciamo più a concepire, ed è questo che ci rende fragili e privi di reali difese, nascosti come siamo dietro quelle finte (che sia la porta di casa trasparente o la siepe a lato della strada nel film).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
8 - The messengers
L’immagine che meglio descriverebbe l’ultima opera dei fratelli Pang è un bambino autistico seduto con la faccia rivolta in un angolino e con le dita nelle orecchie. Tutto il minutaggio è infatti sprecato nell’oscillare ossessivo tra un clichè e un altro, senza nemmeno riuscire a trovare un’impronta stilistica degna di nota: “Che cosa ci mettiamo nella prossima scena? Continuiamo con la macchia alla Kurosawa (per far finta che i Pang arrivino a citare Il trono di sangue quando più probabilmente si rifanno a Poltergeist) o ci mettiamo due fantasmi giapponesi infarinati?”.
Le presenze che infestano la casa non spaventano e a non solleticano nessuna considerazione. Si salva forse la ricerca iniziale della prima vittima di un rifugio all’interno di quello che dovrebbe essere il proprio rifugio principe, la casa natale, discreto esempio di straniamento, ma inquadrato in maniera troppo impersonale e banalizzata.
Non sembrano crederci per primi nemmeno i registi, rappresentanti dell’ennesima chiamata in America di chi magari avrebbe anche qualcosa da dire (ma non ci giurerei) e che invece deve solo mettere la firma su un prodotto anonimo (vedi Muccino).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
9 - Darkness
E’ da premettere subito una cosa: io e Balaguerò non andiamo affatto d’accordo. Nameless era piuttosto irritante, Fragile invece nemmeno lo ricordo (probabilmente è composto da uno schermo nero per un’ora e venti). Darkness è la sua opera seconda e anche in questo caso non me la sento di promuoverlo, per quanto sia comunque un film a tratti gradevole.
Il fatto è che anche in questo caso la visione non ha grande significato perchè è sempre lo stesso film: stessi traumi infantili che tormentano anche gli adulti perchè “E’ tutto vero” e stessi fatti di sangue tra le mura domestiche che riemergono dal passato e maledicono gli sventurati nuovi inquilini.
L’unica ventata di novità sta nei protagonisti: normalmente le vittime designate sono famiglie modello american dream segnate dal Trauma Passato che minaccia di disgregarle ma che affrontando il Male supereranno. Qui invece la “casa maledetta” è il contenitore di una “famiglia normalmente maledetta”, gli orrori sovrannaturali sono finalmente davvero esternalizzazione e estremizzazione di tensioni familiari, del non detto, della quotidianità fatta di cattiveria sottintesa.
| Voto (3/5): |  |
10 - La casa sfuggita

Spiace dover parlare male di progetti del genere. Perchè il film di Ivan Zuccon si vede che è girato bene, che ha idee, che è curato. Purtroppo i soli 35 mila euro usati per la produzione si vedono tutti: camera digitale di bassa qualità, luci posizionate un po’ a caso, attori che fanno la figura dei dilettanti, questi sono solo alcuni dei problemi.
Ma il gusto estetico dell’inquietante è presente: la scena del violino la ricorderò probabilmente finchè campo. L’ispirazione lovercraftiana conferisce a tutto il lavoro una mancanza di freschezza nel trattare il tema della casa posseduta, è vero, però gli dona anche un’aura fuori dal tempo. Sebbene non si arrivi alle vette di eccellenza viste con Amenabar, verrebbe eguagliato di certo, se avesse avuto un budget decente, il buon lavoro di Stuart Gordon nella prima serie di Master of Horrors.
Si nota sul web l’esaltazione di questi nuovi giovani autori italiani horrorifici, come nel caso del Custodies Bestiae di Bianchini che estremizza, nel bene e nel male, le caratteristiche della Casa Sfuggita. Ma finchè qualcuno non deciderà di investirci sul serio queste rimarranno solo promesse acerbe.
| Voto (2/5): |  |
11 - Le verità negate
Ammetto di non conoscere nulla di Ann Turner, la regista di questo film, e confesso di averlo visto solo in quanto innamorato da ben 10 anni di Sam Neill, il Merlino più simpatico che mi sia capitato di vedere.
Questo film in sé non ha grandi punti di interesse: è il classico “thriller da 90 minuti”, ovvero tutta quella serie di film tutti uguali in cui sono certo che anche tutti i vari passaggi della trama (famiglia felice, inquietudini, paranoico/a che non viene creduto dagli altri) avvengono sempre nello stesso ordine e negli stessi minuti della pellicola. La regia è piuttosto piatta, cerca un po’ di visionarietà forse solo nelle sequenze oniriche, ma finisce per essere legnosamente statica nella forzata simbologia che vuole mostrare.
Il poco di interessante è veicolato da una sceneggiatura scritta discretamente bene: non ci sono infatti dialoghi di troppo ma ogni aspetto psicologico è mostrato e non detto, regola d’oro troppo spesso dimenticata. Certo, rimangono i classici buchi incomprensibili: possibile che tutti gli indizi per arrivare al bandolo della matassa siano custoditi tutti nello stesso punto, che è ovviamente quello in cui viene rinchiusa l’unica persona in grado di collegarli?
| Voto (2/5): |  |
12 - Matrix
Avvertenza: non sto per parlare male di Matrix solo per darmi arie da intellettuale. Lo ritengo infatti un dignitosissimo prodotto, curatissimo sotto molti aspetti, ha fatto scuola sotto altri (nel bene e nel male) e tutto il resto. Ma in questo caso non posso promuoverlo. Se capiterà di parlarne sotto un altro aspetto sarò felicissimo di tesserne le lodi. Ma ora proprio non ce la faccio.
Matrix è un film stupido. Matrix è una baracconata new age per piccole tasche con le esplosioni. Se fosse un libro, Matrix sarebbe quei piccoli libri editi da Adelphi di 40 pagine riempiti di aforismi di Schopenhauer. Quelli che si comprano tanto per fare gli intellettuali da due soldi di cui sopra e dire di aver letto della filosofia e che si scorrono (facendosi delle gran risate, per carità) in mezzo pomeriggio.
Benissimo il velo di Maya rappresentato con i caratteri verdi cadenti. Benissimo la citazione da Bella addormentata nel bosco. Benissimo Giuda e i cucchiai zen che si piegano. Ma “Svegliatevi, dormienti!” è un’altra cosa. Matrix invece puzza lontano un miglio di operazione fatta giusto perchè “cool”, per mettere insieme due mossette di kung fu estrapolate dai gongfupian (e da tutto quello che lì significano) e creare un nuovo supereroe, nuovo esempio di “Sindrome di Mark Hamill” dalla quale il buon (?) Reeves ha dovuto sudare per uscire.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
13 - Millenium actress
Assai simile al decisamente più toccante Big fish il secondo film del bravo Kon è un viaggio all’interno della vita dell’attrice del millennio cui si riferisce il titolo. Il viaggio è fatto attraverso le immagini dei film che ha girato nella sua carriera e visto con gli occhi del vero protagonista della storia: il giornalista che decide di intervistarla 30 anni dopo il suo ultimo ciak.
Toccante affresco di due personalità che inseguono qualcosa di troppo lontano perfino per il loro sguardo, Millenium actress sostituisce alle favole di Big fish il cinema. Il protagonista è buttato a forza in situazioni romanzesche tipiche della tradizione nipponica (il rimando a Il trono di sangue è urlato), che rispecchiano nella doppia farsa del film/racconto dell’attrice un mondo che non può cambiare. Per quanto si possa sforzare è sempre una comparsa e anche al centro della scena non può fare nulla per spostare i binari di una triste storia che si è consumata più di 30 anni fa. Esattamente come uno spettatore non può cambiare, per quanto partecipe al dolore di un personaggio fittizio, il finale di un film.
| Voto (3/5): |  |
14 - Welt am draht
Probabilmente uno dei migliori Fassbinder, Il Mondo sul Filo (questa la traduzione del titolo) colpisce sotto molti aspetti. C’è un’incredibile originalità dell’intreccio, una rivisitazione tecnologica dell’uomo che si vuole fare Dio di un mondo da lui creato. C’è un folgorante parallelismo tra l’illusorietà caleidoscopica di mondi falsi e mondi veri e la regia. I personaggi infatti vivono in un mondo riflettente in cui sono impallati e replicati infinite volte all’interno della scena. Ci si chiede spesso con chi stanno parlando, se con un altro essere umano o un riflesso che scimmiotta solo la vita. La stessa fotografia aumenta lo straniamento, con statue greche fuori dal tempo o scelte cromatiche alla maniera di Klimt.
Le figure umane quindi guadagnano ulteriore impalpabilità. Oltre quella sullo schermo c’è anche quella oltre lo schermo: in che mondo si stanno muovendo? E siamo sicuri di saperlo anche noi? Libera rilettura di tematiche esistenziali alla Solyaris, non è riuscito a scampare dall’infamia di un remake decisamente più bambinesco e immaturo.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
15 - Allegro
Allegro va a toccare un altro grande capolavoro di Tarkovskij, citandone esplicitamente La Zona da Stalker. Questa “Zona” nasce dal profondo shock del protagonista principale. E’ quindi un posto dove l’intimo, il subconscio e strane presenze convivono e si mescolano. Luogo dell’anima in cui nessuno può entrare, luogo che c’è in ognuno di noi, ma che Zetterstrom ha materializzato nella realtà.
La realtà molteplice quindi si snoda tutta all’interno della psiche di un uomo ed è quindi misteriosa per lo spettatore ma forse, ancora di più, proprio per il protagonista che deve guardarci dentro. Gli errori che lo hanno portato a naufragare nel proprio io infatti sono evidenti, e vengono esplicitamente detti all’inizio. Ma la forma di cecità peggiore è la miopia nel guardarsi dentro: così vicino così sfumato.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
16 - The wicker man
In questo film cult risalente al 1973 il protagonista, un sergente di polizia ligio al dovere e fervente cristiano, viene mandato ad indagare sulla scomparsa di una bambina in una comunità rurale della Scozia.
La pellicola, diretta magistralmente da Robin Hardy, incentra tutta la sua azione nel delineare il contrasto tra un uomo fermo sostenitore dei propri principi e un luogo (incarnato nel personaggio di Christopher Lee) in cui tutti questi principi non sono solo disattesi, ma perfino messi al bando.
L’atmosfera fuori dal tempo che si respira è difficilmente inquadrabile in un genere preciso. Il suo scopo è quello di accentuare ancora di più quello che è in fondo lo scontro tra due personalità, o più precisamente tra due credo, il cui esito è quello di bruciare nell’uomo di vimini le certezze e i dogmi correnti. Il sabba celebrativo vuole mostrare attraverso i suoi evidenti paradossi le conseguenze di una fede cannibalmente cieca e priva della responsabilità e dei doveri che (dovrebbe) avere nei confronti delle persone che governa.
Astenersi dal recente remake con l’orso-Cage ballerino, mentre assai interessante dovrebbe essere il ritorno di Hardy dietro la macchina da presa, dal titolo magnifico (e impossibile, scommetto, da vedere in Italia): Cowboy for Christ.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
17 - Pleasantville
Pleasantville è la storia di due ragazzi dei nostri giorni che si ritrovano catapultati all’interno di una sit-com in bianco e nero degli anni ’50. All’interno di questo mondo fittizio tutto è ovviamente perfetto e al suo posto per un abitante del luogo, ma per un ragazzo degli anni ’90 abituato a ben altri stili di vita può essere l’inferno.
La morale di questo scempio su pellicola viene riassunta dal suo slogan ‘Nothing is as simple as black and white’ (e su questo credo che monsieur La Palice sarebbe d’accordo). Quello che punta a definire è una società opprimente che comprime in una finta perfezione la mancanza di ‘personalità’ e ‘unicità’. I toni bambineschi sono ulteriormente instupiditi da un certo sottotesto reazionario che basa la cosiddetta ‘libertà di comportamento’ con un po’ di casto sesso o un ‘merda!’ sussurrato che dovrebbe spaventare o far ridere. Ovvero: la libertà in fondo è una trasgressione da salotto.
Il punto fondamentale è che le scelte presentate sono troppo facili e per nulla sofferte: è elementare ‘rinunciare’ a un mondo per nulla attraente (per finire poi nella conformista società che si sente trasgressiva e libera solo perchè dice ‘culo’ ogni tanto). Il risultato è quello di far accontentare gli spettatori e anestetizzarli su come è bello vivere nei nostri tempi.
| Voto (1/5): |  |
18 - Den Brysomme manner
Questa bomba atomica col silenziatore targata Norvegia porta egregiamente a compimento, a mio avviso, il tema delle società opprimenti fintamente utopiche. Presenta infatti una realtà convincente, in cui non tutto è ovvio fin dal primo minuto. Inoltre la minaccia apportata a un protagonista caduto in mezzo alla storia non si sa bene come è sottile e subdola.
I toni pacati potrebbero far pensare a un Pleasantville a colori: in realtà la ‘società utopica’ riesce a far rientrare nei suoi schemi tutto, dal lavoro al sesso. La scelta tra lo stare al gioco e il non rinunciare alla propria vita è molto più sofferta: guardandosi dentro onestamente chi potrebbe rinunciare senza battere ciglio a un lavoro facile e remunerativo? Più una decappottabile? Più una bella casa, una relazione con una bella donna? La società arriva perfino a offrire un’amante, siamo ad anni luce dalle ‘offerte irresistibili’ del piatto Pleasantville.
La ‘Zona’ arriva a rendere immortali, è impossibile suicidarsi. Ma la pena per chi prova a ritagliarsi uno spazio in cui gustare per davvero un caffè, in una scena fantastica, è alta, totale. Anche in questo il film (che ha per protagonista un incrocio tra Lapo Elkann e il Noah Taylor di E morì con un felafel in mano) mostra grinta e coraggio, nascosti dietro un velo di finta pacatezza.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
19 - Hot fuzz
Seconda fatica di ‘quelli di Shaun of the dead‘, questo Hot fuzz è un vero e proprio concentrato di quanto di meglio possa offrire il cinema di intrattentimento nel 2007. A volte perfino troppo concentrato, visto che la durata (due ore nette) è infarcita fino a scoppiare, con un montaggio fin troppo rapido e pieno di cose da dire che, almeno all’inizio, lascia un po’ spiazzati.
La società utopica che popola Sandford, sebbene sia ovviamente parodica e ritratta in maniera giocosa, è forse una delle più acute nell’individuare i pericoli del tipo di vita a cui aspira le gente reale. Il motore che la anima trae probabilmente ispirazione dalle liti condominiali, che ovviamente portato su schermo ai suoi eccessi diviene qualcosa di comicamente grottesco, riuscito fino in fondo.
Questo lavoro comunque pare decisamente un gradino sotto a quel gioiellino che è Shaun of the dead, sia per i problemi di regia rilevati che in fase di sceneggiatura. C’è infatti una minor profondità nei personaggi, oltre a un richiamarsi più al comico che al vero grottesco (complice anche il genere scelto, meno horror e più action).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
20 - Il grande capo
Tutti hanno un capo a cui dover rendere conto. Il mestiere del capo è piuttosto infame e ingrato, odiato da tutti e amato da nessuno. Qual è la soluzione per un capo? Avere a sua volta un capo verso cui indirizzare le responsabilità delle decisioni più impopolari.
Sagace, ironico, acuto e sbruffone, quest’ultimo lavoro di zio Lars sarebbe stato bene anche nella variazione del Mise en abyme. Quello che attua è uno straniamento dalla realtà, apparentemente elitario e asettico, in realtà irriverente e graffiante, dell’alienazione in cui versa un lavoratore dipendente. Non si sa più per chi si lavora, in buona sostanza, né perchè: c’è solo un lavoro che deve essere fatto. Il “potere” rimbalza quasi impazzito da una persona all’altra, è uno scettro portato da chi deve essere il feticcio dell’odio, figura fondamentale per poter sopportare il proprio ruolo da subordinato e far funzionare una squadra. Il paradosso in cui si vive lo fa però finire nelle mani dell’unica persona che non ne sa assolutamente niente.
I difetti non mancano, come un uso francamente stereotipato del narratore fuori campo e una forma stilistica che potrebbe allontanare molte persone dalla pellicola. In realtà se ci si mette in gioco e si accetta la partita proposta dal film non si può fare a meno di ridere di lui/noi e di apprezzare la sottile satira alle nevrosi quotidiane (la scenetta della fotocopiatrice o il teatrino finale per la simpaticissima interpretazione di Fridrik Thor Fridriksson).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
21 - Il cacciatore di teste

‘Il cacciatore di teste’ è un miracoloso esorcismo agli impeti di frustrazione che attanagliano chi è imbrigliato nel limbo della disoccupazione. Mette in scena con naturalezza la tragedia di chi, qualificatissimo e bravo nel proprio mestiere, è consapevole che più tempo trascorre dal suo licenziamento meno probabile diventa una sua futura assunzione.
Da questo assunto parte un’avventura che per la propria fredda spietatezza diventa onirica e irreale. Quella che è una lotta per la sopravvivenza combattuta a suon di curriculum e colpi più o meno bassi (come in Cresceranno i carciofi a Mimongo) diventa una vera guerra con sangue e pallottole. E’ un magistrale pezzo di cinema che sublima con una metafora estrema quello che la società maschera come un processo pacifico, ma che non è né più né meno che un darwinismo paradossale.
Ci tocca talmente a fondo nell’intimo che non possiamo fare altro che ammirare l’ingegnosità del protagonista. E tifare per lui, tremare all’idea che non ce la faccia, perchè la riuscita delle sue azioni delittuose è conforto e speranza per noi tutti.
| Voto (4/5): |  |
22 - Executive Koala
Questo pupazzoso film nipponico porta all’estremo la ‘disumanità’ in cui lentamente scivola il mondo del lavoro degli esseri umani. Lo fa su piani differenti partendo da quello ovvio della ‘forma’ dei propri interpreti (koala, conigli, rane antropomorfe che si comportano come se fossero uomini) che è poi forse l’unico vero motivo per cui parlare di questo lavoro.
Questo perchè anche gli altri piani potrebbero essere interessanti. Si va dalla follia rimossa rinunciando alla propria personalità, alla persecuzione totale di un sistema progettato da noi che si ribella al suo creatore. Il problema è che il film non sa che cosa essere: non sa se puntare sul non sense o sull’horror, finendo addirittura in un action evidentemente ridicolo (voleva esserlo e c’è riuscito troppo bene) che nulla aggiunge alla vicenda e sa di stantìo, di ovvio, di facilone.
Credo che il film sarebbe dovuto rimanere sui binari dell’idea iniziale, visto che i momenti non sense sono decisamente i più riusciti. Imperdibili le sigle di apertura e chiusura.
| Voto (2/5): |  |
23 - 13 Beloved
Belll’esempio di cinema dalla Thailandia, questo 13 Beloved. Non è di certo un grandioso pezzo storico, ma a modo suo è complesso e interessante, merita più riletture e testimonia che il cinema contemporaneo Thai non è solo il Pen-Ek Ratanaruang di Last life in the universe e compagnia.
Sebbene le scene ‘lavorative’ siano in minoranza all’inizio del film e sebbene il tema principale sia un Grande Fratello che gioca col destino dei comuni mortali, 13 Beloved ha una sua valenza nel testimoniare alcuni aspetti del lavoro nel nuovo secolo. Pusit, il protagonista, è infatti un ingranaggio come tutti nella macchina moderna. Anzi, non come tutti: è infatti uno degli ingranaggi meno oliati e più lenti. Tartassato da un sistema che eleva palchi ai vincenti costruendoli buttando nel fango quelli come Pusit, il protagonista si trasforma in una bomba ad orologeria.
La miccia per farlo esplodere nel suo giorno di ordinaria follia è il gioco 13 Beloved, ovvero il sogno di ogni ingranaggio: quella di una pioggia d’oro facile e immeritato. Onestissimo, quindi, il lavoro di Sakveerakul, che ha il pregio di colpire sotto la cintura alcune ipocrisie del mondo contemporaneo.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
24 - Born to fight
Questo delirio in salsa Thai da 96 minuti (di applausi) è qualcosa che difficilmente risulta comprensibile alla mente umana per la sua totale mancanza di un senso. Chi è un po’ più avvezzo alla cinematografia Thailandese da esportazione (Ong-bak, The Protector, Dynamite Warrior, Chocolate) sa a cosa va incontro. Ovvero mazzate. Tante. E spesso senza un filo logico che le lega l’una all’altra e che non sia riassumibile in una riga e mezzo (prendendosela comoda con la grandezza dei caratteri).
Born to fight non fa eccezione. E non la fa alla grande: i cattivi presentati sono delle macchiette ridicole come un corsaro a una cena di gala, sono i famosi “Cattivissimi” armati con il “Dispositivo Fine-di-mondo”. Gli “eroi” che vorrebbe tratteggiare sono i campioni dello sport (!), cui ovviamente ribolle il sangue nelle vene a sentir sbeffeggiato il loro inno e che sconfiggono il Male dei terroristi sfruttando le loro specialità (la ginnasta sfugge usando le sbarre dell’ambiente circostante come se fossero parallele, il calciatore prende a pallonate i nemici e così via). Aggiungete anche dei paraplegici a fare rovesciate e il quadro è completo.
Questo è il patriottismo che mi piace. Anche se rimane l’orrido sospetto che in Thailandia i patriottici che parlano così siano seri, non si può rimanere indifferenti a tanta comica sconclusionatezza. Finchè il nazionalismo agisce con macchiette e pupazzetti esplicitamente ridicoli non può far male, può però intrattenere. In fondo un po’ di campanilismo diverte tutti.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
25 - Independence day
Independence day è un capolavoro. Persa, dopo una frase di appena cinque parole, metà della mia utenza, posso cominciare a motivare una frase come quella appena scritta.
La bellezza di Independence day non sta nelle sue caratteristiche interne di realizzazione. La regia è dozzinale (stiamo parlando di Emmerich, di cui volevo recensire per questa variazione Il patriota), la sceneggiatura è un gruviera e contiene le classiche spacconate da “Film del 4 Luglio Americano”. Infatti l’interesse non viene dal film, ma dal prodotto che il film rappresenta. In altre parole Independence day è un documento, e come tale rappresenta la testimonianza di una mentalità. E’ un po’ come Pasolini prossimo nostro: non è interessante quello che viene detto e come viene detto, ma lo è il fatto che quella realizzazione avviene in quel momento e in quel luogo.
Independence day con il suo parallelismo alieni/comunisti è una rappresentazione quasi documentaristica di un popolo che, perso un nemico, non sa più cosa temere (ovviamente nel 1996), ma sa (spera) che i suoi eroi spacconi abbatteranno qualsiasi cosa si troveranno davanti.
| Voto (3/5): |  |
26 - 2009: Lost Memories

Questo dimenticabile film Sudcoreano basa l’intera sua struttura su un “what if”: cosa sarebbe successo se la Corea non avesse mai raggiunto l’indipendenza dal Giappone (il cui dominio sulla penisola è durato dal 1910 al 1945)? Tutta la sconfinata durata del film basa la sua prima parte sul piagnucolare dell’unicità culturale Coreana che nulla ha da invidiare a quella Giapponese, con la classica maturazione interiore del suo eroe che prova a integrarsi ma è vittima dei pregiudizi cattivi cattivi.
Dalla seconda parte, non potendo dare sfogo a una guerra colossale con spade laser e unicorni alati per la cacciata dei Giapponesi dalla Corea al Calderoliano grido di “Ognuno a casa propria”, il film scivola pesantemente su gravi forzature alla sceneggiatura. Viene creato un impianto fantascientifico difficilmente in grado di reggere a un’analisi anche solo approssimata e che suona tanto di “Succede questo e quest’altro perchè si”.
Patriottismo dozzinale e poca cura nella scrittura fanno capire quanto distanti si sia dal vero gioiello (patriottico? A modo suo sì) Joint Security Area di Park Chan-Wook.
| Voto (1/5): |  |
27 - Fist of legend
Jet Li non è nuovo a interpretare ruoli “nazionalistici” in terra cinese (ad esempio la serie C’era una volta in Cina di Tsui Hark, Fearless o Hero). In questo remake di Fist of Fury viene diretto con un tocco più smaliziato (sia rispetto all’originale con Bruce Lee che alle opere medie di Tsui Hark) da Gordon Chan.
Come in molti film patriottici cinesi, anche in questo caso il teatro di base è l’occupazione nipponica della Cina. Dove Chan evita gli scivoloni propri dell’originale è nella rappresentazione del nemico occupante. Intendiamoci: non è con quattro frasi paracule messe in bocca ai “cattivi” che si crea una buona sceneggiatura, ma il plauso va comunque per la creazione di una situazione complessa, in cui in realtà non è ben chiaro quale sia la strada migliore da seguire.

Facilona è invece condensare l’intera soluzione con un duello finale. Anch’io sono d’accordo con mio nonno quando diceva che “Se i generali vogliono fare la guerra dovrebbero prendersi un paio di spade e giocarsela tra loro”, e sarà anche un topos del gongfupian (i film di kung fu cinese), ma non si può mettere in piedi un’intelligente situazione e risolverla con due calci e “e vissero tutti felici e contenti…”.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
28 - Waking life
Schopenhauer diceva che “Il furore di leggere è una specie di fuga vacui: un fuggire dal vuoto di pensiero dei cervelli”. Quello che scatenava la furia del simpaticone teutonico non è tanto l’”atto” del leggere, ma l’”atteggiamento” che si ha nel leggere. E questo atteggiamento è esattamente quello che si ha durante la visione di Waking life. Il film di Linklater infatti è un colossale ammontare di parole riversate a casaccio dall’inizio alla fine.
Il frastornarsi onirico è reso in maniera magistrale dai dialoghi, ma è un esercizio di stile fine a se stesso. Come il fuggire dal vuoto di pensieri, Waking life è un manualetto per riempirsi la testa dei pensieri di un altro, un esempio di intrattenimento sciocco che basa tutto il suo fascino sull’oscurità. E’ il classico esempio di film il cui estimatore termina la visione con il soddisfatto commento “Non ci ho capito niente: figata!”.
D’altronde “Tenersi alla larga da ogni cosa che coinvolge sia Linklater che Soderbergh” si può dire che sia più di un avvertimento: è una filosofia di vita.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
29 - Talking head
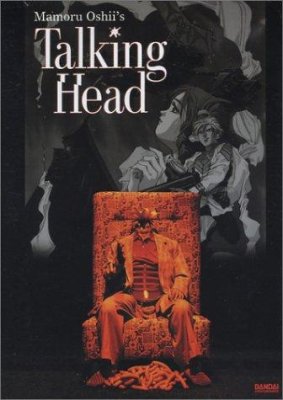
Normalmente rimango piuttosto indifferente (più spesso indispettito) dai giochetti di sceneggiatura del “film nel film” ovvero un film che racconta in maniera diretta ed esplicita la realizzazione di un film fittizio. Tra le eccezioni giustificate c’è il giocoso Effetto notte, ma Talking head riesce ad entrare in questi casi fortunati solo per metà.
La sceneggiatura è una spirale che porta ogni personaggio a rappresentare una parte del film che viene disintegrata (il sonoro, il colore, le musiche, …): espone la sua teoria, il suo ruolo, e quindi scompare. Anche l’assenza di scenografia porta sempre di più all’isolamento il personaggio del “Regista in grado di copiare ogni film”, sia dal suo lavoro che dalla realtà. Tutto questo avviene in un caleidoscopio di invenzioni visive volutamente ingenue, il cui esempio principale è proprio la testa parlante che dà il titolo al film.
Durante il film stesso viene però detta la frase che lo auto-condanna. “Fare un film è come commettere un crimine: per quanto tu possa stare attento le modalità con cui lo compi rivelano le tue intenzioni”. E l’intenzione di parlarsi addosso anche in questo caso c’è, si vede, e alcune parti sembrano essere state aggiunte a forza solo per mostrare i muscoli di una quasi vuota meta-conoscenza del cinema.
| Voto (2/5): |  |
30 - Concursante
Tutti noi sogniamo di trovare la lampada magica che renda realtà i nostri desideri. Ma la realtà in cui piomberebbero questi desideri è solo un sogno, perchè se essi precipitassero nel nostro mondo concreto si tramuterebbero di certo in incubi: la vita non è così semplice.
Quella sopra esposta è la morale di Concursante, un docu-fiction spagnolo che cerca di smascherare il gioco con cui le banche regolano la nostra vita. Il nostro protagonista Concorrente viene infatti prima sedotto da affascinanti teorie economiche senza alcuna base matematica e poi si rende conto che la realtà concreta è assai diversa da quella scritta in mezzo alle cifre virtuali di un conto corrente. Tutte le metafore visive, alcune molto ben pensate, puntano in una direzione ben precisa: quella di aprire gli occhi sulla colossale truffa economica che in questi giorni sta scoppiano in mano perfino a coloro che l’hanno ideata.
D’altronde si potrebbe riassumere tutto con la famosa citazione di Henry Ford: “It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning” (“E’ un bene che le persone non capiscano il nostro sistema bancario e monetario, perchè, se lo capissero, ci sarebbe una rivoluzione prima di domattina”). Da segnalare anche la recitazione di Leonardo Sbaraglia, ben lontana da quella di un alunno dell’Actor’s Studio, piena di ingenuità e cadute di toni, ma che sa tirare fuori delle piccole perle (“Porque si no… Lo mato”). [Di seguito si riporta il primo spezzone del film su Youtube, dove è fruibile per intero e con i sottotitoli in italiano]
| Voto (3/5): |  |
31 - Born to fight
Ci sono tizi che combattono sul tetto di due tir e vi cascano in mezzo passando con la testa a venti centimetri dalle ruote. Ci sono ragazzine alte un metro e una formica di traverso prendere a thai-ginocchiate dei terroristi armati di mitra (e rincarare la dose con delle sane pedate dietro la nuca eh!). C’è un tizio che si butta a capofitto con una moto in mezzo alle fiamme. Un altro che mena i stronzi con un paio di legni arroventati.
C’è una sottospecie di Kitano-karateka che nessun cinefilo può esimersi dal vedere. C’è la “Gomitata su ‘a capoccia” © (marchio registrato da Tony Jaa, tutti i diritti riservati). C’è un tizio senza una gamba che combatte come manco uno dei peggio ceffi da capoeira. C’è un terrorista che viene letteralmente spalmato dentro un enorme vaso. Perchè accade tutto ciò? Boh!
Comunque sia il film secondo gli ostacoli del non prendersi troppo sul serio perde su tutta la linea, perchè è troppo evidente quanto regia e sceneggiatura si prendano eccessivamente sul serio. Soprattutto, noto in chiusura, con la vita dei poveri stuntman: se riuscite a trovare in giro un backstage guardatelo e vi renderete conto di quanto paia impossibile che in Thailandia non muoiano due dozzine di stuntmen l’anno.
| Voto (1/5): |  |
32 - Terremoto nel Bronx
Chiamare Jackie Chan “erede” di Terence Hill è quanto mai inappropriato, perchè l’oramai inciccionito funambolo dagli occhi a mandorla ha alle sue spalle una carriera sterminata che comincia come protagonista già negli anni ’70 (ad esempio con Drunken master o l’originale FaceOff) e come comparsa addirittura prima (nel leggendario A touch of zen e in svariati film con Bruce Lee). Si può quindi dire che il Keung di questo film sia un fratellino minore di Trinità o una perfetta spalla di Bud Spencer in Altrimenti ci arrabbiamo.
Quello che accomuna i due ragazzi che ci conquistano con la simpatia dei loro cazzottoni è un uso fantasioso dell’ambiente circostante. Tutto attorno a loro è un’arma e viene usato per ridicolizzare l’avversario, da un carrello della spesa a uno sci. C’è ovviamente un significato profondo in tutto questo, una splendida metafora con la quale si sussurra allo spettatore che anche nelle situazioni più nere c’è sempre una soluzione a portata di mano, che mai bisogna dispera…
Ok basta: Jackie Chan è divertente perchè mena forte e lo fa con fantasia. E’ stato anche abbastanza intelligente nella sua carriera da non farsi coinvolgere quasi mai in lavori gestiti completamente da stranieri: il suo gongfupian è tipicamente di Hong Kong e fuori da Hong Kong ha poco senso. Anche Terremoto nel Bronx è di fatto una produzione orientale e questa recensione ha parlato in generale di Jackie Chan in quanto questo film segna di fatto in maniera caratteristica tutti i suoi altri lavori.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
33 - Chocolate
Immaginate che una simpatica vecchina vi debba dei soldi che le servono per coprire le sue spese mediche. Immaginate di essere dei creditori brutti sporchi e cattivi. Immaginate che a chiedere una proroga o l’annullamento del debito vengano da voi due Thailandesi: un tizio qualunque un po’ tontolone e una ragazza autistica che peserà al massimo cinquanta kili. Per di più costoro girano per i bassifondi di Bangkok IN VESPA. Beh siete creditori brutti sporchi e cattivi no? Che altro potete farvi se non una risata?
E invece è meglio stare attenti. Perchè, come ci insegnano tutti i film, gli autistici hanno i superpoteri. Questa in particolare essendo cresciuta sopra una palestra di Thaiboxe ripetendo gli esercizi che vede è diventata un’esperta di arti marziali (!) in grado di fermare i coltelli che le lanciano contro senza guardare.
Il baraccone, per quanto abbastanza delirante e senza senso, non funziona però nemmeno per un secondo. Innanzi tutto non si capisce lo scarso impegno nel trovare il pretesto per scatenare la caciara: sembra quasi un serioso incitamento alla prepotenza. Inoltre le citazioni a Bruce Lee, sia quelle esplicite (la visione del film alla televisione e la lotta con gli urletti nel ghiaccio) che quelle implicite (la sottospecie di torneo finale con i vari stili di combattimento), sono solo irritanti e per nulla efficaci.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (1/5): |  |
34 - The protector
Come richiesto dalla variazione, in questo film si raggiungono le vette mondiali di semplicità della trama. A un tizio rubano un elefante (!) e questa cosa lo fa talmente incazzare da prendere un aereo per Sydney e riempire di botte chiunque gli passi a tiro. Fine. Giuro: non succede davvero altro.
Con questo film Tony Jaa (Ong-bak) si dichiara esplicitamente un figlio di Jackie Chan (vedi il cameo di quest’ultimo all’aeroporto). La fisicità esplosiva di questo ragazzo viene mostrata lungo tutta la durata del film senza che ci sia veramente spazio per altro. Anche in questo caso il film soffre un po’ della mancanza di originalità (c’è il solito siparietto alla Bruce Lee sul “torneo” tra combattenti di provenienze diverse, ma Nathan Jones non regge il confronto con Abdul-Jabbar) e di una regia approssimativa.
Lungi dall’irritante triplo rallenti ostentato di Ong-bak, Pinkaew cade in uno stile tecnico pesantemente presuntuoso. Il lungo piano sequenza è si affascinante e testimone di una bravura incredibile, ma è innegabilmente molto più noioso di un combattimento classico in quanto perde la possibilità di sottolineare la coreografia con il montaggio. In chiusura a un massacro di un’ora e venti (sarei curioso di vedere la versione originale con quasi mezz’ora di più) non ci si può trattenere dall’esplodere di risate alla battuta conclusiva del film: “Noi Thailandesi amiamo la pace… E’ che non sopportiamo i prepotenti”. Bella per te, Pinkaew!
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
35 - Following
Opera prima di Christopher Nolan questo Following ne espone in maniera ingenua e per nulla mascherata le idee che caratterizzeranno la sua produzione futura. Al centro della vicenda c’è infatti un ragazzo che confessa la sua insana passione per il pedinamento. Questo suo morboso attaccamento al sapere è la condanna che lo porterà all’interno di una situazione più grande di lui.
E’ evidente che a Nolan interessi la manipolazione. Il protagonista che vorrebbe bearsi della sua trasgressione è invece creta informe nelle mani di un finto amico smaliziato che sembra voler portare le sue tendenze naturali all’estremo, mentre invece finirà per condurlo alla perdizione. Se da queste poche parole qualcosa nella vostra testa comincia a rimandare al personaggio di Teddy in Memento siete sulla buona strada. Ancora migliore se vi ricorda la passione per la manipolazione che ha anche nel suo cinema Daniele Vicari (L’orizzonte degli eventi per dirne uno a caso).
Ma in fondo la manipolazione delle menti è anche pane per i denti di un Joker, in cui la figura del personaggio di Cobb in Following, con tutti i suoi giocosi discorsi sulla psiche umana, può specchiarsi senza trovare grosse differenze.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
36 - Eraserhead
Eraserhead è un film che mi mette in difficoltà. Da un lato esso fa certamente parte della filmografia di Lynch “che funziona” quella dove il regista del Montana non fa troppo il fanboy di se stesso. Dall’altro è innegabile che esso contenga in stato embrionale proprio tutti quegli elementi di voluta oscurità e di vuoto fascino che me lo rendono tanto odioso.
Il fatto è che in questo film, a parte l’incipit veramente assurdo, tutto il resto, dalla creazione dell’ambiente surreale, gli elementi horrorifici, la scenografia demolita e quant’altro sono funzionali alla storia, hanno significato. Prendendo le pareti inclinate ad esempio è chiara la metafora dell’ambiente sempre più soffocante e insopportabile che sempre più si stringe attorno al suo protagonista. Una situazione insostenibile in cui non si sa come ci si è cacciati, come quella di un effetto speciale veramente magistrale nel suo essere rivoltante.
Ho apprezzato davvero tutti questi elementi e lo considero ancora uno dei Lynch massimi. Tuttavia c’è un fastidioso retrogusto in tutto questo. C’è la sensazione che è partito tutto da qui, che i capelli sparati di Henry Spencer siano davvero il preludio ai nani, ai conigli di pezza, alle scatolette misteriose che se possono entrare nell’olimpo di qualcosa, certamente quel qualcosa è la sconclusionatezza.
| Voto (4/5): |  |
37 - Pi
Impossibile cercare un paradigma comune all’interno della filmografia di Aronofsky. Ogni opera sembra voler a forza negare tutti i paradigmi stilistici della precedente. Guardare Pi quindi significa guardare solo il punto da dove è partito un elettrone impazzito.
Il Max protagonista è un incrocio tra Icaro e Ulisse, un uomo che vuole avvicinarsi a una conoscenza più grande di lui con tutti i mezzi e l’ingenuità che gli è stata concessa. E se l’aver cercato di guadare il sole lo rende sempre più instabile come chi ha avuto uno scorcio di una logica superiore che non può capire, la sua ossessione per i numeri lo porterà sempre più vicino alle ombre di petrolio della magistrale e sporca fotografia del film.
I numeri rappresentano non più che una formula magica religiosa che sembra riuscire a mettere tutto al suo posto. I primi giochi infantili (il prevedere i risultati di borsa) portano Max all’attenzione di chi davvero crede di aver trovato la chiave per aprire le porte a Dio. Ma è un’ovvia illusione bambinesca quella di poter imbrigliare il sole in piccoli artefatti di creazione umana: a un problema complesso e intimamente connesso alla nostra natura (simbolizzato dalla Torah) non c’è mai una soluzione universale e apprendibile con un semplice studio (simbolizzata dalla matematica).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
38 - Stereo
La carriera di uno dei massimi cineasti mondiali, secondo il mio misero parere, ovvero David Cronenberg, è un percorso stranamente dritto e lineare. Ogni suo film infatti rappresenta un passo avanti o un mutamento di scenario/metafora di quello che lo ha sempre affascinato: la tematica della metamorfosi. Questo Stereo non è da meno, essendo il prologo ideale al Demone sotto la pelle e a Scanners.
Quello che scorre davanti agli occhi dello spettatore vorrebbe sembrare la testimonianza di un esperimento scientifico. In realtà è solo una pallida illusione e una falsa certezza a lui regalata, in quanto ciò che vediamo non sono che immagini in movimento e senza audio. Gli attori svolgono delle azioni e il compito di darvi un significato è affidato a una voce narrante e impersonale, che testimonia intenzioni e risultati di una scienza che vorrebbe penetrare e spiegare la psiche. Ovvero un cervello umano che vuole comprendere se stesso come se potesse osservarsi dall’esterno.
L’inganno è duplice. Perché l’aura scientifica vorrebbe fornire una rassicurazione allo spettatore: la mente e l’amore attraverso la metafora paranormale sono spiegabili ed oggettivi. Ma il fatto che in realtà lo spettatore non sappia niente di quello che è successo davvero, perché non ne ha prove dirette né audio né men che meno video (con una messinscena tecnica eccellentemente fasulla) riconsegna a questi due aspetti le chiavi del mistero di cui sono i legittimi proprietari.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
39 - The cameraman's revenge
Questo corto narra la storia di un fotografo che, maltrattato da una personalità importante, decide di riprenderlo mentre tradisce la moglie e di proiettare queste immagine in un cinema dove è presente la stessa moglie. Dove sta l’interesse in una storiella come questa, raccontata per di più con la bambinesca ingenuità adatta a un pubblico di infanti? Nel fatto che i protagonisti del corto sono il signor Cavalletta, la signora e il signor Scarafaggio.
L’intuizione che sta alla base di questo piccolo show per bambini di Starewicz è di quelle che scardina il mondo. Già in questa opera, e ancora più in altre seguenti, si nota come l’entomologo polacco riesca a dare una grande fluidità dei movimenti ai suoi insetti. La messa in scena è riuscitissima fin dai primi secondi, e il suo umorismo è in grado di contagiare anche uno smaliziato spettatore del XXI secolo.
Più che in altre opere di Starewicz c’è anche da rivelare una sottile consapevolezza del mezzo cinematografico, che oltre ad essere usato come mai prima di quel momento, al pari di Melies, in questo caso diventa anche oggetto interno alla narrazione. Un oggetto che svolge un ruolo centrale nella storia, una piccola geniale scintilla di intuizione di quanto sia rivoluzionario l’insignificante pupazzetto che nel 1912 l’autore stava tenendo tra le mani.
| Voto (5/5): |  |
40 - King kong
Glissando senza troppi problemi sui vari remake che si sono susseguiti negli anni, questo film del 1933 se viene raffrontato al suo remake ad opera di Peter Jackson diventa un esempio paradigmatico dello scambio dei ruoli tra le tecniche della stop motion e della computer grafica. Entrambi i film sono infatti dei grandiosi kolossal ed entrambi i film puntano su una spettacolarizzazione dell’effetto speciale come mai visto prima.
Se lo si guarda con un occhio appena attento, il King Kong del ’33 rappresenta un approccio tecnico assai barocco per quanto riguarda gli effetti speciali. Gorilla e lucertolone infatti vengono animati e sistemati su multipli schermi di trasparenza rendendo l’azione molto teatrale (anche se viene percepita un po’ distaccata dallo spettatore). In una scena si nota che probabilmente sono stati usati più schermi di trasparenza contemporaneamente (si ricorda che uno schermo di trasparenza consiste nel riprendere prima lo sfondo e poi proiettarlo alle spalle dei personaggi su un enorme telo bianco).
Questo uso e abuso dell’effetto è ripreso completamente nel grandioso King Kong di Jackson, ma è sostituito con la stop motion del presente, in un insolito e personalissimo parallelismo.
| Voto (4/5): |  |
41 - Giasone e gli Argonauti
Con la collaborazione a questo film si può dire che Harryhausen, uno dei luminari dell’arte della stop motion, raggiunge una delle sue vette tecniche. Eppure non riesco a celare una certa insoddisfazione per la resa visiva della sua opera, più a demerito della regia che suo.
Tutte le animazioni sono realizzate infatti in maniera magistrale, a partire dal gigante di bronzo. Tuttavia il modo in cui sono messe in scena lascia piuttosto indifferenti. C’è un netto distacco tra l’azione ripresa da Don Chaffey e quella creata da Harryhausen: l’impressione che gli Argonauti continuino a dare ripetutamente dei fendenti in aria è troppo evidente.
Da cosa deriva tutto questo? Dal fatto che in questo e in molti altri casi simili, la stop motion non è la ponderata conseguenza di una cifra stilistica, ma si riduce a mero effetto speciale, scelto praticamente per forza. Non c’era altro modo per far interagire gli eroi con un esercito di scheletri e quindi ci si è “accontentati”. Non si possono raffrontare quindi questi mucchietti d’ossa con quelli sboccati e geniali de L’armata delle tenebre, realizzati forse tecnicamente peggio, ma almeno con un’anima e uno scopo.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
42 - L'impero colpisce ancora
Al pari di 2001: Odissea nello spazio, la trilogia di Star Wars ha rappresentato un nuovo punto di non ritorno per quello che riguarda gli effetti speciali. A partire dal 1977 fare fantascienza, o qualsiasi altra pellicola che richiedesse un certo impianto scenografico, non sarebbe più stata la stessa cosa.
Verrebbe da pensare che la rivoluzione operata da Lucas sia una totale rottura col passato, e che le operazioni della neonata Industrial Lights & Magic stabilissero un indiscusso primato delle nuove tecnologie digitali sulla tradizione analogica in cui aveva vissuto il cinema. Questa supposizione si sarebbe rivelata veritiera con il passare degli anni, ma il merito di Lucas è stato quello (raramente poi ripetuto) di riuscire a fondere in un amalgama di rara magia la computer grafica con la stop motion.
Nel film in questione, per fare un esempio, l’attacco iniziale degli enormi mammut tecnologici è realizzato proprio con il nostro mammut tecnologico della stop motion. E in questo caso il lento e irregolare avanzare iper-definito, causato dagli effetti collaterali di questa tecnica, veste magistralmente lo stile che viene regalato all’impero del male, molto più di quanto possa mai fare un pugno di bit luminosi.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
43 - Faust
Con Svankmajer si giunge a una fase in cui la tecnica della stop motion è definitivamente declassata a effetto di serie B per quanto riguarda le produzioni mainstream ed è quindi diventata una firma da apporre alle proprie opere d’autore. Il filmmaker ceco ci offre con il suo Faust una personalissima interpretazione di questo modo di concepire il cinema.
La sua opera infatti è quasi per intero ambientata all’interno di un teatro, in cui al Faust in carne, ossa e cerume del trucco di scena, si affiancano scenografie di cartone e marionette a grandezza d’uomo. Il parallelismo tra uomo e marionetta è più che evidente, ma anche angeli e demoni di creta sono dei semplici pedoni su una scacchiera in cui sono ammessi solo due giocatori: la malizia divina/demoniaca e la follia.
Fondamentale è infatti l’esilarante figura del buffone, che è l’unico essere in grado di farsi davvero beffe del demonio dall’interno del suo circolo di sicurezza. E tali marionette, così come le creazioni di Faust, prendono vita con la magia della stop motion, in grado di dare una forma vera e concreta alla smania di creazione che pervade l’animo dell’uomo-Faust.
| Voto (4/5): |  |
44 - La sposa cadavere
La sposa cadavere è un film che chiude, in maniera triste e desolante, il ciclo che ha portato ai giorni nostri la stop motion come tecnica affascinante e portatrice di una bellezza elitaria e particolare. Complessivamente il film non è da buttare, basti anche solo citare il comparto musicale curato da Elfman e la perizia alla regia di Burton. Ma con Victor e Victoria nella fossa della sposa si va a depositare tutta la magia di un regista che poteva essere considerato uno dei maestri di questa tecnica.
La realizzazione visiva è infatti disarmante. Si arriva a definire un intimo intrecciarsi tra la computer grafica e l’animazione a passo uno con delle modalità diametralmente opposte da quelle attuate da Lucas per Star wars. In questo caso infatti la pulizia dell’elettronica spoglia completamente da tutta la magia i protagonisti, in cui è evidente la mancanza di anima in fondo ai loro occhi.
Un uso così sconsiderato inquina quella che dovrebbe essere l’anima del cinema in stop motion e non può che lasciare insoddisfatti. E getta dei pesanti dubbi sulla speranza di vedere nuovamente questa tecnica usata con maestria in un prodotto che possa beneficiare di un pubblico più vasto di quello necessariamente di nicchia di uno Svankmajer.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
45 - Rottweiler
Rottweiler è solo l’ennesimo esempio delle scempiaggini spagnole che Yuzna ha compiuto quando si è posto dietro la macchina da presa. Ed è una metafora esemplare del suo lavoro: vorrebbe essere un mastino dai denti d’acciaio, ma finisce per essere un cucciolotto fantasma che si affida a una computer grafica talmente finta da non poter ingannare sulla sua concretezza nemmeno per un secondo.
Se infatti il buon Brian da produttore è sempre riuscito a caratterizzare in maniera pregevole i lavori a cui si è dedicato, da regista ha solo dimostrato di non avere le idee chiare. La sua parentesi spagnola poi rappresenta un disastro dopo l’altro, con pellicole che oscillano tra l’appena sufficiente al totalmente disastroso.
Rottweiler vorrebbe essere un Cujo futuristico, ma ha due difetti. Da un lato è tecnicamente realizzato in maniera approssimativa: lo scheletro del rottweiler è composto da una computer grafica talmente brutta che non ci si crede. Dall’altro la sceneggiatura non lascia molto spazio alla logica: le azioni dei personaggi (messi in scena con costumi e scenografie approssimative) sono quasi sempre insensate e non raggiungono mai un vero climax emozionale.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
46 - Amores perros
Iñarritu è il regista-cane per eccellenza. Come per il film di Lynch recensito qualche settimana fa anche in questo caso sono alle prese con l’opera prima di un futuro cialtrone che contiene i germi della sua follia cinematografica amalgamati ancora con qualche buona idea. Proprio perché alle prese con il suo esordio, Iñarritu non si lascia cullare dalle sue manie di “terzomondista che ce l’ha fatta”. E’ il solito vizio di un cane randagio, che viene dalla fame e dalla strada e quando qualcuno si prende cura di lui ingrassa con una boria compiacente che ne uccide la fantasia e lo stile, unici responsabili del suo successo (un po’ come i calciatori brasiliani che escono dalle favelas).
Il nostro Fido di Mexico city in questo caso scodinzola meno forte che in altre occasioni alla pappa che Arriaga gli propone. Ma ci sono due modi di digerire il cibo di questo talentuoso sceneggiatore. C’è l’ingozzarsi senza ritegno di Iñarritu e poi c’è lo spiluccare sapiente che mette all’opera Tommy Lee Jones con Le tre sepolture. I risultati, di una portata radicalmente opposta, sono sotto gli occhi di tutti.
Gli amori e i cani in questo caso salvano il film. La messa in scena è sporca e sanguinosa, ben adatta alla quotidianità violenta delle strade. E anche quando ci si sposta in appartamenti lussuosi c’è una totale distruzione delle radici su cui si basa questo lusso in cerca del vuoto su cui esso si basa. Il vuoto alla base del lusso che copre con un manto impenetrabile la piccola fiammella di umanità che rimane nei nostri cuori. E che viene gettata in pasto ai mostri che il lusso stesso calpesta senza fare distinzioni e prigionieri.
| Voto (3/5): |  |
47 - Resident evil
Mr. Paul W. S. Anderson è un regista cane. Sì, perché nessuno può mai, a meno che non sia vittima di un’ubriachezza molesta, sostenere che codesto cialtrone abbia un minimo di gusto estetico. O anche solo, basterebbe, un po’ di senso della misura. Tutta la sua produzione si snoda lungo i binari del grottescamente pacchiano ed esagerato, del barocco fine a sé stesso, e a volte pure realizzato piuttosto male. Eppure…
Eppure il più bistrattato e certamente il meno talentoso degli Anderson registi non si può non amare. Le sue pacchianate sono, ammettiamolo, tutto quello che avremmo voluto realizzare noi da bambini. Chi, mi chiedo, non ha immaginato esattamente così il film di Mortal Kombat sognando di dirigerlo? Per Resident Evil vale lo stesso discorso: l’attinenza con le atmosfere videoludiche è effettivamente poca, ma il risultato è un solido intrattenimento.
I cani hanno poco spazio, è vero, anche se il mostro finale (assolutamente senza senso, grazie Anderson!) è di fatto un grosso “peggior amico dell’uomo”.Ma a ben vedere questo film ha tutto quello che deve avere: sangue, orde di zombie in spazi ristretti, one-line pungenti, qualche scena visivamente pacchiana ma interessante, hot chick e una Rodriguez più testosteronica che mai.
| Voto (3/5): |  |
48 - Una bionda in carriera
Non è che io ce l’abbia particolarmente col regista di questo film definendolo “cane”. Anche perché non l’ho mai sentito nominare prima e credo, controllando i suoi lavori su IMDb, che nemmeno sia in grado di arrivarci, al titolo di “cane”. La scelta del film ricade invece sul suo pretesto narrativo che fa da sfondo alla vicenda.
Sequel di La rivincita delle bionde, questo film vede messo “alla berlina” il mondo delle aziende “senza scrupoli”. Comandante della crociata è la determinatissima avvocatessa interpretata dalla Witherspoon (che mi sta talmente simpatica da spingermi a voler decorare l’ingresso della magione di FiveObstructions con la sua testa infilzata su di un palo). Tali aziende sono ree di utilizzare come cavie dei poveri animaletti innocenti, tra cui un simpaticissimo chihuahua (al quale personalmente io farei di molto peggio, in fondo per decorare bene l’entrata della redazione ne servono due di pali: ci tengo alla simmetria!).
Una bionda in carriera rappresenta quell’odiosa corrente Mtv-new age dotata di un terribile e insopportabile buonismo di fondo. E’ la riproposizione pedissequa e arrogante di slogan nati già vecchi da più di trent’anni, il cui unico scopo è di far sembrare impegnati. Perché se non sei impegnato, cioè, sei troppo out. Però non impegniamoci troppo sul serio, che magari passa di moda.
| Voto (1/5): |  |
49 - R-Point
Una squadra di soldati della Corea del Sud di stanza nella guerra del Vietnam viene mandata in missione nel famigerato Romeo Point. Tale R-Point pare una casa un po’ scassata come quella di Non aprite quella porta (e che cosa ci faccia Leatherface in Vietnam non è dato sapere). Lo scopo è fare luce su che fine ha fatto la vecchia squadra, massacrata settimane prima, ma che ancora dà segnali di “vita”.
Purtroppo per parlare di cosa non va in questo ennesimo deludente horror coreano dovrò fare degli spoiler, quindi siete avvertiti. La minaccia sconosciuta che si trovano ad affrontare è infatti un non meglio identificato spirito che, impossessandosi dei soldati a piacimento, li trasforma in macchine per uccidere. E’ fin troppo evidente, spiattellata e pacchiana la morale del film. Uno sciocco parallelismo dello spirito militare che penetra nel corpo e nelle menti di giovani “innocenti” e li trasforma in macchine senza testa e fratricide.
Anche perché se la messinscena introduttiva non è granché (ma ste bimbe cinesi coi capelli lunghi stanno pure nel Vietnam?) non è che lo scioglimento finale sia indimenticabile. Un po’ di tensione la può anche regalare, ma l’escamotage del soldato sopravvissuto che comanda i compagni in modo da intrappolare lo spiritello è qualcosa che difficilmente si salva dal comico involontario.
| Voto (2/5): |  |
50 - Allucinazione perversa
La scala di Jacob che dà il nome al film è un vero e proprio tragitto che porta all’inferno. E se il punto di partenza è il Vietnam, l’inferno verde per eccellenza, quale potrà mai essere il punto di arrivo?
Durante la discesa Jacob si vede affiancato da altri soldati come lui, che con un fucile in mano erano leoni assetati di sangue, ma senza cosa si ritrovano ad essere? Dei bambini dispersi in un mondo che non capiscono e in cui vengono presi a pesci in faccia anche da un piccolo avvocato. E non c’è nessun posto in cui chi è stato macchiato dalla maledizione del suo passato può trovare scampo: non a una festa orgiastica di demoni, non nella propria casa che lo fa bruciare dal di dentro. A tal proposito è caldamente consigliata la director’s cut, uno dei pochi casi in cui tale versione è imprescindibile.
Allucinazione perversa è un vero cult spesso dimenticato al pari di Ascensore per l’inferno, che però supera in quanto ad atmosfere e sapienza nel costruire la paura. Sono entrambi esempi magistrali di un modo di creare la tensione che oggi esiste solo in rari casi di nicchia. E contemporaneamente riescono ad evitare quel rivoltante sapore “nineties” che visto al giorno d’oggi sa veramente di invecchiato terribilmente male.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
51 - Dog soldiers
Un gruppo di soldati viene mandato in pasto come carne da macello durante un’esercitazione ai corpi speciali. Il problema avviene quando ci si rende conto che nella foresta scozzese teatro dell’operazione i corpi speciali sono ben diversi da un gruppo di tizi incappucciati. La vera minaccia infatti è rappresentata da una squadra di… licantropi.
Che Marshall non si voglia prendere troppo sul serio è chiaro fin dall’inizio, con un comandante estremamente stereotipato nel suo ruolo di “soldato cattivo”. L’ironia è la chiave di lettura del film. I corpi speciali vengono infatti sbaragliati come delle mammolette e i soldati, che tanto si dilettano in storie compiacenti sull’orrore della guerra, vengono salvati da una casetta che somiglia tanto a quella dei tre orsi di una favola dei fratelli Grimm. E anche quando lo scontro arriva alle sue battute finali non è più la ferrea disciplina a farla da padrone, ma una reazione isterica e umana di attaccamento alla vita, che spoglia di tutti gli inutili strati dell’addestramento (e allora si dia il via alle padellate! Sublime!).
Intelligente anche l’uso dell’effetto speciale. I licantropi sono probabilmente i più brutti mai realizzati nella storia del cinema, e proprio per questo la loro minaccia è qualcosa di terribile e irreale. Marshall infatti li mostra col contagocce, per evitare di farsi ridere in faccia, rendendo le loro apparizioni inquietanti quando le soggettive de La casa 2 di Raimi. Segno che “mancanza di mezzi, abbondanza di idee” batte sempre e comunque il suo contrario. (Geniale il contro-finale sui titoli di coda, non perdetevelo!).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
52 - Homecoming
E’ incredibile come un regista non propriamente raffinato come Joe Dante sia riuscito a mettere in piedi un gioco di specchi deformanti così arguto in appena 50 minuti. Nel suo Homecoming infatti c’è un primo ribaltamento di ruoli tra il soldato e la minaccia horror: questi due aspetti si trovano a coesistere nella stessa entità di militari zombi, in cerca di vendetta fuori dalle loro tombe decorate. Ma c’è un secondo twist: questi zombi non sono affatto dei mostri assetati di sangue, essi vogliono solo avere ciò che non hanno potuto ottenere prima della loro morte: una voce in capitolo nelle decisioni che riguarda la loro vita. E i veri mostri divengono gli inceronati burocrati sepolti nelle loro bare a forma di studio televisivo.
Questa rilettura dello zombie è qualcosa che francamente riesce a far impallidire perfino Romero, il maestro e inventore del genere (con La notte dei morti viventi). E’ di sicuro la più fresca e frizzante interpretazione del genere, più di quella di Danny Boyle in 28 giorni dopo, e l’esempio più anarchico all’interno della serie dei Masters of Horror.
Quello che impressiona degli zombi di Dante è tutto ciò che circola attorno alla loro creazione in quello che alla fine non è altro che un mediometraggio. La marcia verso Washington, carica di significati. O l’umanità che riescono a trasmettere allo spettatore, pur partendo dalla loro forma disumana. L’ironia e anche il dramma di vedere che cosa sono diventati. E la rabbia. Tanta rabbia rivolta verso coloro che sono i responsabili di tutto (e, fortunatamente, senza ingenuità o soluzioni pacchiane).
| Voto (5/5): |  |
53 - Serenity
Il primo (e per ora unico) lungometraggio di Joss Whedon rappresenta la frontiera più avanzata e affascinante della fantascienza del XXI secolo. Inserendo i propri personaggi in un western affatto tecnologico, fatto di rapine in banca e risse nei saloon, riesce a creare un mondo convincente e incredibilmente attuale. Si può ben dire che facendo la media tra l’ambientazione futuristica e gli stilemi western il risultato sia una splendida storia attuale.
Protagonisti della vicenda sono dei simpatici briganti capitanati dallo straordinario Malcom Reynolds (interpretato da un Nathan Fillion in stato di grazia). Questo manipolo di burberi ma buoni anti-eroi è inserito in una enorme gradazione di grigi che caratterizza le azioni di tutti gli attori della vicenda. E’ impossibile stabilire davvero una gerarchia tra “buoni” e “cattivi” perché tutti a modo loro perseguono ciò che ritengono più giusto e non è facile capire dove questo “giusto” davvero si collochi. Il “cattivo” sceriffo infatti mantiene per tutta la pellicola un comportamento esemplare per il suo ruolo di rappresentante della giustizia, convinto dei propri ideali.
E, soprattutto, i briganti, le prostitute, i piloti e i capitani di stanza sulla scassata navicella Serenity sono personaggi veri, con pregi ma soprattutto difetti e necessità di personaggi veri. Sono datati e rimasti legati a un vecchio mondo fatto di alcool e cavalcate come i loro dirimpettai del Mucchio selvaggio. Ben lontani dai damerini e le maschere piatte di Star Wars e Star Trek, immersi in una finzione palese, che ha funzionato molto bene fino agli anni ’80, ma ormai oggi sterile e fastidiosa.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
54 - Sukiyaki western Django
Se il western parte da Kurosawa, si può dire che il suo punto di arrivo attuale sia Miike. Il folle regista giapponese ha deciso con questo film di invertire la direzione classica di questo genere e di portare pistoleri e bovari nel medioevo Giapponese. Ovviamente il giocoso caleidoscopio di citazioni non si ferma qui, in quanto la trama di Sukiyaki lo rende praticamente un remake di La sfida del samurai e Per un pugno di dollari.
D’altronde il sukiyaki di cui è ghiotto il Ringo interpretato da Tarantino (una parte molto più sfaccettata e importante di un semplice cameo) non sono altro che l’equivalente giapponese degli spaghetti di Sergio Leone. Purtroppo a Miike gli alti budget fanno male, ed è veramente brutto affiancargli il nome di uno dei massimi esponenti cinematografici, in questo caso. Perché le atmosfere barocche e iper-saturate di questo film richiamano più gli eccessi e i difetti dell’Hero di Yimou, e anche il livello di intrattenimento non riesce a garantire una piena soddisfazione allo spettatore.
E’ invece ben più riuscito come prequel dell’eccessivo e non del tutto soddisfacente Django targato Corbucci/Deodato, con il quale condivide una certa perplessità sulla morale del film. Non ci si meravigli se questo paragrafo è zeppo di rimandi e citazioni: è proprio nelle intenzioni di Miike realizzare questo pasticcio postmoderno. La presenza di Tarantino e l’amicizia con l’Eli Roth di Hostel infatti non sono avvenimenti che passano senza causare degli effetti.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
55 - Cemento armato
Cemento armato non è altro che La notte prima degli esami versione western (o noir, se Martani ne fosse stato capace). A parità di cast e quasi di regia (regista e sceneggiatore si sono infatti scambiati di ruolo) Cemento armato trasla il suo genere da commedia a poliziesco serioso. Il cattivone Faletti non è altro che una versione moderna, cementata appunto, del classico latifondista del vecchio west, che guardando la vallata ha il solo desiderio di impossessarsi di tutti quei piccoli ranch condotti con tanto amore dalle piccole famiglie.
Il film pecca clamorosamente sul gradino del ridicolo involontario. Sia perché prende come suo cowboy Vaporidis, che dovrebbe rivestire i panni dell’eroe bello e dannato ma con la sua facciotta pulita conferisce a tutte le sue azioni un’aria di assoluto nonsense (esempio: per far vedere quanto è ribelle il nostro Nicolas passa in un ingorgo sul raccordo anulare col suo motorino e decide di… spaccare gli specchietti delle auto in sosta a pedate! Tu sì che sei un ribelle vero, si vede che ti chiamano Er Teribbile). Sia perché la sceneggiatura è qualcosa di mostruoso.
Si nota infatti un’enorme forzatura per dare a dialoghi e azioni prive di fascino un tono solenne, tipico dello spaghetti western alla Leone. Purtroppo non bastano un paio di citazioni dal vecchio west. Non bastano le frasi da duro in bocca a Faletti (“Questa volta ha rotto lo specchietto sbagliato!”, uhhh che paura). Non bastano i cliché dello stupro della donna del buono (tra l’altro realizzata con uno dei buchi di sceneggiatura più catastrofici del cinema: la maggior parte delle vicende accade completamente per caso). Non basta la memoria infamante di un padre e un eroico duello finale. Gli attori e la storia di Cemento armato non smettono mai di essere quello che sono: una congrega di burini che si rigano la macchina per un parcheggio rubato sulla Tiburtina.
| Voto (1/5): |  |
56 - Cowboy bebop
Il film tratto dall’omonima serie vede il cacciatore di taglie Spike braccare un pericoloso terrorista, aiutato da un gruppo di amici che quasi mai riesce a rimanere assieme per più di poche scene. Se andiamo ad analizzare il lungometraggio ci si rende conto di quanto sia pesante il fardello dell’ottima serie da cui è tratto.
La storia del nostro bounty killer è infatti appassionante e farcita di evocative cavalcate a bordo di futuristici cavalli tra lune e grattacieli hi-tech, duelli all’ultimo sangue (e oltre), enigmi filosofici, vendette da soldato abbandonato (un classico da guerra di secessione!) e cacce all’uomo. Eppure si resta comunque con l’amaro in bocca. Senza nemmeno averne chiaro il motivo: l’azione quando viene messa in campo è appagante e carica di adrenalina, mentre pause e dialoghi sono arguti e stimolanti.
La spiegazione è abbastanza semplice. Spesso quando si fa un adattamento cinematografico di una serie si cade facilmente nel tranello della semplice realizzazione di un episodio di due ore. Questo è tristemente vero per Cowboy Bebop. E il problema è che questo episodio lungo non è nemmeno particolarmente interessante nell’ottica della serie. Se fosse stato inserito nei 26 episodi regolari non sarebbe stato altro che un filler, un riempitivo. Ovvero in pratica i personaggi sono costantemente immersi in qualcosa che sembrano reputare normale, di routine, una normale cavalcata nelle lande del west, e questo non riesce ad emozionare lo spettatore, a farlo stare in ansia per la loro sorte, a intrattenerlo.
| Voto (3/5): |  |
57 - Moscow Zero
La schiera di recensioni negative che accompagnano questo film me lo ha reso ancora più gradevole. Questa storia di discesa progressiva nei cunicoli e nei sotterranei di Mosca, a patto di riuscire a passare sopra a quei due o tre difetti con un po’ di sospensione dell’incredulità, è in grado di regalare emozioni forti e coinvolgenti. Tali difetti sono una resa degli effetti speciali veramente povera (penso agli scheletri umani palesemente di gomma e ad altro) e alcune banalità pacchiane e totalmente gratuite comprese nella sceneggiatura (il bacio tra il prete e la guida).
Ma i pregi li sovrastano nettamente. La fotografia, che vira su colorazioni molto accese e riprende le scelte scenografiche ultra claustrofobiche di The descent, è straordinariamente efficace nel comunicare paura e angoscia. E’ un cinema della tensione più che dello spavento, con poco sangue mostrato e molto suggerito. La ricerca del proprio mentore da parte di un sempre grandioso Vincent Gallo è qualcosa che mette prima di tutti in gioco noi stessi. Perché quando si decide di schierarsi, di voler bene a qualcuno o di prendere semplicemente posizione bisogna essere consapevoli che la nostra scelta non è mai indolore. E’ prendersi un rischio e accettarlo che concede dignità alle nostre azioni. Anche quando il prezzo è fronteggiare l’ingresso dell’inferno.
Film del 2006 è, a quanto pare, in uscita in Italia anche se non ho trovato notizie più precise. Non lasciatevi ingannare dal nome di Val Kilmer posto per primo nei credits: la sua presenza è più simile a un cameo che a un vero ruolo attivo.
| Voto (3/5): |  |
58 - Stalker
Stalker è un’opera come se ne vedono poche in giro. E’ un’opera esigente, richiede l’impegno e il mettersi in gioco dello spettatore, esattamente come la guida che è in grado di prendere i personaggi/spettatori per mano e di trasportarli dentro una Zona misteriosa, dentro il proprio animo. La promessa è quella di uno sconosciuto qualcosa in grado di esaudire i desideri più reconditi che abbiamo.
La guida chiede molto in termini di attenzione ed obbedienza. I personaggi, talmente svestiti delle proprie peculiarità da diventare vere e proprie maschere che rappresentano filosofie di vita, devono ubbidire a questo stalker. Così come lo spettatore è piegato a uno spettacolo di estenuante bellezza, una natura poetica che dilaga per tutte le tre ore di durata del viaggio dentro all’Uomo. E ci suggerisce che è stupido desiderare che basti un qualcosa che metta a posto la nostra vita con un tocco. La felicità facile non esiste, c’è solo da rimboccarsi le maniche. Anche perché non siamo sicuri di ciò che è nascosto nelle pieghe del nostro animo: potrebbe esserci qualcosa che non ci piace.
Se si presta un po’ di attenzione a ciò che viene detto si capirà che questa recensione non è altro che un riassunto del film, un vademecum troppo sintetico (in entrambi i sensi: breve e di materiale artificioso e inerte) a quella che chiamo una “guida dell’Anima”. Perché il cinema di Tarkovskij è così: non c’è niente da capire realmente, c’è soltanto molto da vedere. Ma le risposte sono tutte lì. Si arrabbiava Tarkovskij quando gli chiedevano cosa rappresentasse la Zona: la Zona non rappresenta niente, è.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
59 - The tracker
La ricerca che anima i personaggi del film di Rolf de Heer è una ricerca di giustizia. C’è un aborigeno fuggiasco, reo di aver ucciso una donna bianca. Ma la ricerca della giustizia bianca non può vivere senza una guida aborigena del luogo, senza la quale il manipolo di giustizieri non saprebbe muovere un passo. Come nello Stalker di Tarkovskij anche in questo caso non c’è bisogno di nomi per i personaggi: essi sono maschere che rappresentano un modo diverso di concepire vita e giustizia.
La guida non è affatto uno sfondo, un qualcosa di necessario ma invisibile e a sua volta insensibile. E’ il perno su cui ruota la vicenda con la sua scaltrezza e sottomissione, il suo sopportarne sornione ciò che gli si para davanti. Sia essa l’ingenuità tipica di chi è appena entrato nel mondo e non sa come funziona e pensa di poter risolvere i problemi in maniera oggettiva. O sia anzi la ferocia razzista del genocidio degli aborigeni, rappresentato non mediante azioni recitate ma con affascinanti dipinti che ne raffigurano i momenti più atroci.
”Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere” diceva Wittgenstein. E capire quando non si può capire (e quindi agire secondo la nostra nozione di giustizia) non è segno di debolezza. Imporre dall’alto una presunta (e presuntuosa) giustizia oggettiva è sciocco. Si rischia solo di creare frustrazione e odio anche in chi ti trasporta al sicuro in mezzo al deserto australiano, dove da solo non dureresti un metro.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
60 - Control
Fate un esperimento. Prendete uno qualsiasi dei fotogrammi che compongono questo film. Uno a caso, anche il più insignificante. Passatelo a un amico un po’ appassionato di rock senza dirgli da dove viene quella foto e chiedetegli: “Che gruppo musicale ti fa venire in mente?”. Io ho fatto un paio di prove. E la risposta è sempre stata la stessa. “I Joy Division”.
D’altronde dietro alla macchina da presa di questo Control non c’è una persona qualunque. C’è il grande Anton Corbijn il genio visivo che sta dietro alle produzioni più fortunate di un gruppo semisconosciuto come i Depeche Mode. Il fatto è che questo film sprizza da ogni poro lo spirito che ha contraddistinto in ogni singola nota la troppo breve storia di un’icona come l’anima dei Joy Division. Se Ian Curtis fosse stato fatto di celluloide, sarebbe Control.
Tutto in questa durata limitata urla “Joy Division”. Un bianco e nero usato come se fosse un colore psichedelico estratto direttamente a forza dal 1976, i tempi dilatati alternati alle scene dei concerti che sono un crescendo sempre più disperato verso le crisi epilettiche, gli episodi chiave di una vita che è già leggenda. E’ un film realizzato talmente bene da portarti davvero a pensare che mai nessuno potrà più essere così: Interpol o Editors potranno essere tecnicamente più bravi od orecchiabili, ma nessuno sembra poter essere in grado di sprigionare il fuoco sacro che da Curtis è sceso nelle mani e negli occhi di Anton Corbijn.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
61 - Ray
Perchè guardare Ray? Francamente non mi viene in mente nessun motivo. Il film interpretato da Jamie Foxx infatti si può riassumere con poche, spersonalizzanti, parole. “La vita di Ray Charles dagli inizi nei bar fino alla sua morte. In mezzo i successi”. Capirete anche voi che è un po’ troppo poco. Non c’è in questo film assolutamente nulla in più che potete trovare aprendo una sua biografia.
Il fatto è che il film manca nell’abc basilare della creazione del pathos. E’ un accavvallarsi di “cose che succedono” senza che queste “cose” siano sottolineate né con uno spirito stilistico affine alle opere di Ray Charles né con una qualsiasi altra trovata di regia, fotografia o sceneggiatura. C’è un certo tentativo, un abbozzo nei flashback dell’infanzia di Ray, ma è francamente troppo poco. Gli eventi scorrono sullo schermo e non si riesce a provare empatia, partecipazione.
Si ha in pratica la fastidiosa impressione che la personalità di cui si dovrebbe ammirare il ritratto sia lì per caso. Che questo ritratto non abbia alcuna pennellata o intuizione artistica, ma sia una fototessera. Tutto è troppo impersonale, oggettivo. E allora, francamente, per capire meglio chi è Ray Charles preferisco farmi un’idea ascoltando la sua musica.
| Voto (2/5): |  |
62 - Last Days
La vita di un’icona degli anni ’90 come Kurt Cobain ritratta da un’icona vivente del cinema del ventunesimo secolo. Ogni opera di Gus Van Sant invoglia a leccarsi i baffi, ma in questo caso se ne hanno veramente tutte le ragioni del mondo.
Il regista di film come Gerry e Will Hunting riesce infatti a trovare la chiave di lettura giusta di quello che è essenzialmente un film grunge. Il disordine mentale, il corpo e la vita trasandate, annebbiate, offuscate sono messi in scena in maniera altrettanto magistralmente confusa e contundente. Per fare un esempio dell’annebbiamento visivo a cui è sottoposto lo spettatore basti pensare ai dialoghi surreali e apparentemente non sense, che svicolano volontariamente da quello che lo spettatore bramerebbe come snodo del film. O i pensieri sussurrati senza un filo logico di Kurt. O ancora il viso del protagonista, che è costantemente celato a chi gli si para davanti, e si mostra in tutta la sua pienezza solo quando l’idea del suicidio finalmente viene alla luce.
A Van Sant non interessa “analizzare” una mente ma sintetizzarla, esprimere con poche forti immagini i suoi pensieri. Ed ecco che nella scena in cui Cobain guarda la televisione si manifesta uno dei tanti chiodi che si sono infilzati nella sua bara: dei finti-rapper neri al guinzaglio dei media, un simbolo della rabbia contro le convenzioni che viene addomesticato, masticato e sputato a forma di conformistico Backstreet Boy.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
63 - Velvet Goldmine
So bene che Velvet Goldmine non è espressamente la biografia di David Bowie o, addirittura, di Iggy Pop. Eppure non sono riuscito a trattenermi dal forzare le regole della variazione per includerlo. Perchè questo è un puro glam-film, eccessivo fino al midollo, ma d’altronde come dice sempre una mia amica “Se non è eccessivo allora non è glam”. Questo è effettivamente qualcosa che mette in difficoltà il mio gusto personale, ma visto dall’esterno non si può che dare atto a regia e tutto il comparto tecnico di aver svolto il più eccellente dei lavori.
Tutto è infatti dove deve essere. Scenografie, sceneggiature ammiccanti all’estetismo di Oscar Wilde, interpretazioni (sublime Rhys Thomas, ma lo è altrettanto Bale in un ruolo difficilissimo che rischia di passare inosservato in mezzo a tutti quei lustrini), colonna sonora. A tal proposito invito a scoprire il gruppo dei Venus in furs: dietro la citazione ai Velvet Underground stanno nomi giganteschi come Radiohead, Suede e altri.
A questo punto mi chiedo: è davvero necessario che il protagonista del film non si chiami David Bowie? O che non siano rappresentati dei momenti chiave della sua esistenza? Francamente ritengo di no. In fondo la domanda che mi spinge a rispondere in questa maniera è: che senso ha lamentarsi se un ritratto non somiglia al tuo corpo quando somiglia alla tua anima?
| Voto (4/5): |  |
64 - Piano, solo
Piano solo traduce nei problemi del cinema italiano gli stessi difetti che animano la produzione di
Ray, il film sulla vita di Ray Charles. Come nel film americano, infatti, quello che viene presentato rasenta tutti i difetti di una cinematografia senza idee. Se Ray è spersonalizzante, Piano solo non riesce nemmeno per un attimo a scrollarsi di dosso l’identità da “film italiano”.
Come in molte produzioni di fiction italiane riguardanti “personaggi celebri”, infatti, si assiste a una messa in scena stereotipata degli eventi. In altre parole quello che si vede è la classica storia di “amore” o “sentimenti forti” che viene narrata in ben più della metà delle produzioni nostrane. Il fatto che i personaggi si chiamino Luca Flores piuttosto che Garibaldi cambia leggermente le scenografie e due o tre fatti biografici di controno, ma il nodo della vicenda, quello che interessa allo spettatore, è sempre rappresentato dalle solite due o tre banalità.
Non c’è nulla di Flores in questo film insomma, a parte nome e cognome, problemi mentali e suicidio. E tutto questo nonostante un’interpretazione anche abbastanza convincente da parte di Kim Rossi Stuart. Ci sono invece le storie d’amore tormentate, i pianti nelle stanze, i drammoni pubblici, i Traumi. Ma francamente non credo che Flores si meritasse un racconto della sua vita made by Ozpetek à la Un giorno perfetto.
| Voto (2/5): |  |
65 - Natale in crociera
Sequel remake di un’interminabile (e, per me, quasi indistinguibile) sequela di film, Natale in crociera rappresenta la traduzione con linguaggio contemporaneo dei film di Totò. Esiste verso film di questo genere una certa vena polemica riguardante i modelli che propone. Ma sono più le accuse di squallore tecnico che mi interessano: non si può bocciare un film per partito preso riguardo il suo contenuto, a mio avviso.
E se andiamo a vedere messa in scena e battute servite non si può fare a meno di notare il parallelismo di cui in apertura. Anche Totò infatti era volgare, anche i suoi film riempivano le sale coi famosi ragazzini che imbrogliavano sull’età. E se adesso non ci si trova nulla di male non vuol dire che allora non ci fosse: Totò (ad esempio in Totò, Peppino e i fuorilegge) ha costante fame di cibo, donne, sesso, soldi, successo, esattamente come i protagonisti di questo Natale in crociera. E la traduzione moderna è efficace perché non ci si limita a riproporre il cliché del passato ma lo si rielabora, e allora l’”italiano” di De Sica/Parenti è il vero italiano, coi suoi tic e i suoi pregi, cafone, fatuo e compagnone.
La mia personale bocciatura viene da un’altra parte. Sebbene lo schiavismo da griffe dell’italiano medio sia uno dei tratti su cui è necessario calcare la mano, non si può perdonare a De Sica le terribili sponsorizzazioni sbattute in faccia allo spettatore. Non possono passare come Totò con gli spaghetti in tasca. Non è una questione morale. Ma semplicemente del fatto che ormai sono passati vent’anni e questa serie non può giocare la carta dell’ingenuità e della leggerezza. E’ un panzer del cinema italiano e come tale ha responsabilità che non possono essere eluse. E di questo se ne dimentica troppo spesso.
| Voto (2/5): |  |
66 - The Bourne Identity
Alcuni sanno che la trilogia di Bourne è tratta da una serie di romanzi. Molti non sanno che da questi libri era già stata girata alla fine degli anni ’80 una trilogia, per la televisione tedesca. L’evoluzione di Bourne ad opera di Damon, Doug Liman e, soprattutto, della qualità registica posta da Greengrass nei due seguiti è stata forse l’operazione più importante per il cinema d’azione degli ultimi anni.
Se l’originale infatti viveva all’ombra dei Bond anni ’80, questo remake ha ribaltato i ruoli in maniera netta e irreversibile. E’ stato proprio dopo Bourne infatti che ci si è resi conto di dover abbandonare gadget e pupazzoni alla Brosnan e dare un nuovo inizio a Bond con Casinò Royale. Bourne ha dalla sua il fascino della realtà. I combattimenti sono molto più rapidi e visibilmente dolorosi, le sparatorie si risolvono in pochi colpi ben mirati, gli inseguimenti sono spettacolari ma non vedremo mai Bourne pilotare un carro armato futuristico in centro. Così come il rapporto con la tecnologia è finalmente maturo e funzionale alla storia e non usato al posto della magia.
A livello tecnico è con Bourne che si nota un restringersi della telecamere sempre più addosso ai protagonisti. Si nota un abbandono sempre più ragionato dei sostegni irreali di treppiedi e cavalletti: il cameraman segue l’azione e ce ne fa divenire parte. E’ un punto di non ritorno stilistico che ha dei precursori, ma che si può individuare qui come finalmente meditato e sdoganato all’interno del cinema d’intrattenimento.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
67 - Doomsday
Non si possono elencare qui tutte le citazioni che Doomsday fa a 1997: Fuga da New York. A puro titolo di esempio la protagonista non ha un occhio. Si usano le stesse animazioni in computer grafica. La trama è la medesima (ti butto in mezzo all’inferno e devi riportarmi l’oggetto X in tot tempo). Il protagonista deve affrontare orde di selvaggi. Eccetera, eccetera, eccetera.
Va bene, non è un remake. Ma se a un certo punto del film il personaggio di Rhona Mitra si girasse verso la telecamera dicendo “Chiamami Iena” ci sarebbe davvero qualcosa di cui stupirsi? Non credo. Marshall ha messo in piedi un colossale baraccone solo per amore. Per un amore che si chiama Carpenter. E’ tutto dedicato a lui, dalla prima all’ultima citazione, ed è dedicato a noi, per avere un Fuga da New York di inizio secolo.
Doomsday è puro estratto di anni ’80 rivisitato e messo su pellicola. Troviamo infatti tutti i cliché di cui si sono riempite le pellicole dell’epoca, non ultimo un gruppo di marine protagonisti di cui non si perde tempo a fornire una caratterizzazione in quanto evidente carne da macello fin dal primo minuto. Non c’è infatti nessun reale bisogno di una spalla per la Mitra, che incarna il tipico super eroe invincibile, tutto quello che le accade intorno è puro contorno. Serve per spezzare la monotonia sulle sue acrobazie al volante o in un torneo medievale mentre deve fronteggiare un energumeno in scatola. Si potrebbe pensare a un’operazione vetusta, un passo indietro dagli stilemi espressivi moderni. In realtà con l’estrema modernità che assumono oggi gli anni ’80, Marshall ha dato una sua visione carica di personalità e teste mozzate e infilzate su di un palo. E, se avete buona memoria, la prima cosa ma soprattutto la seconda da queste parti è azione graditissima.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
68 - Miami vice
Ah Miami vice. Ferrari rosso fiammante, tramonti luminosi, cocktail blu fluorescente, fenicotteri rosa… E poi alla regia c’è lo stesso Mann ideatore della serie, quindi si va sul sicuro con queste cose, no? Certo che si va sul sicuro, ma completamente nella direzione opposta. Mann infatti prendendo in mano questo progetto si è reso conto che nessuno può tornare dopo venti anni di assenza esattamente com’era quando se n’è andato, men che meno gli anni ’80.
Innanzi tutto Miami vice è un trionfo dell’oscurità. Tutto si svolge in orari notturni, a parte rare eccezioni, ed è cupo, lontano dalla luce del sole, anche la solare Cuba. Perché lo spacciatore che negli anni ’80 andava in giro con camicia hawaiana e pantaloni bianchi oggi ha una felpa nera con cappuccio. Basta questo parallelismo per capire com’è cambiato il vizio di Miami nelle sapienti mani del suo creatore. Inoltre tutto diviene più tecnologico e realistico: non c’è più spazio per figure criminali che sembrano uscire da un romanzo o una canzone pop.
E’ proprio in funzione del realismo che si scatena tutta la straordinaria bravura tecnica che sta alla base del lavoro di Mann. La notte è ripresa come solo in Collateral era stato fatto, con una perizia fotografica e un uso del digitale francamente incredibile. Anche il comparto audio va oltre ogni aspettativa (anche se è difficile da valutare in DVD) ed è tutto elaborato ad hoc per avvolgere lo spettatore, trascinato da cameraman a spalla come in Bourne, all’interno di sparatorie sporche, letali e per nulla eroiche. Miami vice è la perfetta traduzione di quello che sono diventati oggi gli anni ’80.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
69 - 2 Fast 2 Furious
Fast and furious 2 è un film che c’ha i probblemi. Sì perché dimostra come già alla seconda parte di una serie sia possibile perdere una bussola (già instabile di per sé, sia chiaro). Per riassumere i problemi del film in una semplice frase si potrebbe dire che 2 Fast 2 Furious considera esclusivamente la parte più sciocca e superficiale di un tema come il tuning automobilistico.
Al contrario di altri efficaci film, infatti, questo non è altro che una carrellata, una vetrina piatta e senza significato di un ammasso enorme di macchine decorate con un cattivo gusto techno barocco. Francamente una scena impostata come quella dell’inseguimento in mezzo al traffico di auto modificate non trasmette né adrenalina né fascino per il suo caleidoscopio di colori, ma solo un’irritante sensazione di caos e di ingorgo da tangenziale est. E, francamente, non credo che uno spettatore voglia ritrovarsi al cinema in una situazione simile alla più crudele invenzione del XX secolo, alla piaga che dilania Palermo e mette famiglia contro famiglia: il traffico.
Inoltre si respira una totale assenza di idee a livello di sceneggiatura: tutto scorre su binari di cliché fin troppo ben collaudati. Perfino le battute in bocca ai personaggi sembrano provenire tutte “da un’altra parte” e non danno nessuna sensazione di “citazione ammiccante” ma solo di carenza di qualità nella scrittura. Alla fine risulta chiaro che tutto ciò è dovuto all’assenza dei due pilastri su cui si reggeva il primo film. Da una parte la presenza scenica di Vin Diesel, ma soprattutto l’abilità di mestierante nel campo dell’intrattenimento spicciolo di Rob Cohen.
| Voto (1/5): |  |
70 - Velocità massima
L’opera di Daniele Vicari è solo apparentemente un film leggero di intrattenimento, o uno scimmiottamento a più ricche produzioni statunitensi. In essa il tuning è infatti preso come metafora e portatore di un messaggio tipico delle opere di Vicari, riscontrabile anche ne L’orizzonte degli eventi. Il tema è quello della manipolazione della realtà.
I suoi personaggi sono sempre animati dalla ricerca dell’affermazione di se stessi. Tale affermazione si deve realizzare a prescindere da quale sia realmente l’evidenza dei fatti. E allora essi dedicano la propria vita a ingannare la realtà, a manipolarla, a cambiarla. Anche quando questo può significare il tracollo finanziario o sentimentale. Le perle di saggezza maschile snocciolate da Mastandrea non sono altro che la maschera di una persona che sa solo manipolare ciò che conosce e non è in grado di ammettere quanto tutto il resto per lui sia misterioso.
Non mancano purtroppo molte ingenuità. Da una parte le ridicolaggini del truccare una macchina col computer, dall’altra prendere come esempio di bolidi insuperabili delle Ford superschifo deluxe. Tuttavia non sono grosse macchie nell’economia del film: contribuiscono a creare quell’atmosfera spensierata da italianità che alleggerisce i toni e prende in giro chi tratta l’automobile come una sorta di reliquia divina.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
71 - Initial D
Initial D è strano come può essere strano un film di Hong Kong ambientato in Giappone e tratto da un manga. E’ strano come una coppia di registi come Wai-keung Lau e Siu Fai Mak, da sempre dediti a rinnovare con straordinaria forza il poliziesco di Hong Kong si dedichi a un’opera così lontana dalla loro specialità. Abbiamo capito di essere di fronte a un’opera particolare: ma in tutta questa singolarità esiste qualcosa di buono?
Se esiste è davvero poco. Prendiamo come esempio il protagonista del film: le corse. Ci si comincia a scaldare durante il film con il racconto di come il ragazzino pilota riesca ad acquisire la tecnica del drifting, pregustando il grande spettacolo che verrà. Poi si giunge alla prima sfida e… Cavolo, i registi con la macchina da presa ci sanno fare davvero: adrenalinico ed esaltante. E poi? E poi comincia una serie interminabili di frasi monosillabi, situazioni stereotipate e gare tutte uguali e tutte ricalcate sullo schema iniziale. Eh no, se bisogna sparare tutte le cartucce in una volta sola allora tanto valeva fare un medio metraggio.
Prendendo ad esempio i comprimari invece, ovvero i personaggi, la situazione non migliora. Nessuno in quella banda di morti di sonno riesce a convogliare un’emozione, nemmeno il ragazzo che riesce a uscire da questa condizione risvegliato dalla “passione per la velocità” (sic). Straordinaria è invece la Toyota AE86, portatrice di un fascino spigoloso paragonabile alla DeLorean di Ritorno al futuro. Initial D è un film che subisce la maledizione del nome del drifting: scivola via anche lui come un copertone sull’asfalto, lasciando un piccolissimo strato di gomma sulle menti degli spettatori che presto lo laveranno via.
| Voto (2/5): |  |
72 - A2 Racer
Macchinone, gnocca e un’atmosfera da “Non prendiamoci affatto sul serio”. Deve puntare su altro un film di car tuning? Francamente non credo. Se A2 Racer ha un pregio allora è sicuramente quello di saper riconoscere i propri limiti. Anche perché onestamente chiunque messo di fronte a un film che si presenta come un Fast and furious fatto dai tedeschi difficilmente riuscirebbe a nascondere un’inquietudine e un nervosismo di fondo.
Sia ben chiaro che comunque ci troviamo di fronte a un film piuttosto povero. Il primo difetto che salta immediatamente all’occhio è una sceneggiatura piuttosto approssimativa proprio a livello di realizzazione dell’impianto narrativo: le prime due scene sono totalmente sballate nei tempi e nella presentazione dei personaggi. Eppure, passato questo scoglio, gli stessi personaggi riescono a vivere di vita propria e, nella loro piattezza, a risultare simpatici e convincenti. Purtroppo la regia ha quella terrificante patina di “action alla Steven Seagal” dove scene che in teoria dovrebbero essere emozionanti e adrenaliniche risultano essere statiche come un monolito (vedere le gare in autostrada: è così palese che sono riprese velocizzate di macchine che vanno a 80 all’ora da far vergognare lo spettatore).
I siparietti comici che vedono protagonisti i poliziotti anche se ampiamente stereotipati (ancora con le barzellette sui carabinieri? Su dai…) ogni tanto riescono nel loro intento. Anche se non è ben chiaro come faccia l’imbranato protagonista a diventare un superfigo solo piazzando il culo su una Mustang. Insomma il film ha i suoi pro e i suoi contro (solo a un tedesco poteva venire in mente l’idea della Smart truccata che raggiunge i 220 Km/h), fa sì passare un’ora e venti piacevolmente ma questo non basta. Se avesse saputo giocare di più con gli stereotipi come ad esempio Blu profondo avrebbe forse raggiunto la sufficienza.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
73 - Miss Muerte
Non conosco molto la sterminata filmografia di un prolifico luminare del cinema di cassetta come Jesus Franco, ma a giudicare rapidamente dal piccolo campione che ho visionato mi pare di poter capire che questo Miss Muerte ne rappresenti probabilmente uno dei prodotti di punta. L’equilibrio tra paura, sangue ed erotismo che lo accostano al Joe D’Amato di Antropophagus sembra trovare nel diabolico dottor Z una combinazione vincente.
La trama parte da binari piuttosto classici: gli studi eticamente controversi e dai discutibili risultati di uno scienziato eccentrico lo portano alla derisione da parte dei colleghi e alla sua conseguente morte per lo choc subito. Ma la sua eredità viene raccolta della figlia che, altrettanto intelligente e pazza, progetta la sua vendetta. I tre scienziati, i carnefici della follia, rappresentano la resistenza del nostro raziocinio a quello che esce dai binari di ciò che possiamo comprendere. Essendo però essi stessi vittime di questa pazzia stanno a significare che il folle e l’assurdo non devono mai essere oggetto di scherno, non prima di averne una piena comprensione non basata solo sul sentito dire.
C’è molto del Mabuse di Fritz Lang nella macchina che è in grado di dare vita alla temibile Miss Muerte un concentrato di erotismo e fatalità assolutamente impensabile per l’epoca in cui il film è stato girato. Alcune stesse scelte di ripresa, come la camera a mano, fanno di questo film un capostipite quasi sconosciuto di certo cinema che esploderà poi, soprattutto in Italia, negli anni ’70.
| Voto (4/5): |  |
74 - L'uomo senza ombra
Veroheven ci ha abituati da sempre a una fantascienza fuori dagli schemi o quantomeno interessante. Questo uomo senza ombra però è senza molte altre cose: non c’è il burlesco fascismo di Starship troopers, non c’è la solida trama Dickiana con piani di realtà intrecciati e confusi di Atto di forza, non c’è la critica sociale splatter di Robocop. Quindi, alla fin fine, cosa c’è in questo uomo senza ombra?
Personalmente lo ritengo uno Spiderman al contrario. La scintilla che ne anima lo svolgimento è, come nell’uomo ragno, il dono di un potere: l’invisibilità. Ma Veroheven ha intenzione di svolgere il suo compito a casa in maniera radicalmente diversa da Stan Lee. Il suo Peter Parker infatti si comporta in maniera diametralmente opposta, e più vicina a quello che farebbe un essere umano reale, credo (perdonatemi il nichilismo). E’ acuto il cineasta olandese nel suo sondare la natura umana e per questo va solo applaudito.
Se a livello di contenuti L’uomo senza ombra non tradisce, a livello di realizzazione si rimane alle perplessità iniziali. Non c’è, nella realizzazione, uno spunto, un acuto, un guizzo che lo possa far diventare un’icona memorabile di un certo filone di fantascienza.
| Voto (3/5): |  |
75 - Frankenstein jr
Non si può dire che con questo film Mel Brooks abbia aggiunto qualche cosa al clichè dello scienziato pazzo. Complice la predisposizione fisica di un Gene Wilder già di base abbastanza somigliante ad Einstein, il FrankenstIn del film è una riproposizione tradizionale di tutti gli stereotipi: manie di onnipotenza, pettinatura sparata, mezzi sbrigativi, amore di conoscenza…
Ma, alla fine, a chi importa. Frankenstein jr. è di certo il suo film migliore perchè ha tutti i pregi della comicità idiota di cassetta di Brooks (attenzione lettori: idiota è da sempre per me un grande complimento in questo caso), ma non solo. Questo umorismo è sapientemente mescolato con temi alti, tra i quali il rapporto tra l’uomo e l’ignoto, un misto tra paura e voglia di scoperta. Questi temi alti trovano ampio respiro attraverso pause nella comicità sapientemente previste dalla sceneggiatura, come la solenne e foriera di brividi di piacere scena della cattura della furia selvaggia della natura per gli scopi umani oltre i propri tradizionali limiti. E anche alcune scelte comiche sono felicissime nel traghettare questi contenuti (penso alla scena dell’eremita). Come si spiega questa differenza palese con tutte le altre produzioni di Mel Brooks? Potrebbe essere la collaborazione in fase di scrittura di Gene Wilder, anche se a giudicare dai film da lui diretti in prima persona (Luna di miele stregata) non sembrerebbe proprio.
Sta di fatto che oltre quanto detto si ride. Si ride tanto e di gusto, e soprattutto con i tempi giusti, senza ridere “troppo”. Molte battute sono diventate veri e propri tormentoni da anni ormai e se ancora non l’avete visto lo diventeranno. Una nota in chiusura sull’adattamento italiano (che comunque non ha nessun peso nella valutazione di questo come di qualsiasi altro film): è stato realizzato in maniera magistrale e alcuni passi ardui sono stati resi quasi meglio che in originale.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
76 - Beyond Re-Animator
Piccolo test. Un giorno incontrate per caso uno scienziato (in carcere eheheh). Costui vi confida di aver bisogno di voi per condurre delle ricerche. Quello di cui ha bisogno sono cavie umane per mettere a punto un suo siero verde fosforescente in grado di rianimare i morti. Qual è la vostra reazione? Personalmente di primo acchito la mia sarebbe cercare di capire come abbia fatto Yuzna a scoprire dove abito. Ma di sicuro so che subito dopo verrebbe lo sdegno per una proposta così immorale.
In fondo il dilemma morale che ci pone il dottor Herbert West, protagonista della serie Re-Animator, è molto più semplice di quello, ad esempio di Veroheven nell’uomo senza ombra. Non si tratta di dover gestire un potere caduto dal cielo, non c’è nessuna occasione che ci rende ladri. Si tratta di lavorare sodo per costruirsela, questa occasione. E, data la sua difficoltà, è facile mettersi a posto la coscienza e rifiutare. Ma quando questo siero è in grado di riportare in vita una persona alla quale teniamo più di ogni cosa le nostre certezze traballano e cadono. E si smaschera ancora una volta l’ipocrisia umana.
Purtroppo queste considerazioni, già banalizzate di per sè dal poco spazio, sono ulteriormente rese stantìe (quando non assenti) dall’opera di cui stiamo parlando. Yuzna non maschera il suo tentativo di resurrezione di West come risultato di una crisi di risultati creativi in terra iberica (vedi Rottweiler). Ma non basta avere per le mani un personaggio carismatico come il dr. West proveniente da un passato ormai straniero se intorno non si è capaci di donargli un teatro degno del suo rango.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
77 - 15: The movie

Si può tranquillamente dire che questo film filippino sia una delle più riuscite trasposizioni su pellicola di un fumetto o forse, esagerando, di una tematica esistenziale. E’ il frutto infatti di un lavoro meticoloso di riduzione della tecnica di ripresa a punto di vista dei personaggi rappresentati. Ovvero: dato che i personaggi e protagonisti di questo film sono dei quindicenni allora il film stesso è rappresentato in tutti i suoi dettagli (sceneggiatura, montaggio, fotografia) come se fosse visto (o per meglio dire fatto) da un quindicenne.
Il risultato è qualcosa di veramente ostico per lo spettatore. Perchè montaggio sincopato e flash di luci sono serviti in maniera barocca, gratuita e irritante, e tutto questo è voluto, perchè facente parte di una ben precisa scelta comunicativa portata al suo estremo. E pone una domanda interessante: fino a che punto ci si può spingere nella ricerca di uno stile espressionista che si adatti come l’acqua alla tematica e ai punti di vista trattati? Spesso si tacciano film di troppa impersonalità, di stile omogeneizzante e asettico che tratta senza una visione veramente artistica differenti storie che meriterebbero ben altri stili (lo so perchè l’ho fatto più volte). L’estremo opposto è 15, ed è quindi logicamente qualcosa di sempre buono e riuscito?
Per quanto mi riguarda no. E’ ancora per me da stabilire, ma credo esista un punto di non ritorno oltre al quale dare un taglio eccessivamente espressionista o comunque personale è altrettanto deleterio all’assenza di un progetto stilistico. Per certi versi la visione di 15 è estrema quanto quella del film blu di Jarman, e per lo spettatore può essere altrettanto ostica.
| Voto (2/5): |  |
78 - Sweet sixteen
Il cinema di Ken Loach è da sempre fatto di eccessi. E se è vero che da un lato questo può renderlo affascinante, da un altro punto di vista è un terribile male che rende i suoi film assolutamente indigesti e faziosamente chiusi in se stessi. In tutta la sua immensa filmografia sociale, però, Sweet sixteen spicca come uno dei pochi esempi in cui gli eccessi riescono ad amalgamarsi alla storia, a diventarne funzionali e a far sentire di meno il loro peso sulle spalle dello spettatore.
Quella che viene narrata è una storia di ascesa al potere comune a molti film sulla falsariga di Scarface, per richiamarsi all’esempio forse più celebre. La differenza è che ad attuarla è un ragazzo di quindici anni, che da piccoli crimini diviene prima spacciatore e poi affiliato a un’organizzazione che lo spinge fino ad azioni drasticamente più gravi. La trovata intelligente è quella di lasciare in totale sospeso (sia nella risoluzione del film che più sottilmente con lo sguardo della telecamera) il giudizio che normalmente un altro cineasta avrebbe dato al proprio protagonista.
Ovviamente non sto dicendo che Loach guardi con occhio neutrale al ragazzo interpretato magistralmente (come suo solito) da Martin Compston e a tutto ciò che gli ruota attorno. Non è un regista capace di farlo, non ne ha la sensibilità. Ma il freno che si è posto è abile e intelligente nel centellinare queste considerazioni in quello che è sicuramente il suo film più asciutto. Lontanissimo da pacchiane e nauseanti banalità sul “bianchi e neri che ce importa, volemmose bene” presenti ad esempio in Un bacio appassionato.
| Voto (3/5): |  |
79 - Il giardino delle vergini suicide
Sofia Coppola con questo film si è dichiarata poetessa. Con tutta probabilità (anzi quasi certamente) non è il suo film migliore, in quanto le stesse tematiche sono state rielaborate con più maturità e malizia nei due lungometraggi seguenti, particolarmente in Lost in Translation. Ma l’idea della forza interiore, della volontà di vita e di esperienza tipicamente femminile pone le sue radici nell’albero tanto amato dalle vergini del titolo.
Diviene poetessa perchè riesce a rielaborare dei sentimenti complicati, delle pulsioni che vengono dall’interno dell’anima di ragazze ingenue e ancora nuove alla vita che ancora non hanno conosciuto. Questa rielaborazione è un lungo processo di esteriorizzazione che ha il suo culmine con un’opera artistica unica, che riesce a dare un nome vero a queste pulsioni. Operazione che in fondo sta alla base dello stesso concetto di poesia: prima che un poeta lo descrivesse nessuno aveva mai associato il concetto di amore a tante e tali sfaccettature.
E lo stesso avviene davanti all’obiettivo della macchina da presa della figlia di Francis Ford Coppola. Prende corpo quell’inquietudine tutta adolescenziale, quel malessere riposto nel sospetto di non riuscire a poter vivere tutto, in pienezza e completezza con se stesse che magari può passare inosservato, banalizzato o volgarizzato, ma che è presente nelle pieghe dell’animo di chi è abbastanza sensibile per accorgersene. Non solo Sofia lo ha certamente subito, provato e superato, ma l’ha anche capito e reso comprensibile da tutti.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
80 - Elephant
Quando si ha un problema grande quanto un elefante l’unica cosa possibile per il cervello umano è quello di dividerlo in sotto problemi e cercare una risposta ad essi. Il problema sorge quando la riduzione in sotto problemi non è sufficiente perchè anche ognuna di queste variabili si scopre essere essa stessa grande come un altro elefante. L’elefante iniziale è il liceo di Columbine, le sue variabili sono i ragazzi che lo abitano.
In altre parole Gus Van Sant ci pone di fronte il preoccupante interrogativo di un disagio giovanile che ha trovato per una serie di ragioni un terreno fertile. E in questo terreno è esploso con una violenza mai vista. E vuole prenderci per mano e farci letteralmente inseguire (con straordinarie scelte di piani sequenza e movimenti di macchina) i ragazzi che lo rendono vivo in un giorno come gli altri che non è come gli altri.
Lontano anni luce dai facili indici accusatori del Bowling for Columbine vuole mettere a nudo quello che può essere successo per capire che… Che in realtà non c’è niente da capire, o meglio di comprensibile. Tutti i punti di vista espressi, tutti i tasselli del puzzle fanno parte di un quadro cubista, a tre dimensioni o forse trenta, non indagabile dalla mente umana fino in fondo, ma spietato come una bomba ad orologeria. Come un perfetto scienziato, ma artista, è consapevole che una grande opera non può dare risposte nè facili nè difficili, può solo spingere a farsi le giuste domande.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
81 - The constant
La serie di Lost si adatta perfettamente allo spirito del mistero dei viaggi temporali. Perchè da sempre ne rappresentano i due pilastri fondamentali con la continua decostruzione della linea temporale mediante flashback e flashfoward. Con il mistero è in grado di fornire domande appassionanti, alle quali non è importante dare una risposta, o non lo è darla nei semplici e poveri termini della linearità di una trama. Con i flashback invece è sempre stata una sfida affascinante nel trovare i parallelismi, il significato e la complementarietà tra “ciò che è stato” e “ciò che è”.
Spesso delude per soluzioni poco brillanti o esagerate, soprattutto quando vuole rimarcare qualcosa di “alto” o “importante”. Questi difetti invece non si applicano a The constant che in quanto ad ambizioni e spiegazioni fornisce solo il minimo indispensabile. Il resto è una storia d’amore, di fantascienza e di una corsa disperata.
L’episodio è costruito in maniera tecnicamente invidiabile. Tutto il ritmo è di fatto un’unica enorme feccia dritta puntata verso l’alto. Ogni scena si sussegue aumentando sempre di più il pathos verso la risoluzione finale, e non ha importanza in realtà quale sia. E’ importante che tutta la messa in scena rasenta semplicemente la perfezione. E’ impossibile staccare gli occhi di dosso a Desmond nella sua turbolenta, irregolare, rocambolesca e climatica ascesa verso la propria salvezza. Testimonianza che con cuore e testardaggine si può fronteggiare anche ciò che per noi è ignoto a patto di mettere in gioco tutto noi stessi.
| Voto (4/5): |  |
82 - The jacket
Esiste un filone di fantascienza dei paradossi temporali da salotto, e The Jacket ne fa parte. In questo genere la stesura della sceneggiatura utilizza salti e paradossi temporali per tessere una tela che vuole sorprendere e spiazzare lo spettatore e porlo di fronte a degli enigmi che non sono altro che un mero piatto riscaldato vecchio di parecchi decenni. Vorrebbero essere come Ritorno al futuro, dove invece la scrittura è (quasi) a prova di bomba e comunque ha una sua coerenza interna, ma si ritrovano ad essere dei Butterfly effect.
In tali film si fa un uso stereotipato del paradosso temporale come se l’eroe all’interno della vicenda fosse onnipotente e potesse andare ad uccidere Hitler. In realtà non si rendono conto che non si può giustificare un gioco del genere con la linea temporale se non lasciando perdere enormi implicazioni. Il presente è la somma di tutto ciò che è passato e la sua manipolazione è molto più complessa di un semplice salto. In pratica è necessario trattare il passato con molta maestria, come una strada percorribile in sentieri molto ristretti: ciò che è già successo non può cambiare. Ma un semplice principio nella mani di sceneggiatori incapaci porta ad abomini simili al coreano 2009: Lost memories.
The jacket non riesce a salvarsi, nemmeno con la splendida Knightely e il bravissimo Brody. Pur se il meccanismo che permette al protagonista di muoversi nel tempo è intrigantemente spaventoso e assolutamente non dipendente dalla sua volontà di vittima, si respira pur sempre un’aria da messia, da supereroe. E questo non fa bene, non riesce a catturare nemmeno per un secondo.
| Voto (2/5): |  |
83 - Il mare
Avverto fin da subito che questo paragrafo potrebbe rovinare la visione del film in quanto discute del meccanismo narrativo su cui si basa, e che viene svelato verso la metà della vicenda. Quindi se avete intenzione di vederlo (o di vederne il remake La casa sul lago del tempo) siete avvisati.
L’assunto fondamentale di cui si discute infatti è carico di una certa genialità. Viene costruito un contatto misterioso e affascinante tra due persone. Queste persone però sono impossibilitate a incontrarsi. Quella che all’inizio poteva sembrare una burla si rivela essere invece un mistero ancora più grande. Le lettere che trovano (e si scrivono) i due protagonisti infatti non provengono da due luoghi diversi, ma da due tempi diversi. Essi sono infatti gli inquilini della stessa casa a pochi anni di distanza l’uno dall’altro. Il che fa sorgere un inquietante interrogativo: una volta scoperto ciò, come mai l’inquilino del passato non è rimasto ad aspettare l’amato del futuro nella casa?
E’ geniale perchè questo interrogativo fa riflettere sul passato, sulla storia, sul destino. Ma anche sulla lontananza incolmabile, su un rapporto che cresce e diventa unico. Purtroppo regia e sceneggiatura non sembrano intenzionati a spingere il piede sull’accelleratore di un’idea veramente stuzzicante. Dopo aver ideato questa situazione tutto si appiattisce sui toni banali e piatti di una storia d’amore fatta di sospiri e sguardi intensi all’orizzonte, senza che tutto questo possa davvero riempire il vuoto di domande e di voglia di scoprire che le basi della sceneggiatura creavano.
| Voto (2/5): |  |
84 - The girl who leapt through time
Cosa succederebbe se un giorno scopriste per caso di avere il potere di saltare indietro nel tempo? Che cosa fareste? Probabilmente combinereste un sacco di disastri. E’ più o meno quello che succede alla ragazza protagonista di questo film, imbrigliata nella pesante normalità della sua situazione fatta di compiti in classe e amici di sempre che cominciano a covare sentimenti nuovi. Il potere di saltare nel tempo è dunque occasione per riflettere su se stessi.
E’ divertente e non pesa l’approccio naif al paradosso temporale. E’ leggero come può essere leggera una liceale ingenua e pasticciona. E se all’inizio il nuovo super potere viene ovviamente usato per comodità personale, lentamente la protagonista capisce di acquisire una nuova maturità. E avviene a due livelli. A livello della maturazione spontanea della persona, quando si rende conto che certe situazioni indesiderate si rivelano essere inevitabili (esilarante le successioni di scene delle dichiarazioni d’amore), oltre alla consapevolezza che nel cambiare un avvenimento per evitare un danno c’è sempre qualcuno che ci rimette, non importa quanto buone siano le nostre intenzioni. E a un livello di un semplice limite posto dall’esterno: nessun potere, nessuna potenzialità che abbiamo ora sarà disponibile in eterno e quindi ne dobbiamo fare un uso accorto e saggio.
E alla fine questa ragazza che salta nel tempo sa far ridere, commuovere, salire la tensione e riflettere. Il tutto con uno stile visuale abbastanza personale e una buona messa in scena. Le falle di sceneggiatura, soprattutto in fase di risoluzione, sono in fondo perdonabili, come già detto. E’ un altro esempio di come l’animazione giapponese di consumo sia ancora un passo avanti rispetto alla media occidentale.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
85 - Milk
Se si dovesse accostare un esempio del passato nella filmografia di Van Sant a Milk bisognerebbe risalire di certo a Will Hunting. Entrambi i film condividono infatti un’idea ben chiara del cineasta del Kentucky, ovvero la sua forte volontà di mettere al servizio le proprie qualità di regista e di produttore di arte utilizzando un linguaggio stilistico più accessibile a tutte le fasce di spettatori. I risultati di Milk però sono abbondantemente superiori a quelle di Hunting.
Questo perchè il film con Matt Damon presenta questa volontà solo a livello implicito, e per tutta la durata dell’opera si assiste alla messa in scena di qualcosa di, in un certo senso, scontato e poco innovativo. Milk invece rappresenta a tutti i suoi livelli di lettura e di realizzazione una vera e propria poetica della svolta di Van Sant. Già nella recensione sul blog avevo evidenziato come il forte messaggio convogliato dal film è quello di un innalzamento di pugni contro l’autoghettizzazione, una tra le subdole armi che le società liberali imbrigliano le minoranze indesiderate (come diceva Pasolini “In una società repressiva tutto è vietato quindi si può fare tutto, in una società liberale qualcosa è permesso e si può fare solo quel qualcosa”).
Ma è ovvio che Van Sant non si rivolge (solo) ai gay. Van Sant si rivolge anche a se stesso. I film ostici, gli scogli meravigliosi dal punto di vista stilistico ma assolutamente insopportabili per il pubblico medio (Gerry?) sono l’autoghettizzazione dell’intellettuale, sono uno dei mali contro cui la cultura deve lottare. Continuare su quella strada per Van Sant è continuare a voler tenere separata la maggior parte della popolazione dalla fruizione della cultura. E con la sua svolta rappresentata da Will Hunting come da Milk vuole dire, definitivamente, basta a tutto questo. La nomination all’Oscar la si può considerare come un piacevole effetto immediato.
| Voto (4/5): |  |
86 - Frost Nixon
Questo film di Ron Howard fa parte di quella categoria di film “belli perchè… boh”. E’ innegabile che ci si trova di fronte a una ricostruzione accurata, uno stile di ripresa elegante, una sceneggiatura ben scritta con qualche one-liner da ricordare. Però è anche vero che non c’è niente di particolare, di memorabile. Vederlo candidato a un Oscar non scandalizza nessuno, eppure ci si chiede se davvero l’anno passato non sia uscito niente di meglio. Suoi compagni sono ad esempio Ray o Sideways.
A dirla tutta è facile individuare i motivi della nomination. Che risiedono, guarda caso, principlamente nei punti deboli che avevo individuato nella recensione sul blog. Ovvero fondamentalmente nella figura di Frost amalgamata con quella radicale interpretata da Sam Rockwell. Ovvero spacciare l’immagine dell’idealismo americano da grande democrazia, che riesce a mettere al confino coloro che la minacciano, anche dall’interno, e a rinascere più forte che prima, animata da questi giovani bollenti spiriti.
Un meccanismo fin troppo facile, un gioco furbo che non regge però a una analisi anche solo poco attenta. E che condanna questo film nella sua valutazione in ottica Oscar: rappresenta proprio tutto il male dello scendere a patti della qualità solo per guadagnarsi il proprio nome inciso su di una targhetta. Con tutto che, lo ripeto dalla recensione, questo è probabilmente il miglior film di Howard: sono le circostanze ad inchiodarlo.
| Voto (2/5): |  |
87 - Slumdog millionaire
Il trionfatore degli Oscar di quest’anno aveva tutte le carte in regola per fare man bassa di premi. Aveva la storia d’amore, aveva un comparto tecnico classico ma ben realizzato, aveva una sceneggiatura originale e ben scritta, aveva la morale facile che piace agli animi semplici della Academy, aveva l’ambientazione povera dell’India contemporanea.
Danny Boyle ha messo in piedi un impianto sicuramente ben riuscito per narrare una piccola storia senza pretese. Ha anche avuto una buona intuizione in fase di sceneggiatura: le domande del quiz che scandiscono la vita del protagonista sono un meccanismo che può affascinare e di sicuro fresco e interessante. E questo basta per fare incetta di premi. Purtroppo il suo milionario degli slums si è trascinato dietro alcuni effetti collaterali che lo rendono un clamoroso inno allo schiavismo culturale con cui chi detiene il potere imbriglia chi di potere non ne ha.
Nelle battute finali ci si rende conto che il quiz è l’unica via per uscire dagli slums, ma solo se si sta al suo gioco e alle sue regole perverse. Il ragazzo protagonista infatti si piega a tutto e obbedisce come un cagnolino a tutte le vessazioni e alle ingiustizie del sistema. E con lui vengono imbrigliati anche tutti i milioni di persone che rimangono incollati al televisore per seguire le sue gesta. Il fatto che ce la faccia non è testimonianza che il sistema possa essere scardinato, ma è proprio il raro successo occasionale con cui il sistema stesso fa credere di poter essere scardinato. Ma in realtà questa è proprio la sua base fondante.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
88 - Valzer con Bashir
Di Valzer con Bashir ho già accennato i difetti, il cui principale è l’eccessivo manicheismo nel dipingere il conflitto libanese e il porsi come colpevoli senza appello e senza considerare attentamente le ragioni di ognuno. Il j’accuse diretto contro se stessi è uno degli esercizi che più solletica la masturbazione mentale della giuria californiana. Tuttavia questo difetto in Bashir è del tutto secondario: mina la sua universalità ma per nulla la sua visione artistica del mondo.
E’ meraviglioso infatti come Folman riesca a riprendere non la realtà di ciò che è accaduto, ma i suoi ricordi e le sue sensazioni. Lo stile visivo fumettistico in movimento quindi non è affatto fine a se stesso, ma funzionale all’emozione e al ricordo. Il Valzer del soldato con il mitra ne è forse la sequenza cardine e più importante, la rappresentazione concreta di come il ricordo è più vero di ciò che è successo.
Anche lo scheletro con cui prende forma la vicenda non è affatto scontato. Invece che riprendere direttamente e per tutto il tempo la battaglia, cosa che lo avrebbe reso un classico film di guerra, la storia si snoda per interviste, come un documentario. Il che rende esplicito come sia il filtro dei ricordi ad essere importante (la sequenza psicologica del circo all’inizio) e di come in realtà una guerra non finisce mai con il cessate il fuoco, ma perdura per sempre nelle menti, nelle azioni e nella vita dei soldati.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
89 - Virus
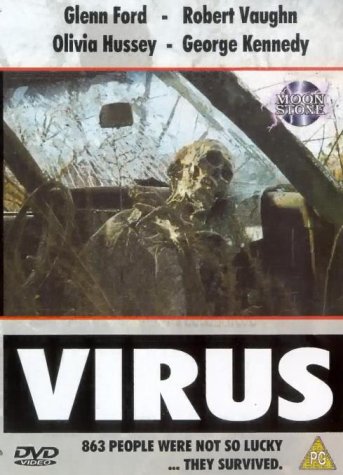
L’ampio preludio che apre questo film mostra come l’esplosione di un elemento inaspettato possa far crollare senza appello un intero mondo di certezze. Le affidabili strutture su cui si regge il nostro mondo infatti non sono abbastanza solide per reggere un cambiamento così repentino. E l’unica barriera che si frappone tra la morte e la sopravvivenza è un ambiente ostile alla vita stessa, l’Antartide, in cui si rifugia l’ultimo baluardo umano. E’ possibile risorgere da queste ceneri ricostruendo da zero una nuova società che non frapponga più le nazioni (e le persone, i sessi) con vecchie e superate ostilità?
La risposta di Fukasaku non arriva senza una certa dose di sofferenza e dubbi. Ma la sua risposta è sì. Dopo litigi e baruffe (i russi e gli americani, gli argentini e gli inglesi, le donne violentate) arrivano azioni che possono finalmente far sperare in un’epoca di pace (il sofferto auto sacrificio del generale russo con gli uomini del suo sottomarino). Quest’aria di “pace tra i popoli” rispecchia ciò che si vede in alcune sorprendenti produzioni di sci-fi della Germania orientale in piena guerra fredda (su tutti Sojoux 111). E tale pace parte sotto degli auspici possibili (il neonato, la collaborazione nel cercare una cura, il viaggio in cerca di superstiti). Tuttavia c’è sempre un’ombra che gravita sopra il futuro.
Innanzi tutto l’ombra dei tagli inspiegabili alla pellicola, svariati minuti (credo più di quelli di Solyaris, addirittura) che quasi non la fanno sembrare nemmeno un horror. Ma il pericolo che gravita di più sul futuro è un passato scellerato fatto di sfruttamento e scelte miopi e cieche di autodistruzione. Se non esiste una pianificazione, un’attenzione a ciò che ci sta intorno tutto rischia di scomparire, soprattutto un fragilissimo equilibrio che si è costituito quasi per miracolo.
| Voto (4/5): |  |
90 - La cosa
Uno dei temi ricorrenti negli anni ’80 era quello del corpo. Già lo dissi per La casa 2 e qua lo ripeto: gli anni ’80 hanno portato un’enfasi estenuante sulla bellezza fisica, sulla perfezione, una sorta di culto. E l’horror del tempo, massimo anarchico sberleffo, rispondeva con sonore prese in giro di queste nevrosi. Lo fa anche La cosa di Carpenter e a due distinti e intriganti livelli di lettura.
Il primo e più immediato è quello di veder ridotto a pezzi il proprio corpo. Di più: vederselo rubato e usato come fantoccio è uno shock al quale difficilmente si riesce a resistere. Il secondo livello a cui opera questa “Cosa” infatti è ancora più subdolo: è il furto dell’identità. Quello di più intimo che ci rimane e che ci caratterizza viene perso e usato contro di noi, uno po’ alla maniera di Face/Off o del The game, piccolo film coreano che parte da un assunto simile al film di Woo.
Insomma: si è di fronte a una minaccia strisciante e subdola. Se non bastasse lo shock del furto di corpo e quello dell’identità rimane il fatto di trovarsi a fronteggiare uno spietato assassino che può avere il volto della persona che fino a un secondo prima ti ha salvato la vita. La spirale di violenza e orrore che si innesca viene ulteriormente elevata al quadrato: non ci si può fidare degli altri, non ci si può fidare di se stessi. E allora di chi? Di Carpenter di sicuro, che ancora oggi a sprazzi riesce a regalarci perle paragonabili ai suoi capolavori degli anni ’80. E poi di Iena Plissken. Oh sì, di lui sì.
| Voto (5/5): |  |
91 - Antarctic Journal
Dietro la sceneggiatura di questo film coreano c’è uno dei più grandi talenti del cinema di quella terra: Joon-ho Bong. Purtroppo del suo talento sia nella scrittura che nella regia ci sono solo alcune tracce: Antarctic journal infatti rischia di scivolare fin troppo spesso negli stilemi classici di un banale film di fantasmi orientale. Se normalmente questi sarebbero peccati veniali da far passare in secondo piano, per il gelido film antartico si traducono in scivoloni macroscopici. Nella distesa bianca del polo sud infatti ogni piccola imperfezione risalta all’occhio o, per meglio dire, il film è talmente esotico e arguto in alcune sue parti che la “normalità” dell’horror orientale risalta come una giraffa in una metropolitana.
La scelta di ambientazione e di totale decostruzione delle scenografie è straniante ed efficace. Così come l’elemento narrativo di misteriosi accadimenti che rientrano nella sfera del “normale impossibile”. Con tali avvenimenti mi riferisco sia al ritrovamento del diario del titolo che della malattia di uno degli elementi della spedizione. Sono normali in quanto sono cose che possono accadere (ritrovamenti, malattie…) ma impossibili perché posti nel contesto dell’Antartide. Proprio come l’Antartide stesso è un luogo reale (esiste!) ma a sua volta è talmente estremo e alieno dalla normalità a cui siamo abituati da sembrare impossibile.
Di contro c’è un Pil-Sung Yim al suo esordio alla regia. La qualità tecnica indubbiamente c’è, vista le difficoltà di ambientazione e assenza di scenografie di cui sopra, ma ci sono anche le cadute di stile. Rimane un esperimento interessante e in grado di intrattenere con gusto.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
92 - Deep freeze
Ricetta per una valutazione di 1 su Five Obstructions: prendere abbondanti dosi di fotografia da porno tedesco anni ’90, mescolare con abbondanti clichè e battute stereotipate, dare una spruzzata del solito casto e ipocrita erotismo da maglietta attillata, condire con dialoghi al limite del patetico e rifinire il tutto con effetti speciali da far provare vergogna allo spettatore e i soliti omicidi fuori campo da horror di serie zeta. Deep freeze ha tutto questo e molto di più… Yum!
Per capire in che brutte acque naviga questo film basta dare un’occhiata alle scenografie e ai costumi. Regista e sceneggiatore vorrebbero farci credere che quegli interni da villa di Beverly Hills sono in realtà una base antartica perché due o tre bellimbusti vanno in giro in piumino e ci sono due mappe del polo sud appese alle pareti. E poi le due bonazze del film vanno in giro in magliettina aderente quando non direttamente in reggiseno. Il tutto condito da un talento visionario che richiama David DeCoteau (e per chi conosce questo regista non c’è veramente bisogno di aggiungere altro).
Tutto il resto sono una assoluta mancanza delle regole basilari di ripresa e di scrittura (“Stai attento a cadere: è l’acqua più fredda del pianeta! Se ci cadi in due minuti sei morto”… Santo iddio è acqua allo stato liquido, a quanti gradi può mai essere??). Le creature che dovrebbero terrorizzare poi sono due piattole un po’ cresciute, che nelle scene finali si spostano con la stessa letale velocità di un pinguino obeso. Patetici gli attori che se le abbracciano e si dimenano facendo finta di essere assaliti da quelle cimici di plastica (questo può andare bene se è fatto con palese intento satirico, come in Alien Trepass, ma qui sono tutti serissimi: è questo ad essere agghiacciante!). Nonostante tutto comunque un’alzata di sopracciglio per una scena più cattiva del previsto se la merita anche questo Deep freeze.
| Voto (1/5): |  |
93 - Shining
Vedere Shining nel 2009 è come assistere ad un costante e sorprendente deja vu. Praticamente in ogni scena, sia quelle che costruiscono la tensione con scelte sottili e subdole che quelle in cui tale tensione esplode in una festa di sangue e violenza, lo spettatore è posto di fronte a una sensazione di “già visto”. Ma questa sensazione è molto diversa da quella che normalmente lo coglie di fronte a un qualsiasi horror post 1980. Perchè è un deja vu a ritroso: ci si rende conto di quanto questo film sia stato saccheggiato nei suoi stilemi espressivi, nella sua costruzione della paura o semplicemente di questa o quella scena. Shining è la Bibbia dell’horror e a parte piccoli casi originali ed eclatanti (e i loro cloni) quasi tutto si è ispirato (dichiaratamente o tacitamente) a lui.
Oltre a un deja vu è quindi anche un mise en abyme letterario. Perchè nel suo rifarsi a un racconto di King diventa esso stesso un “King della celluloide”, un punto di non ritorno per un certo cinema (letteratura) di genere. Come dopo 2001: Odissea nello spazio fare fantascienza non sarebbe stato più lo stesso, così dopo Shining lo stesso discorso si applica all’horror.
Deja vu, mise en abyme. Questi sproloqui francesi però non debbono dare l’idea di essere schermi protettivi per un capolavoro del passato invecchiato male e non in grado di difendersi. La visione di Shining regge ancora, quasi trent’anni dopo, anche per gli spettatori più smaliziati. L’icona di Jack Nicholson è qualcosa che pochi horror attuali riescono a permettersi, così come scelte di culto quali le gemelle, la stanza 237, la luccicanza, il foglio della macchina da scrivere…
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
94 - Misery non deve morire
Misery è, senza troppi pudori, un autoritratto di Stephen King. Lo è a due livelli: sia esplicitamente a livello di sceneggiatura che implicitamente a livello di qualità realizzativa. Nel primo caso è evidente che la sceneggiatura risente di un King che “parla di se stesso”, nel secondo caso si intuisce, nel rivederlo a distanza di vent’anni, la parabola della scrittura stessa di King che è avvenuta nel frattempo.
E’ innegabile che lo scrittore paralizzato nel suo letto e assistito dalla sua fan sfegatata, forzato a intendere e a volere solo ciò che intende e vuole lei, è una metafora del suo stato d’animo interiore. Di più: è da una parte una sottile critica al vuoto mondo della letteratura di consumo e delle sue logiche perverse. Soprattutto alla logica di chi di quel mondo è il verso finanziatore: il fanboy, colui che apprezza in maniera perversa un’idea originale e la vuole riproposta pedissequamente e sempre uguale a se stessa, negandole la forza vitale che è la vera responsabile della sua bellezza.
Il secondo parallellismo a cui alludo è la pessima impressione che Misery dà al giorno d’oggi. Come moltissima produzione anni ’90 semplicemente non riesce a reggere il passo con i tempi. La tensione è pallida, il pathos sale troppo poco in alto per coinvolgere seriamente, molti passi sono stilisticamente poveri o ingenui. E’ un pallore che a quanto pare coinvolge anche la scrittura di King, incapace ultimamente di fornire nuovi personaggi e situazioni all’immaginario collettivo.
| Voto (3/5): |  |
95 - Cuori in Atlantide
Se avete già sbirciato il voto e conoscete questo film anche solo per sentito dire o dal trailer probabilmente vi stupirete di tanta cattiveria. Perchè Cuori in Atlantide alla fine è un film confezionato benino: non ci sono particolari oscenità né a livello tecnico né a quello della sceneggiatura. Eppure la mia considerazione per questo film rasenta lo zero assoluto, o quasi. Da dove viene tutto questo astio?
Principalmente dal fatto che sono uno snob con la puzza sotto il naso, ma questo già lo avete intuito e vale per tutte le altre recensioni. Il secondo motivo è che questo film in realtà non ha uno scopo e non ha un messaggio, non ha punte stilistiche degne di nota né in positivo né in negativo. E allora la valutazione dovrebbe essere una più neutra insufficienza, dato che personalmente preferisco una piccola ambizione ben realizzata piuttosto che il tiro in alto fallito. Ma Cuori in Atlantide va oltre: non ha nemmeno una piccola ambizione. Non ha niente. E’ soltanto un passatempo, confezionato in un grigiore sufficientemente buono. Un’ora e quaranta di puro nulla.
E io detesto chi non vuole dire niente, chi (spettatore o produttore) considera un libro (come paiono essere gli ultimi di King) o un film come un semplice modo per passare il tempo. E’ una forma espressiva artistica e deve sempre avere qualcosa dentro, deve comunicare. Se dopo la visione non si ha un’opinione non dico sull’opera in quanto pezzo d’arte, ma almeno sul suo contenuto, allora è stato tutto inutile. E Cuori in Atlantide è inutile.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (1/5): |  |
96 - The mist
Non è certo la prima volta che Darabont affronta l’adattamento di un’opera di Stephen King. Per questa ragione la visione di The mist parte già con un pregiudizio affidabile. Più o meno si sa già dove andrà a parare tutto l’impianto narrativo. Ovvero i binari di un classico adattamento, piacevole e ben orchestrato, senza particolari guizzi se non quelli già abbondantemente previsti nel racconto che si adatta (vedasi Le ali della libertà).
Proprio partendo da questo pregiudizio non si può che rimanere piacevolmente sorpresi ed apprezzare questo The mist. La realizzazione è tutto fuorché piatta o buonista. Nella piattezza lo stile di Daranbont effettivamente qualche volta cade, ma meno spesso che in altre occasioni. Inoltre la realizzazione visiva dell’assedio della nebbia al supermercato è francamente affascinante e funzionale. Oltre al fatto che va vista secondo le intenzioni originali del regista, e cioè in bianco e nero, modalità che regala un pizzico di fascino in più, depredato da produttori poco lungimiranti. Tra parentesi il colore svilisce anche la computer grafica usata, in maniera simile a quello che accade per Dagon.
Ma è soprattutto il lato “buonista” che è clamorosamente negato. C’è un’efficace rappresentazione quasi sociologica delle tensioni e dello scivolare nell’irrazionalità di un gruppo di persone costrette all’isolamento per una situazione spaventosa e totalmente fuori da ogni logica. Ed è proprio l’irrazionale, il pericoloso fervore fondamentalista, a prendere piede e trovare un buon terreno in cui germogliare quando ci sentiamo piccoli piccoli di fronte all’orrore. Così come anche quando, nel finale, la razionalità e la scienza (l’automobile) cominciano a venir meno questo irrazionale torna prepotentemente, quando invece basterebbe riuscire a guardare oggettivamente poco al di là del proprio naso.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
97 - Un bacio appassionato
In questo film Ken Loach rischia più volte di dare il peggio di sé e repentinamente ogni volta riesce a salvarsi in calcio d’angolo, senza però evitare di dare l’impressione che si senta in colpa per le marachelle commesse. Il tema, l’amore inter-religioso e inter-culturale, è di quelli che Loach VIVE per dirigere, anche se il suo allontanarsi da una prospettiva politica riesce in qualche modo a salvarlo dalla sicura rovina.
Quali sono i problemi di Un bacio appassionato? Fondamentalmente è la rappresentazione stereotipata dei “cattivi”. Le due classi sociali che opprimono i due amanti protagonisti vengono rappresentati come i soliti bigotti incapaci di un qualsivoglia ragionamento logico. E’ la classica rappresentazione faziosa della parte avversa, un sintomo di immaturità nel compito, fondamentale, di instaurare un dialogo con chi opprime e toglie le basilari libertà agli individui (un po’ come succede in Mare dentro di Amenabar). Senza contare che c’è il cortocircuito logico che porta il film a sostenere che gli oppressi debbano voler cercare per forza l’integrazione e l’approvazione degli oppressori, procedimento che, oltre che impossibile, è stupido applicare in quanto può risolversi solo o con l’inasprimento dell’oppressione o con il suo ribaltamento, opprimendo a loro volta i “cattivi”.
E la risoluzione, che qui anticipo ma che è ovvio intuire fin dal titolo del film e dal suo genere, è facilona e imbarazzante. Non credo sia possibile risolvere ancora oggi, o meglio già nel 2004, un film in cui a vincere è La Forza dell’Ammore. Men che meno per Ken Loach, che se ha un pregio è quello di regalare alle sue opere sempre una nota realistica e di crudezza.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
98 - Bianco e nero
L’opera della Comencini è la perfetta sintesi della totale mancanza di talento in tutti gli ambiti realizzativi di un film, sia sul versante tecnico che su quello dei contenuti. Di più: a giudicare da quanto scritto essa è un vero e proprio fallimento a livello intellettuale. Sull’ambito di ripresa è bene spendere due parole all’inizio e non tornarci più, per aver pietà delle mie e delle vostre pupille. Basta infatti notare quanto le riprese abbiano la stessa valenza tecnica di quelle di una qualsiasi fiction italiana di seconda categoria, sulla flasariga de Gli occhi del cuore di Boris.
Vediamo quindi di sezionare il terribile contenuto di questo scempio. E vediamo come, da brava furbetta, la Comencini vada ad eseguire una codarda e scontata manovra: quella della provocazione fine a se stessa. Prende un tema controverso e dibattutto e crea una situazione artificiale, messa lì ad arte per andare a girare il dito su una piaga aperta. Va insomma a giocare con un accendino sulla coda di paglia della gente. E come lo fa? In maniera scaltra e propositiva? No, in realtà non fa altro. Butta un paio di scene e una montagna di parole solo per solleticare queste corde e semplicemente far parlare di sé invece che del tema, esposto superficialmente come non mai.
La presenza di Fabio Volo poi non aiuta. A parte l’indecente sceneggiatura e la sua discreta capacità recitativa (fortunatamente) in miglioramento, la sua presenza porta la classica ventata di intellettualoidismo new age mtv-iano da copertina. L’”essere impegnati perché va di moda” che fa rassomigliare terribilmente questo film a Una bionda in carriera. E non ci sarebbe niente di male se almeno la Comencini non avesse le pretese di andare in giro a fare la persona di cultura. Quello in realtà è: la caricatura di una bionda con un chihuahua (se non fosse che quel film americano è almeno realizzato tecnicamente meglio).
| Voto (1/5): |  |
99 - East is east
Uno dei mezzi più classici a disposizione degli scrittori per trattare il cambiamento, a volte anche drammatico, di costumi, società e individui è l’umorismo. La risata ha un enorme potere dissacrante e di alleggerimento della tensione riguardante certi temi. E’ però uno strumento che non si può usare a comando, non c’è una bacchetta magica con cui colpire gli spettatori e dirgli “Ridete!”. Va solleticata e fatta venire alla luce con una sapiente maieutica.
East is east parte da un’opera teatrale che cerca di fare proprio questo: mette in campo la drammaticità di una società multietnica in cui la tradizione schiaccia e opprime la necessità di tolleranza e di trasformazione in meticci, almeno concettuali, capaci di ragionare sulle diversità. Strumenti che sono ad oggi gli unici con cui disinnescare una possibile bomba di violenza. Ma lo fa con risultati francamente altalenanti.
Tra le varie ingenuità spicca di sicuro l’assegnare ai giovani un vero e proprio ruolo di mediatori tra la modernità e la tradizione. Già “assegnare ruoli” è spesso un sinonimo di “permettere ad alcuni di lavarsene le mani” e in seconda battuta si ignora il fatto che sono proprio i giovani le menti da tutelare, quelle che non sono in grado di cogliere i toni di grigio della realtà e si lasciano cullare dagli estremismi. E se sulla banalità di esposizione del tema si potrebbe soprassedere, sono alcune cadute di stile (la figa-torta sulle gambe della bigotta, uh che ridere… Quello dovrebbe rappresentare la leggerezza dei giovani?) a penalizzare la pellicola.
| Voto (2/5): |  |
100 - The new world
Parlare questa opera colossale di Malick solo nell’ottica del rapporto di amore tra due persone appartenenti a un’etnia diversa è una provocazione, ma è anche un grande torto verso l’opera stessa. Limitarsi all’amore e non considerare il rapporto dell’uomo con la natura, la sua parte primordiale, l’incontro di mondi diversi e il loro confronto, alla comunicazione, alla vita… Va bene la smetto. Parliamo d’amore.
L’amore che si instaura tra John Smith, anonimo colonialista britannico, e Pocahontas, figlia del re di una tribù di un mondo completamente differente, parte su basi nulle. Non c’è nulla che possa renderli una cosa sola, nessun terreno comune. Una storia che può sembrare impossibile e invece racchiude in nuce la possibilità di un amore in grado di salvare e innalzare i due mondi contrapposti. Perché quando tra due culture, tra due mondi non c’è nulla in comune è possibile creare un terreno vuoto, una tabula rasa in cui costruire insieme e senza pregiudizi qualcosa di nuovo che ha le caratteristiche di ciò che entrambi hanno messo in gioco: tutto.
La telecamera di Malick si muove con una naturalezza senza fine in mezzo a uno spettacolo fatto di alberi, indigeni a piedi nudi, fiumi, villaggi di legno, in maniera simile a come Herzog riesce a dipingere il mondo in cui viviamo nei suoi Encounters at the End of the World. Herzog spettacolarizza e pone lo spettatore di fronte a ciò che non conosce del mondo in cui vive, Malick gli è superiore perché rende lo spettatore infante di fronte a ciò che credeva di aver sempre conosciuto. Noi all’inizio di The new world partiamo come esperti John Smith, coloni che tutto sanno e finiamo come nativi americani: fanciullini di fronte a una meraviglia misteriosa e così naturale.
| Voto (5/5): |  |
101 - Rosemary's baby
Molti film di Polanski sono diventati con il tempo dei veri e propri simboli, a prescindere dal genere in cui il regista polacco si è cimentato. Non solo Rosemary’s baby non fa eccezione a questa regola, ma anzi è un film talmente riuscito da poter essere eletto come “simbolo dei simboli”, la summa (almeno nell’immaginario collettivo) del cinema-Polanski.
Posto all’interno di una trilogia assieme all’altrettanto bello e sottile L’inquilino del terzo piano, il bambino di Rosemary va a cercare di colpire molto più nel profondo. Se il suo “sequel” cerca di universalizzare la sensazione di furto della propria identità e ostilità sprigionata dalle mura di quello che dovrebbe essere il nostro rifugio, Rosemary’s baby si focalizza sulla gravidanza, sul colpo nell’intimo, sull’angosciante sensazione di essere circondati. E questo non è pane per denti ipocondriaci e/o paranoici: è l’esplosione vera della sottile esasperazione che giorno dopo giorno ci mette contro il mondo, la proverbiale goccia che scava nella roccia e che è necessario esorcizzare per non esplodere come Rosemary.
Come sempre anche il comparto tecnico è a livelli eccellenti. Polanski è anche intelligente nel creare l’horror di tensione puro, quello Hitchcockiano senza una goccia di sangue ma angosciante all’inverosimile. E ancora una volta la messa demoniaca è svariati passi avanti rispetto, ad esempio, al paziente immobilizzato nel letto dell’inquilino del terzo piano. Assolutamente imperdibile per chi sa riconoscersi nella sensibilità di apprezzare l’orrore psicologico ben più sottile di qualsiasi splatter.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
102 - A l'intérieur
“All’interno” è un furbetto film girato dall’altrettanto furbetto Castillo. In cosa sta questa furbizia? Nel fatto che il regista si nota fin dalle prime battute essere un appassionato, nonché un esperto, di film horror, e quindi manifesta questa sua passione in un completo fan service dei suoi simili, amanti del genere. Perciò il film è una carrellata, a volte scontata a volte pacchiana, di una gran quantità di clichè del genere, la cui nota distintiva è una totale cattiveria infinita nel rappresentare le vessazioni subite dalla protagonista.
Quanto sopra detto rappresenta un difetto quando la cattiveria eccede (e si trasforma quindi nella pacchianeria di cui sopra). Si ha la fastidiosa impressione che regista e spettatori diventino dei perversi voyeurs, che il loro guardare sia un godimento fine a se stesso della violenza in quanto tale. Una perversione che il film horror sarebbe in realtà in teoria chiamato ad esorcizzare. Non sempre questo accade nel film francese e questo è un brutto difetto. Tuttavia non definitivo per condannarlo. Perché esistono dei pregi in grado di salvarlo in extremis.
Innanzi tutto è affascinante l’uso delle location interne come un caldo e avvolgente ambiente che cerca disperatamente di sembrare protettivo, ma che viene irrimediabilmente violato e rovinato dalla violenza e dalla sete di sangue. Un interessante parallelismo con quanto succede attorno e dentro l’utero femminile di questi tempi (che può richiamare The others, anche se in questo caso tutto è più grezzo e urlato rispetto al delicato film di Amenabar). Infine alcune di queste manifestazioni di estrema violenza sono talmente esagerate e quasi “fuori genere” (mi riferisco soprattutto a una scena che non dimenticherete) da risultare dei veri e propri sorprendenti colpi di scena che vi attaccheranno alla sedia del tutto esterrefatti su quanto avete visto. E questo rende A l’interieur un film almeno capace di graffiare e colpire.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
103 - La culpa

Questo episodio delle Peliculas para no dormir è a tutti gli effetti la versione horror del segreto di Vera Drake. Il regista di Ma come si può uccidere un bambino? torna all’horror dopo 24 anni per la serie delle Peliculas para no dormir. Questa serie di sei telefilm ha visto tra i suoi autori molti rappresentanti del cinema horror spagnolo con risultati alterni. La forte presenza produttiva ha imposto delle regole ferree, e questo è evidente dal fatto che i sei film si somigliano molto tra loro. Questo in alcuni casi è stato un bene (per Balaguerò che è stato “riportato all’ordine” con Para entrar a vivir con discreti risultati), ma per altri un male, come De La Iglesia e anche il Serrador autore de La culpa.
Sembra infatti che i produttori abbiano imposto che le storie debbano essere tutte riguardanti i fantasmi, le case e i nuclei familiari. E Serrador sembra svolgere in maniera svogliata il compitino che gli viene proposto. Infarcisce la storia di luoghi comuni facilmente smascherabili fin dall’inizio. Non è difficile capire infatti di che clinica privata si tratta quella gestita dalla protagonista, né di che tipo siano le presenze che la infestano. Passa tutto troppo superficialmente, senza lasciare nulla allo spettatore.
Serrador non rinuncia neanche al terribile clichè del lesbismo tra le due protagoniste, veramente telefonato e comunque fuori luogo. Peccato, perché alla fine la qualità tecnica e di budget del progetto è comunque buona e superiore alle produzioni medie iberiche. Purtroppo in terra spagnola non sembra esserci la cattiveria, l’anarchia e l’estro di altri cattivissimi progetti francesi.
| Voto (2/5): |  |
104 - The brood
Sebbene non sia entrato nell’immaginario horror collettivo come quasi tutti gli altri film di Cronenberg, The brood rappresenta uno dei prodotti spaventevoli più riusciti della storia del cinema. Se non ha avuto il successo delle altre pellicole è forse perché in questa sua prova il regista canadese non ha saputo (voluto?) imprimere il suo marchio di fabbrica con la consueta estrema cattiveria. Ma basta grattare solo un po’ la superficie per trovare Cronenberg puro distillato al 100%.
Due sono gli aspetti forti del film, che controbilanciano in maniera egregia il difetto sopra esposto. Innanzi tutto il suo riuscire a porre lo spettatore dalla parte della vittima. Le sedute di psicoplasmica inventate dal sedicente dottore del film non sono rivolte solo contro la gravida e indifesa protagonista: gravidi e indifesi siamo anche noi di fronte a una telecamera che indugia con fare ipnotico sulle parole del carnefice. La tecnica di costruzione della tensione e la psicoplasmica sono palesi riletture più mature degli esperimenti di Stereo e Crimes of the future. Un’esperienza che fa montare la tensione in maniera sottile e angosciante, da vero maestro del cinema.
Spesso un’operazione del genere è in contraddizione con la vena più sanguinosa ed espressionistica (rosso sangue!) di un film. Ma qui sta la grandezza di Cronenberg e il secondo pregio del film: la coesistenza di violenza psicologica e fisica. In The brood le esplosioni di violenza sono disturbanti soprattutto perché il regista è abile a ribaltare più e più volte i ruoli di vittima/carnefice. Con un’intuizione simile a Ma come si può uccidere un bambino? ci pone di fronte al ribaltamento totale dei classici ruoli dell’orrore, con il risultato di un totale straniamento dello spettatore. Ancora una volta e in eterno. Cronenberg lo adoro.
| Voto (5/5): |  |
105 - Iago
Il secondo film di Volfango De Biasi soffre curiosamente degli stessi problemi che hanno tagliato le gambe all’altro film che vede come suo protagonista Vaporidis recensito su queste pagine virtuali ormai mesi fa. Come in Cemento armato, infatti, Vaporidis si sceglie un ruolo che dovrebbe essere oscuro, avvolto dalle tenebre, quasi cattivo. E già accostare queste tre caratteristiche a quel simpatico ragazzino fa un po’ ridere. Oltre a questo ci si mette la solita sceneggiatura ridicola, che scivola più volte nel comico volontario e involontario (e questi non sono nemmeno i difetti peggiori, affatto! A volte sono perfino pregi).
E dire che le idee questa volta sembravano esserci tutte. Una rilettura moderna della tragedia Otello di Shakespeare vista dagli occhi del cattivo. Intrigante la possibilità di ribaltare i ruoli classici: far parteggiare il pubblico per il cattivo, farlo scivolare nei sedicenti ragionamenti della parte malata dell’intelligenza. Ma lo sviluppo di questo guizzo preliminare è il semplice mettere un po’ di fard alla Maledizione della prima luna attorno agli occhi del nostro Iago di Trastevere, con lo scopo di attizzare un po’ qualche femmina sul solletico sessuale di quella malvagità che in realtà malvagità non è.
Sorvolando sul terrificante finale è proprio il rendere Iago buono a condannare il film. Se a Battiato non vanno giù i cori russi, il free jazz punk inglese, ma sopratutto il finto rock, a me non va giù il finto cattivo. Le azioni di Iago vengono giustificate, appaiono perfino ragionevoli in seguito ai torti che subisce. E’ qui che manca il coraggio: ci troviamo di fronte a un ragazzino che fa i dispetti agli altri perchè è arrivato secondo. Comunque sia alla fine questo Iago risulta guardabile, per i momenti comici a cui accennavo sopra: facili e banali ma a volte apprezzabili, come il dialetto romanaccio che sempre più spesso scappa di bocca al buon Nicolas. Dai su, per questa volta un 2 ci può scappare: va, ma non peccare mai più.
| Voto (2/5): |  |
106 - O come Otello
Come si fa a scrivere male una sceneggiatura che si ispira a un’opera di Shakespeare? Sono sinceramente abbagliato da questo singolare fenomeno, ma a quanto pare tutto è possibile. Perché questo “O” riesce a fraintendere il testo originale peggio di quanto non faccia il nostrano Iago. Il film con Vaporidis infatti, pur con tutti i suoi difetti e leggerezze, mette comunque in campo una certa passione e alcune note di umorismo. “O” invece è piatto dall’inizio alla fine.
Il difetto più macroscopico sta in Josh Hartnett. Per tutto il film il suo Hugo è un rachitico giovanetto annoiato e sembra non credere per primo nelle proprie azioni. Si trascina apatico, con un’aria tipicamente nerd, e mette in campo la propria vendetta contro il proprio capitano che non ha nulla di subdolo né di oscuro. Perché di fatto non si sforza neanche: Odin crede come un boccalone a tutto quello che dice senza nemmeno far finta di resistere. E quando arriva all’azione finale è l’attore stesso che non riesce a essere convincente sul perché di quello che fa, figuriamoci il personaggio!
Poche note visive interessanti, poca passione, poca forza narrativa. “O” pecca nel tradire tutti i punti di forza della storia da cui dovrebbe essere tratto. Un peccato mortale che lo condanna ad essere visto più come un prodotto televisivo di scarso valore. E dire che forse qualche intuizione poteva anche essere interessante, come il comportamento asettico dei protagonisti. Ma questa scelta avrebbe previsto una coerenza che in “O” non c’è.
| Voto (1/5): |  |
107 - Titus
Titus rappresenta una faccia della medaglia molto simile al Romeo + Giulietta di Baz Lurhmann. Riesce tuttavia ad esasperarne ed esagerarne sia i pregi che i difetti. E’ di certo affascinante l’uso estremo della simbologia nelle scelte di sceneggiatura, inquadrature, ritmi narrativi e scenografie (assolutamente meravigliose tutte le sequenze girate sulla scalinata dell’EUR a Roma, ma d’altronde nessuno deve insegnare a Dante Ferretti il suo mestiere). Tuttavia la mancanza di equilibrio è pericolosamente grave in larghi punti, scivolando ogni tanto nel pastrocchio senza ritegno.
Questi momenti sanno comunque essere ben limitati dalla notevole preparazione tecnica della regista di Frida e Across the universe. Non è la bravura con la macchina da presa a mancarle: gli altri suoi film fanno difetto di forza vitale al loro interno. Cosa che invece in Titus non avviene. Il testo di Shakespeare riesce a darle in ogni scena la spinta giusta alla riuscita, spinta che è recepita con tutta la sua potenza ma senza che sfugga, a parte le rare occasioni cui accennavo prima, il controllo sul progetto, che è della Taylor non di Shakespeare!
Alla fine di tutto questo baraccone espressionista la valutazione finale è la via di mezzo per un film che non ammette questo tipo di soluzioni. Di fronte ai supporters imperiali con le bandiere giallorosse e biancazzurre non si può rimanere indifferenti. O si scoppia a ridere o si apprezza questo solletico alla Roma che è stata, che è e che sarà. Io apprezzo.
| Voto (3/5): |  |
108 - Romeo + Giulietta
Seconda, e con buona probabilità migliore, opera di Luhrmann questo Romeo + Giulietta raggiunge quello che per me è l’apice delle possibilità che si possono esprimere in un riadattamento. Intendiamoci: i difetti ci sono, figli di una volontà fin troppo marcata di spingere il piede sull’acceleratore dell’espressionismo a tutti i costi. Ma se si riesce a venire a patti con il barocco della regia e della sceneggiatura ci si trova di fronte all’anima del remake.
Il remake è l’anima dell’arte. Il rifacimento, con stilemi ed espressioni nuove, è ciò di cui gli artisti da sempre si sono nutriti. Se Cezanne non avesse rifatto gli impressionisti, che rifacevano Courbet, allora non avremmo Picasso e Kandiskij, e saremmo ancora a guardare e rimirare le solite due versioni di crocifissi. Anche le nozze di Figaro sono un remake, e questo dovrebbe esaurire l’argomento. C’è ostilità nei remake e nei rifacimenti quando questi non aggiungono niente all’arte in generale, quando sono solo lo sfruttare un brand o un’immagine vincente. Ma impuntarsi contro il rifacimento in generale è miope e sbagliato, bisogna sempre valutare con attenzione, altrimenti si rischia di perdersi dei gioielli.
E questo film con Di Caprio lo è di sicuro. Viene mantenuta solo l’esplosiva espressività dei dialoghi originali. Ma tutto il resto cambia, tra pistole automatiche, cadillac e ville a Los Angeles. Non ci può che inchinare di fronte a un carattere così fortemente espresso, anche quando esso straripa oltre le sponde di ciò che gli sarebbe concesso. Così come ci si deve inchinare di fronte alla più bella (e adatta!) canzone mai scritta per dei titoli di coda… Ma di questo già vi eravate accorti sfogliando virtualmente questo sito, no?
| Voto (5/5): |  |
109 - Angels of the universe
In questo splendido film islandese, diretto dal Fridriksson protagonista di un simpaticissimo cameo in Il grande capo di Von Trier, è presentato forse il miglior dipinto cinematografico della follia. Una considerazione pesante, scaturita da come viene tinteggiato dal nordico regista il manicomio, tempio della pazzia. Normalmente tale luogo è fonte di oscurità e malattia, oppure viene visto in ottica parodistica e comica. D’altronde sono i due registri con cui vediamo i pazzi quando cambia il nostro punto di vista: se ne siamo direttamente coinvolti o se ne siamo solo spettatori. Fridriksson non usa né l’uno né l’altro colore: riempie questo manicomio di poesia.
I pazzi sono infatti angeli dell’universo, animi sensibili e ingenui, che vivono la loro passione con più forza di quanto sia conveniente fare. A prescindere che questa passione sia l’amore, la musica, la politica o altro. E quindi entra in gioco l’istituzione, che asseconda e reclude la forza della volontà di vivere con il sorriso con le labbra. Bisogna essere dentisti, non appassionati lottatori. I dentisti hanno belle macchine e soldi, le persone con un fuoco dentro solo sbarre e appartamenti vuoti. Anche se alla fine anche i dentisti possono impazzire e suicidarsi, ma l’importante è che non contagino il resto del mondo con il loro modo di vivere.
Poesia e fuoco interiore. Entrambi elementi trattati dal film e meravigliosamente sottolineati da una splendida colonna sonora interamente curata dai Sigur Ros. Che più pazzi e poeti non potrebbero mai essere.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
110 - I'm a cyborg but that's ok
C’era molta attesa da parte degli amanti del cinema orientale per questo film. La nuova fatica dell’autore del miglior film del XXI secolo, Oldboy, è di sicuro un evento da attendere. E a una prima occhiata si corre il rischio di bruciarsi con una grossa delusione: I’m a cyborg but that’s ok è una commedia, leggera e dai toni patinati, che nulla aggiunge (né in innovazione né in profondità) ai tanti film già visti dedicati al mondo dell’infermità mentale.
Questa delusione è da una parte inevitabile (non si può pretendere un Oldboy a ogni film) e solo apparente. La perfezione tecnica di Chan-Wook è pervenuta immutata negli anni, anzi! E’ evoluta secondo i binari tracciati da Lady vendetta e si può dire che formalmente Chan-Wook parla con un linguaggio solo suo personale, inimitabile, e traccia quella che diventerà necessariamente la poetica visiva del futuro prossimo. Un uso consapevole e funzionale della computer grafica nella storia, uno Scrubs senza gli stacchi sulle fantasie. E il suo non dire nulla di nuovo ma esprimerlo così bene è un esempio di perfetta rilettura postmoderna del tema della pazzia vista come fantasia e creazione di un mondo nuovo e magico.
E’ proprio il ribaltamento delle classiche prospettive il punto di forza eversivo del film. Non osserviamo più il malato dal di fuori, ma entriamo noi stessi in un manicomio a forma di disco volante. Vediamo quello che vedono loro, pensiamo quello che pensano loro. Che siano mitra che escono dalle mani, il ladro di emozioni o una coreana che sogna di fare lo yodel in Austria.
| Voto (4/5): |  |
111 - Don Juan DeMarco
Questo film proveniente dalla prima metà degli anni ’90 è un film ad uso e consumo di Johnny Depp e, probabilmente, della più frivola componente dei suoi estimatori. E’ la storia della “reincarnazione” del grande amatore Don Giovanni, intrappolato in manicomio per via delle sue folli fantasie che si rivelano, guarda caso, essere reali. E che viene curato da un brillante dottore che ha le fattezze nientemeno che del Don Giovanni del cinema: Marlon Brando. Impossibile non notare come l’allora ancora acerbo Depp volesse cogliere al volo un testimone lanciato dalla troppo stanca icona del cinema.
Fondamentalmente il punto debole del film, a parte l’operazione smaccatamente di marketing precedentemente esposta, è la sua mancanza di senso. La sceneggiatura è formalmente ben scritta e lascia ampio spazio ai sorrisi. Il problema è che il personaggio di Depp in realtà non è pericoloso per nessuno, né per gli altri, né per se stesso, né per la società. Non fomenta un’eversione, una visione alternativa della vita, niente. Fondamentalmente si ritrova in un manicomio solo perchè è scritto su di un copione. Perché altrimenti non poteva interagire col personaggio di Brando.
E’ proprio lo scivolone del rendere reali le fantasie improponibili di Juan a condannare in ultima istanza il film. Perché alla fine passa la morale che Juan non fosse realmente malato e tutti vivono felici e contenti perché rientrato, allegri e spensierati, nei canoni della normalità.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
112 - K-Pax
K-Pax è un film che appartiene al genere dei film piatti. Fa parte, per essere più precisi, dello stesso stile cinematografico del recentemente qui recensito Cuori in Atlantide. Sono tutte co-produzioni americane-x (dove con x intendo un’altra nazione a caso, in quel caso Australia, in questo Germania) costruite attorno a un attore di medio richiamo (lì Anthony Hopkins, qui Kevin Spacey) su una sceneggiatura piatta e senza guizzi, esattamente come la regia.
Il regista infatti pare non avere la minima intenzione, in nessuna delle scene che si susseguono, di mettersi davvero a lavorare. Gira più o meno bene quello che gli capita, senza soffermarsi troppo oltre al lavoro preventivato per quella giornata di riprese. Nessuna visione artistica, niente di niente (e dire che è un peccato perché qui Iain Softley in passato ha firmato graziose prove come Backbeat).
L’unico modo che film del genere hanno per piacere è quello di toccare per sbaglio nello spettatore dei nervi scoperti nella sua personalità. Ma non si può assolutamente delegare al caso, presente nella testa di chi vede, quello che invece dovrebbe essere progettato da chi scrive e/o dirige. E l’usare gli stessi ingredienti di Cuori in Atlantide non può che condannare questo film allo stesso esito: un piatto di pasta senza sale e senza sugo che può piacere solo a chi reputa il mangiare una mera sopravvivenza, una necessità da espletare ogni tanto.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (1/5): |  |
113 - Le regole del gioco
In questa coproduzione australiana non si può proprio dire che il centro del film sia il poker o il gioco d’azzardo. Il personaggio interpretato da Eric Bana è sì impegnato in scommesse e azzardi per tutto il film, ma non è la sorte ad essere combattuta. In realtà il gioco è solo un mezzo e non è trattato come molto altro. Non credo che sia un film in grado di appassionare davvero qualcuno che voglia trovarsi di fronte a una rivisitazione, ad esempio, di Rounders.
Cosa c’è allora in queste regole del gioco? C’è fondamentalmente una relazione padre-figlio. Argomento vecchio quanto e più del cinema, al quale questa pellicola ha veramente poco da offrire. Al tavolo verde infatti si scontrano due mentalità e concezioni opposte della vita: l’azzardo sbruffone che rischia tutto e il cauto meditare. Concezioni opposte solo perchè devono esserlo, perchè il padre è visto come ostacolo, nel senso atletico del termine: qualcosa difficile da superare per riuscire ad essere quello che si vuole essere.
Bizzarra la conclusione, forse buttata lì solo per cercare una sparata ad effetto. Rimangono le scommesse fatte col bel faccione di Bana, che danno un tono divertito e goliardico al film. Un’ora e mezza alla fine spesa piacevolmente, ma di cui dimenticarsi dopo poco.
| Voto (2/5): |  |
114 - Il passato è una terra straniera
Questo terzo film di Vicari, assieme a Velocità massima e L’orizzonte degli eventi chiude un tris perfetto di regine in quella che potremmo chiamare la trilogia della manipolazione. Se in Velocità massima si manipolavano i motori e nell’orizzonte degli eventi i dati di un esperimento scientifico qui tocca alle carte da gioco. Se Vicari ha un merito è di certo quello di aver trovato un tema intrigante e di averlo sviluppato ancora meglio senza mai riciclarsi o finire a usare soluzioni banali.
La domanda che questa volta pone è: se arrivasse un angelo a prometterti la vittoria in qualsiasi partita di telesina che cosa faresti? Il protagonista è un pragmatico, che sceglie di ripudiare le lettere del padre per scegliere la solida e sicura carriera di avvocato. Ma d’un tratto arriva questo dono: il dominio sul caso. Che senso ha quindi preoccuparsi di una professione solida? Che senso ha quando si possono manipolare carte, soldi e vite degli altri? Da qui comincia una strada fatta di bluff, la manipolazione tollerata della realtà, e bari, quella più rischiosa e remunerativa.
Comincia una strada fatta di soldi, nascosti come un cuore nei vecchi e vuoti polverosi libri di filosofia. Storia fatta di sesso, soddisfazione di tutti i propri istinti, e violenza: l’esplosione inevitabile e intollerabile di quando il potere di manipolare non trova un freno: di mezzi come in velocità massima o dell’onestà degli altri come nell’orizzonte degli eventi. Vicari raggiunge uno stile personale e lontano da ciò che ci si aspetterebbe, nel suo film forse più convenzionale, ma tecnicamente meglio realizzato.
| Voto (4/5): |  |
115 - Maverick
Questo film può essere giudicato, nei suoi meriti e nei suoi difetti, sapendo semplicemente che ha come protagonista Mel Gibson (o, per essere più precisi, “divo hollywoodiano a caso coinvolto nella produzione del film”). Perché a partire da questo semplice dato si sa che tutta la pellicola sarà quasi certamente un paio d’ore di one man show.
Show che può anche essere divertente. E Maverick lo è senz’altro, complice una sceneggiatura dotata di un umorismo piuttosto banalotto ma comunque in grado di strappare qualche sorriso. E complice soprattutto la regia esperta di Donner, che ha al suo attivo qualche errore vergognoso, ma che non si può certo considerare come il primo venuto. Il problema è che il film pecca e crolla miseramente sulla struttura portante principale di un film di poker, di sfide, di contrasti.
In questo film esiste solo Mel Gibson. La telecamera ruota attorno a lui e a nessun altro. E’ indiscusso che lui sia il migliore, non importa chi ha davanti (personaggi di profondità parti alle carte che hanno in mano). Se perde è solo perché ha un piano, se vince è ordinaria amministrazione. Detto questo: dov’è il pathos? Dov’è la sfida? La scoperta dei propri limiti? Da nessuna parte: Maverick non vuole essere altro che le piccole battute presenti qua e là nella sceneggiatura.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
116 - Fat Choi Spirit
Fat Choi Spirit è, prima di tutto, una giocosa parodia della filmografia epica e nazionalista cinese à la C’era una volta in Cina e Fist of legend. Vista con questi occhi, o anche con i semplici occhi che hanno bisogno di una leggera e frizzante commedia quasi romantica, non si può non apprezzare questo paradossale ruotare della trama attorno al mahjong. Gioco che assurdamente si innalza a metro di vita di un intero gruppo di persone, fino ad arrivare addirittura a materia di insegnamento nella fantastica scena finale.
E allora attorno alle estenuanti e adrenaliniche partite con i tasselli di legno si crea un mondo intero. Il gioco è lo sfondo in cui avvengono battaglie e rivincite, amori e svago, in un turbine di personaggi che attorno al mahjong mettono ognuno la propria parte di vita.
Inutile attendersi chissà quale profondità o significati di fronte a questo colorato lungometraggio. Johnnie To infatti ci abitua ad essere uno dei volti più importante della new wave poliziottesca di Hong Kong, con il pregevolissimo Exiled (miglior film del 2006), ma sa essere capace, assieme a Ka-Fai Wai, di non prendersi troppo sul serio con divertenti e spensierate commedie come questo Fat Choi Spirit o My left eye sees ghosts.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
117 - 300
Outsourcing è allocare la propria forza lavoro lontano dalla sede dell’azienda per sfruttare una manodopera a costo inferiore o altri poco chiari vantaggi. E l’esercito persiano che approcciava le Termopili, composto da battaglioni provenienti da tutte le parti del vastissimo impero, ne era di certo un antico e perfetto esempio.
Tutti sappiamo come è andata a finire. Perchè se sei a capo della più importante e vasta multinazionale dell’epoca se vuoi fare outsourcing devi anche mettere a capo dei vari reparti qualcuno con la testa sulle spalle, che sappia maneggiare tutta questa differenza culturale. E invece no: è tutta un’orgia di oro e sensualità dall’inizio alla fine. Voglia di lavorare saltami addosso, se la volessimo tradurre in termini moderni.
Non c’è alcun attaccamento al branding dell’impero persiano, nessuna visione della mission di Serse. Si nota subito che c’è qualcosa che non va. Di tutt’altra pasta è il reparto di gestione umane di Sparta: crudele certo, ma che non corre il rischio del poco attaccamento ai valori aziendali. 300 in questo è efficientissimo a rappresentare le insidie dell’outsourcing e lo fa in maniera stilisticamente intrigante ed efficace, utilizzando la metafora della battaglia alle Termopili che è inusuale per un film che parla evidentemente della new economy.
| Voto (4/5): |  |
118 - Star Wars
Partiamo subito a bomba con la domanda che chiunque cova nel suo animo fin dalla visione della trilogia di Star Wars: come CAZZO si fa a perdere quando hai dalla tua un’arma come la Morte Nera? Come si fa a perdere quando hai esoscheletri bio-cazzo-tronici e pistole e spade laser e combatti contro gli Ewok, un branco di nanacci pelosi rimasti ancora ai pietroni e alle fionde? Chi diavolo ha costruito quel condotto d’emergenza che pare aver un cartello con su scritto: “Luke per di qua”?
E’ evidente la risposta: non puoi ottenere nessun vantaggio da uno strumento superiore se nessuno la sa usare davvero. Prendi l’inseguimento nella foresta: se sfrecci a trecento all’ora in un bosco forse guardare indietro non è esattamente l’idea migliore che puoi avere. A onor del vero bisogna dare atto che anche le visiere a specchio nere non aiutano molto nella visibilità. Insomma: il caro Darth Vader dovrebbe trovare disturbante, più che la mancanza di fede, la mancanza di uno specifico e accurato training del personale.
La metafora scelta quindi da questo ritorno dello Jedi è sicuramente efficace, perchè presenta una situazione estrema in cui il training del personale fa tutta la differenza. Tuttavia è veramente troppo estrema, nessuno può mai crede che gli Ewok, in qualsiasi universo essi siano, possano avere la meglio su qualcosa di più evoluto di un tricheco. (Chiudo con un video non tratto dal film, come di consueto, ma tratto da Clerks, che sottolinea un altro punto importante riguardante la Morte Nera).
| Voto (3/5): |  |
119 - Rocky 4
Ci sono aziende che solo su fortunate e azzeccate scelte di marketing e di branding si sono guadagnate il loro successo. Prendete il logo della Coca-Cola: uguale da decadi e sempre affascinante, probabilmente l’unica vera ragione del suo successo nelle bevande analcoliche. Un altro grandissimo logo su campo rosso è l’ormai tramontata, ma sempre affascinante, falce e martello.
Gli anni ’80 erano proprio un bruttissimo periodo per le aziende che volevano giocarsi tutto nel settore della conquista del mondo. C’era un terribile duopolio che lasciava fuori le grandi startup come la Cina o le piccole-medie imprese a conduzione familiare come il terrorismo islamico, aziende che ora si sono affermate in pieno. Questa battaglia di marketing senza esclusione di colpi si è combattuta metaforicamente sul ring di Rocky IV. Apollo Creed rappresenta l’America mollacciona dei negri che ha perduto la sua pura integrità nella santa lotta al comunismo, un colosso apparentemente imbattibile, ma dotato di un reparto di gestione delle risorse umane francamente discutibile.
Rocky infatti restituisce all’America la sua purezza e umiltà di scelti da Dio. E i suoi travolgenti bermuda a stelle&strisce (ho già detto che amo gli anni ’80?) fanno troppa presa sulla base del Partito, che si schiera dalla sua parte in un twist assolutamente imprevedibile (?). Non si può pensare di conquistare il mondo se la tua manodopera non è sufficientemente attaccata a un brand così ben pensato ed espressivo. Pollice verso per il comunismo.
| Voto (4/5): |  |
120 - Independence day
Non può esistere azienda nel ventunesimo secolo senza una robusta spina dorsale informatica. L’intranet aziendale è più di uno strumento: è il respiro del lavoro d’ufficio. Come si potrebbe giustificare altrimenti la presenza di un computer per ogni addetto? Oltre alla ragione vera della presenza del macchinario infernale ovviamente: Facebook, Msn e solitario.
Si capisce quindi che una intranet mal progettata è più di una tragedia per una grande impresa: è la morte. Prendete l’esempio di Independence day: abbiamo di fronte la più efficiente ditta di rottamazione di pianeti mai vista. Più efficiente dei Vogon della Guida galattica per autostoppisti. Nulla li può fermare, perfino Will Smith (il che è tutto dire!). Eppure… Eppure probabilmente la ditta informatica a cui si sono affidati non era molto seria. Com’è possibile che un computer alieno si faccia mettere in scacco da un virus programmato.. su un Mac?! Santo cielo: nemmeno i Mac sulla terra hanno problemi di virus!
La morale che ne traiamo è: mai mettere un firewall fuori dalla tua astronave. Mettilo dentro. Sempre.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
121 - Matrix: Reloaded
Difficile trovare qualcuno che non ha visto la trilogia di Matrix e tuttavia è ancora molto interessato a scoprirla, eppure devo avvertire che questa recensione verte sul principale twist della trama. Prima di far partire lo spoiler però una considerazione generale: Reloaded soffre degli stessi problemi che accennavo nella variazione sul gioco d’azzardo per Maverick. Inserirsi nel contesto dell’eterno ritorno prevede la ciclicità, la parità, la negazione dell’Eroe Unico e Solo in grado di salvare e redimere. Matrix non ne è capace. E chi non l’ha ancora visto si fermi qui.
Perchè la soluzione trovata è molto interessante. Un mondo organizzato alla perfezione, in cui anche le anomalie irrazionali sono perfettamente tenute sotto controllo grazie alla ciclica prevedibilità dell’uomo. Un mondo in cui la ribellione stessa fa parte della routine ed è amministrata con cinica previsione. Per parafrasare gli Afterhours: “… e fa rivoluzioni che non fanno male / così che poi non cambi mai / essere innocui insomma che sennò è volgare”.
Mi piace e mi intriga questo dialogo surreale nella stanza delle televisioni. Che mi rende Reloaded tutt’altro che un episodio completamente malriuscito. Il problema è che non riesce andare fino in fondo. Anzi: questo interessante spunto è totalmente negato. Come in Maverick quindi esiste un unico protagonista, un Eroe, che da solo può dominare il caos indominabile, in quanto è figlio di quello stesso caos. E questo è infantile e assurdo.
| Voto (2/5): |  |
122 - Izo
Miike è un regista geniale. Perchè totalmente imprevedibile. La sua sterminata filmografia è un caleioscopio di generi, budget e stilemi espressivi. Ed è molto più imprevedibile di un classico regista anarchico giapponese, perchè in fondo il gore estremo, il soft hentai e quant’altro si possono prevedere. Miike no. Miike passa da questo a un classico yakuza movie, da un western ad alto budget come Sukiyaki Western Django a questo Izo: un film d’autore con la A maiuscola.
Izo è un film dannatamente difficile. Molto più del lynchiano Gozu, che alla fine di tutto può essere interpretato con la facile scorciatoia del sogno. Izo sta a un livello superiore. Un samurai costretto a viaggiare eternamente attraverso il tempo per seminare la sola cosa che sa fare: morte e distruzione. Una vita che si consuma attimo dopo attimo fino all’inevitabile conclusione, una crocifissione sanguinosa e filmata con un occhio di rara potenza.
Alla fine il suo eterno ritorno non è altro il tormento che impedisce alla sua essenza di portare a termine il suo scopo. Il suo karma (uno dei tantissimi rimandi alla cultura orientale di cui questo film è pregno) deve essere equilibrato e solo la sua pura essenza di distruzione può farlo. Una pura distruzione che cala come una scure su chiunque, a prescindere da quale sia la sua forza, la sua ricchezza, la sua integrità.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
123 - The sky crawlers
Chi si appresta alla visione di un film di Oshii sa a cosa va incontro. E soprattutto è un intenditore, dato che il buon Mamoru è uno dei migliori registi viventi, in grado di mescolare con rarissima maestria l’azione mozzafiato a lunghe e calme sequenze affascinanti, la capacità tecnica all’avanguardia a ostici e profondi passaggi di sceneggiatura. Questo Sky crawlers non è da meno in nessuno degli aspetti. Da notare fino in apertura come l’integrazione che Oshii sta meditando tra animazione classica e computer grafica raggiunge risultati più maturi e stilisticamente unitari del precedente Ghost in the shell 2.
Ma è la struttura a inesorabile spirale della trama a catturare maggiormente. La vicenda è infatti incastonata in un non meglio precisato futuro della nostra cara Terra in cui due misteriosi fazioni si combattono per il dominio dei cieli. Tale guerra è eterna e si ripete uguale a se stessa da molto tempo, fin nei minimi dettagli. E il fatto che si svolga nei cieli non è affatto un caso: è sempre lì presente e immanente nella vita dei cittadini, ma mai realmente tra loro. E’ la presenza televisiva in assoluto dominante, eppure viene combattuta da piloti che solo in apparenza sono umani.
I rimandi al nostro piccolo mondo sono evidenti. Come evidenti le implicazioni di un conflitto mantenuto ad arte in equilibrio per imbrigliare menti e preoccupazioni su qualcosa di altro, su cui nessuno può farci nulla perchè al di fuori del controllo. Non c’è quindi spazio per eroi o imprevisti: tutto è deciso e stabilito, come l’ineluttabilità di un leopardo nero, nemico invincibile ma al contempo incapace di vincere.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
124 - Jason X
Perchè includere un evidente film fracassone e ignorante in un contesto di recensione che fa del garbo filosofico la sua forza? Perchè permette di vedere con un occhio malizioso qual è il vero concetto dell’eterno ritorno inscritto nella filmografia di consumo americana. Com’è facile intuire dal titolo infatti questo è ben il decimo episodio della fortunata serie Venerdì 13 che ha dato i natali a una delle classiche maschere dello slasher a stelle e strisce: Jason Voorhees.
Perchè eterno ritorno? Perchè ogni episodio è sostanzialmente identico al precedente (e identico a molte altre altrettanto longeve serie horror). Ogni episodio cade negli stessi errori e consolidati clichè che rendono questi film una vera e propria piaga. Il fascino di una maschera come Jason infatti sta nella sua mole colossale e inarrestabile, una macchina irrazionale in grado solo di uccidere. E allora che senso continuano ad avere degli escamotage che potevano andare bene negli anni ’80 del silenzioso mostro che coglie di sorpresa il malcapitato idiota protagonista? Jason non può e non deve esserne capace, non deve puntare su quello, rende tutto un’ennesima ripetizione scontata e noiosa.
Ma è questo l’eterno ritorno consumista: la riproduzione pedissequa di ciò che è in grado di provvedere a un (eterno) ritorno economico, fornito con cortesia da un appassionato senza fantasia che vuole essere servito con la solita minestra riscaldata. O magari da un novello spettatore ancora inconsapevole di ciò che va a vedere.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
125 - C.R.A.Z.Y.
Un film che riesce a parlare di accettazione della propria unicità e diversità senza scadere in facili morali preconfezionate su pace e tolleranza? Eccolo qua: questo C.R.A.Z.Y. canadese compie un piccolo miracolo. Riesce a tracciare un sofferto cammino interiore che passa attraverso le classiche fasi mentali (“Sono io ad essere sbagliato?”, “E’ il mondo a esserlo?”, “Che si fotta il mondo!”, eccetera).
E tale cammino viene universalizzato dalla macchina da presa di Vallée con un talento inaspettato. Fatte le dovute proporzioni, in C.R.A.Z.Y. si nota un maturo e visionario utilizzo dell’effetto speciale paragonabile a quello di un Chan-Wook in I’m a cyborg but that’s ok (paragoni pesanti quindi, mica pizza e fichi). Suggella questo paragone una delle più riuscite e memorabili scene del film: l’innalzamento al tetto della chiesta nella notte di Natale sulle note di Shympathy for the devil dei Rolling Stones.
E se il percorso interiore è fatto di dolore e sofferenza, Vallée non si dimentica mai il fatto che in fondo dietro tutte le piccole tragedie imposte dall’esterno (e l’omosessualità lo è) non c’è solo dolore, ma anche tanta ironia e voglia di vivere. Ironia che viene sbattuta in faccia all’odio ipocrita di chi vorrebbe condannarti per non si sa bene quale reato. Ironia espressa mediante alcuni scambi di battute sferzanti e una coloratissima fotografia.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
126 - Improvvisamente l'inverno scorso
Di questo curioso documentario italiano nato da PACS, DICO e quant’altro è venuto dopo c’è molto da dire. Iniziando probabilmente da quella che mi è sembrata l’idea più intelligente che ha avuto. In pratica il documentario racconta una storia, quella dei suoi registi, nella loro indagine sulla regolamentazione delle coppie di fatto. Indagine che li riguarda molto da vicino. E la cosa migliore del film è quello di creare fondamentalmente due personaggi: il personaggio che ha voglia di libertà alla luce del sole e il personaggio che sceglie il ghetto, il fare le cose nascosti e in privato. Due mentalità attraverso cui i perseguitati ingiustamente spesso si trovano a oscillare, prima di capire quanto l’autoghettizzazione sia una subdola arma in mano a chi opprime (vedi Milk).
Non so quanto sia frutto di un’operazione studiata quanto più dei caratteri naturali dei due membri della coppia. Sta di fatto che questa scelta è un motore per la vera messa in discussione dell’omosessuale. Messa in discussione aperta e onestissima, visto l’enorme spazio concesso alle opinioni contrastanti, a coloro che non la pensano come gli autori. Un’onestà francamente rara in opere sul filone del documentario a tema modello Roger & me.
Cos’è che non va in questo film? Fondamentalmente non riesco a capirlo eppure qualcosa di sbagliato c’è. Forse le modalità distributive, forse il suo pubblico. Perché se negli intenti questo film cerca una sorta di neutralità, un dialogo, nei fatti tutto questo non avviene. Continua a essere visto in cinema nascosti, ha un pubblico di quasi soli omosessuali che riescono solo a sbertucciare l’immagine del papa. E francamente questo mi sembra un peccato.
| Voto (3/5): |  |
127 - Sommersturm
Finalmente riesco a far uscire una recensione di un film perfettamente in tema con il periodo dell’anno che stiamo passando. Perché questo Sommersturm altro non è che quello che descrive il suo titolo: una tempesta estiva. Una di quelle cattive, che ci va giù pesante con acqua, tuoni e fulmini, ma che dura poco e lascia ancor meno conseguenze. Una tempesta che nasce dal non voler più nascondere la propria diversità e i propri sentimenti verso colui che fino ad ora è stato un “amico”.
Scenario di questa tempesta è un campeggio estivo e una gara di canottaggio. La giovanissima carne fresca che anima la vicenda sa essere sincera e onesta, così come Kreuzpaintner, il regista. E’ inutile infatti continuare ancora oggi a voler presentare l’omosessuale perfetto, privo di difetti e macchia, per indurre il pensiero che sia da accettare. Perché francamente ci se ne fa l’idea opposta, una specie di ente che continua ad essere diverso e staccato dalla normalità. Meglio scegliere la via di Sommersturm: i ragazzi omosessuali sono prima di tutto ragazzi, quindi sciocchi, immaturi, poco svegli.
E tanti luoghi comuni, che se sono nati un motivo ci sarà. Tanta ironia nei gay che affettano cetrioli, nelle battute sporche, nelle botte prese dai “veri uomini”. E anche tanta personalità visiva, con almeno un paio di scelte sicuramente memorabili (vedi il tuffo nel nero di uno dei protagonisti).
| Voto (3/5): |  |
128 - Mysterious Skin
Se si comincia a guardare questo film avendo alle spalle, come ha fatto il sottoscritto, solo la visione di The doom generation di Gregg Araki forse si parte prevenuti. Forse solo un pochino. Diciamo che si sarebbe ben disposti a bocciare qualsiasi altro film di Araki sulla fiducia. Ci si sbaglierebbe alla grande. Mai e poi mai mi sarei aspettato tanto garbo e leggerezza da un regista come il buon Gregg, che però in questo caso riesce decisamente a stupire.
Il suo film è esplicitamente fin dall’inizio diviso in due parti, rappresentate dai suoi due protagonisti. Il momento in cui queste due parti si dividono è quello di un trauma. Le risposte a questo trauma sono diametralmente opposte. Da una parte c’è Neil, con la sua accettazione totale e sregolata di ciò che gli è accaduto. Accettazione che lo fa letteralmente innamorare di quel trauma e lo porta a vivere la sua vita nel costante rischio di ripresentarlo di fronte alla morte e alla violenza. Dall’altra c’è Brian, la rimozione totale, la costruzione di un castello di fantasie per opprimere quella stessa morte che gli cresce dentro giorno dopo giorno.
Ma alla base della rimozione totale sta sempre la voglia di conoscere e capire quel buio che rimane dentro alla tua anima. E’ necessaria una mediazione e un’interazione tra questi due estremi che possa riportare entrambi a poter vivere con maggiore serenità la loro condizione. E tutto ciò avviene nel bellissimo finale, con un monologo del personaggio di Neil da magia della sceneggiatura. E con un sottofondo musicale perfetto, che sfuma dalle canzoni natalizie a Samskeyti dei Sigur Ròs, che rivaleggia con l’Exit music di Romeo + Giulietta nella classifica delle più adatte ed evocative canzoni di chiusura di un film. Finale che qui riporto e che è quindi meglio non guardare se ancora non avete visto il film.
| Voto (5/5): |  |
129 - Frida
Julie Taymor ha sicuramente molto in comune con la pittrice che ha scelto di ritrarre in questo film. Si potrebbe ben ipotizzare, se si conoscesse la regista, che questo lungometraggio vuole essere la trasposizione su pellicola di un autoritratto. E proprio nella metafora a più livelli di questo particolare tipo di quadro credo che stia, nel bene e nel male, la chiave di lettura del film.
Farsi un autoritratto parlando di una pittrice è un’elegante e intrigante provocazione a scatole cinesi. Molto audace, in larghi tratti del film ma soprattutto della sua carriera, la Taymor scivola in alcuni difetti che prima che imperdonabili sono quasi incredibili. Vedere la altre sue opere (Titus recensito su Five Obstructions, ma anche Across the universe) è sottoporsi a un trip colorato e allucinato di cinema. Colori saturi, scene oniriche, visioni potenti. A volte troppo, a volte pacchiane, ma sempre fortissime e personali.
Tutta questa forza e questa personalità in Frida svanisce come neve al sole. Il film innegabilmente è ben costruito, canonico, senza evidenti difetti. Ma anche senza pregi. Proprio come se la Taymor nel volersi per forza rispecchiare in Frida avesse anche limato gli spigoli del suo espressionismo. Forse perchè si voleva vedere bene, nitida, senza sbavature. In maniera “classica”. Ma, di questi tempi, ciò si traduce in banale, privo di forza vitale.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
130 - Il mio piede sinistro
La vita di un uomo nato quasi completamente paralizzato ad eccezione del suo piede sinistro e che con questo solo piede sia riuscito a diventare pittore e poeta è sicuramente una sfaccettatura della storia dell’uomo che merita una rappresentazione artistica e, più ancora, interessantissima. Quello che a mio avviso condanna il film di Jim Sheridan è il fatto di rimanere schiacciato sotto l’enorme mole di questo interesse smisurato e fuori da proporzioni gestibili al regista irlandese.
Il film ben interpretato da Day-Lewis (la cui prova richiama quella assolutamente magistrale di Moon So-ri in Oasis) viene infatti schiacciato dalla storia che lo ispira. Non riesce a farne un ritratto artistico perché la vuole comprendere tutta, senza rendersi conto che è troppo grossa. E quindi non c’è più spazio per l’arte, in questo piede sinistro, ma solo per l’irlandese cocciutaggine del suo protagonista. Diventa quindi la storia di un uomo forte e caparbio, ma senza comunicare alcun fuoco emotivo.
Eppure un modo per trattare con più arguzia e arte una situazione del genere, basti pensare a Lo scafandro e la farfalla. Julian Schnabel non deve rappresentare un artista, eppure trova una combinazione magica di ricordi, idee di regia e scene oniriche che rendono giustizia al tema dell’uomo intrappolato nel proprio corpo. Cosa che Sheridan non fa, ed è un peccato.
| Voto (3/5): |  |
131 - Modigliani
Questo film di Mick Davis fa parte del nutrito gruppo di pellicole che prendono il loro nome e qualche aspetto della biografia di quel nome e ci costruiscono una struttura che con il nome scelto ha poco o nulla di che spartire (Piano, solo?). E’ così questo film che in italiano ha il sottotitolo de “I colori dell’anima”: un film di genere i cui personaggi invece di chiamarsi Pinco Pallino e Asdrubale Pansa si chiamano Amedeo Modigliani e Pablo Picasso.
Il film si inventa particolari poco attinenti alla vera vita di Modì, come ad esempio la sua rivalità con Picasso e i cubisti in generale. In realtà il pittore/scultore livornese era dotato di un estro e una sensibilità assolutamente unica per l’epoca, che lo portava ad essere completamente isolato sia da alleanze che da diatribe sull’arte sua contemporanea. Di trovare in questo film scialbo particolari del fuoco che bruciava dentro a Modì, della sua follia nel ritratto che portava a imprimere sulla tela l’anima di chi gli stava davanti, nemmeno a parlarne.
Tutto ciò che rimane è la storia di un giovanotto estroso che si destreggia tra atelier e modelle a Parigi. Se avesse avuto cinque anni di meno sarebbe sembrato un film su un ragazzetto in Erasmus in Francia, una versione di inizio secolo de L’appartamento spagnolo. Un po’ poco per Modigliani, non trovate?
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
132 - Andrei Rublev
Tutto si può dire del cinema di Tarkovskij tranne che non sia affascinante e fonte di ispirazione su se stessi. Andrei Rublev non fa eccezione. L’unico aspetto che in apertura voglio considerare come unico difetto del film che non lo fa arrivare alle vette di Solyaris o Stalker è la linea narrativa scelta. Il rappresentante di icone sacre è certamente un elemento stupendamente profondo e sfaccettato nelle sue interpretazioni, ma risulta meno affascinante per lo spettatore finale rispetto alle idee esplosive dei due film citati.
Sorvolato questo insignificante particolare si può notare come tutto questo film russo sia un inno all’amore per l’arte. Ma non solo: un inno a tutto ciò che possono fare le mani dell’uomo con amore, che sia artistico o meno. Un amore che migliora il mondo e lo rende un posto ancora più umano. E così la crisi mistica di chi si vuole ritirare dal mondo negandogli la propria arte viene ravveduta dall’ingegno di chi senza alcuna esperienza o competenza, il fanciullino, riesce a regalare a quello stesso mondo un’opera mastodontica e carica di genio, la campana.
O ancora l’affascinante sequenza iniziale, apparentemente slegata dalla linea narrativa principale, dedicata all’antico sogno del volo dell’uomo. Un film che insegna quindi a trascurare i propri piccoli capricci e il nostro elevarci di un gradino al di sopra di un mondo che consideriamo “sporco” o “crudele”. Il mondo è abitato anche da noi. Ed è nostro preciso compito renderlo giorno dopo giorno meno sporco e crudele. E non è con finti culturalismi elitari da intellettuali nella propria torre d’avorio (Le invasioni barbariche) che lo si può fare.
| Voto (4/5): |  |
133 - Six degrees: Pilot
Curiosamente questo telefilm caratterizza la variazione delle reti sociali nella sua nascita e nella sua morte con la figura di J. J. Abrams. Di questa “mente brillante” a cui vengono affidati cult di questo inizio secolo (Lost), complesse operazioni di viral marketing (Cloverfield) o riletture di marchi morti e sepolti (Star Trek) vedremo una rappresentazione reale ed efficace nell’ultimo film del lotto. Ora concentriamoci su questo pilota.
A ben vedere in questo pilota e in questa serie c’è tutto di J. J. Abrams. C’è Lost senza il fascino misterioso e sovrannaturale, ma con i complessi e noiosi incroci nelle vite dei personaggi. C’è Cloverfield senza il mostro che distrugge tutto, ma con la solita banale visione dei seducenti “newyorkers” troppo affascinati dal voler per forza essere qualcosa di speciale da non rendersi conto di non esistere nemmeno. C’è Star Trek senza il coraggio di un reset in grado di destabilizzare ciò che sembrava inamovibile, ma con un branco di bambocci inutili dalla parte sbagliata della macchina da presa.
Insomma: c’è tutto il peggio del peggio di Abrams. Perfino bravi professionisti, come Giacchino alle musiche, sembrano completamente impazziti, regalando prestazioni di rara maestria del brutto. Esempio paradigmatico è il primo fintissimo piano sequenza con un terribile voice over in apertura: quanto di più scontato e pacchiano possa essere girato. Infine lasciatemi lanciare un appello al buon protagonista Jay Hernandez: rimani a fare i vari Hostel, nulla potrà riuscirti meglio di quello.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (1/5): |  |
134 - Connected
Fare un documentario informativo è una missione. Lo scopo è quello di illustrare qualcosa, fare in modo che gli spettatori la conoscano e possano farsene un’idea loro propria dovuta ai fatti presentati (tutto un altro campo da gioco è il documentario artistico alla Herzog, ma sto divagando). Sono sempre stato particolarmente ostile alla moda del documentario d’autore statunitense alla Michael Moore (Fahrenheit 9/11), gradisco di più brillanti esempi alla Workingman’s Death in grado di non esprimere una tesi da sposare, ma solo visioni.
Connected fa parte di quest’ultima tipologia di documentari. E’ una scelta difficile, perché finché si sostiene una tesi si ha comunque il facile appoggio di chi la pensa come noi. In Connected non c’è una tesi, dunque deve affascinare con immagini, parole ed evocazioni nella mente dello spettatore. E il documentario della Talas non è in grado di farlo.
Primo perché i concetti più affascinanti sono esposti con le soluzioni più banali che possono venire in mente (documentare la spedizione dei pacchi per verificare i sei gradi di separazione? Bambinesco e inutile). Secondo perché momenti topici ed emozionanti per chi ha studiato, come me, le reti sociali sono rappresentati cripticamente: Watts che disegna lo schema dello Small World alla lavagna a me suscita brividi lungo alla schiena, ma per chiunque altro è un tizio che scarabocchia palline e linee. Connected non è quindi in grado di catturare e far conoscere che cosa di veramente esplosivo c’è dietro a ciò che all’apparenza possono sembrare le superficiali pagliacciate di Facebook.
| Voto (1/5): |  |
135 - The Nines
Nelle reti sociali esiste un fenomeno chiamato “power law degree distribution”. In parole povere significa che chi ha molte conoscenze ha una probabilità molto più alta di incontrare e conoscere nuove persone rispetto a tutti gli altri. O, per dirla ancora in un altro modo, “piove sempre sul bagnato”. In un certo senso questo film ne può essere una espressione molto particolare.
Tutto il film è incentrato su un protagonista, che si ritrova in situazioni e personalità diverse: attore fallito di Hollywood, sceneggiatore o programmatore di videogiochi. E vari elementi nel film, che cerca di costruire un’atmosfera misteriosa e surreale, cercano di ricordargli in continuazione che lui non è una persona come le altre: lui fa parte dei nines, i nove. Lui non è come gli altri. Fa parte di questo misterioso picco di fortunati, che possono avere tutti e tutto e sembrano non avere limiti a ciò che possono fare.
Le idee che stanno alla base della pellicola non sono affatto male. In diverse mani avrebbero potuto dare vita a un gioiellino del mistero a basso budget come può essere un Primer. Ma la realtà non è stata così gentile con The nines. La regia è qualcosa di assolutamente televisivo, il regista non pare avere né un comparto tecnico all’altezza, né la furbizia di saper ovviare a questo problema. Anche in fase di scrittura August sa di essere bravo (suo ad esempio è lo screenplay di Big Fish), ma non ha nessun controllo e nessun freno e le sue soluzioni finale suonano bambinesche e non attentamente meditate. Vuole stupire a tutti i costi e si ritrova ad essere infantile.
| Voto (2/5): |  |
136 - Sei gradi di separazione
Film legato a doppia mandata con la variazione sui Social Network, questo Sei gradi di separazione va notato soprattutto in quanto è legato al mattatore della variazione: J.J. Abrams. Tutti ne lodano il talento produttivo, come un novello re Mida riesce a rendere oro tutto ciò che paga. Ma è tenerissimo il personaggio che interpreta in questo film: l’ottuso e iracondo figlio di uno dei protagonisti principali, vero esempio di quale sia la reale caratura del personaggio.
Cosa sono alla fine i “sei gradi di separazione”? Sono protagonisti di uno dei più influenti falliti esperimenti della storia. Nel 1967 Stanley Milgram (non) dimostrò che ogni persona è divisa da ogni altra nel mondo da sole sei consocenze: tu devi contattare solo sei diverse persone per raggiungere me, Obama, un barista iraniano, un barbone argentino o Sasha Gray (corri!). E’ in realtà qualcosa che esiste, più o meno, davvero, ma di certo l’unico merito di Milgram fu di intuirla.
E’ anche un concetto che affascina la maggior parte delle persone che ci pensano. E che acquisisce subito le caratteristiche di una storiella divertente da raccontare a una cena di gala. Che è in fondo quello che fa questo film. E’ la cena di gala del cinema: completamente raccontato e mai recitato, popolato da ricchi boriosi che vogliono disperatamente sembrare simpatici o brillanti, ma dispensano solo odio e sbadigli (come ne Le invasioni barbariche).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
137 - Boccaccio70
Registi del calibro di Fellini, Visconti, De Sica e Monicelli si uniscono con il dichiarato scopo di creare un Decamerone dell’italianità moderna, un intreccio di satira, morte, serio e faceto che si mescolano assediati dalla peste della grigia monotonia degli anni ’60 italiani. Un esperimento che in realtà esperimento non è visto che viene dopo molti altri progetti simili, ma che pur contando nomi pesantissimi non riesce a convincere fino in fondo.
Particolarmente l’episodio di Visconti rappresenta tutto il male di questo tentativo. Il cinema di Luchino infatti è da sempre improntato nella ricerca del marcio all’interno della nobiltà del vapore e della forza lavoro: l’alta borghesia potente e annoiata. Ma se questo filo conduttore ha dato a opere come Il Gattopardo una forza espressiva più unica che rara, qui lo scenario desolato di poesie scadenti e camere da letto annoiate non può che trasmettersi senza alcun metabolismo allo spettatore, annoiato anch’esso dalla boria che gli viene proposta.
Di tutt’altro stampo e verve è l’episodio migliore del lotto, senza dubbio quello di Fellini, con un Peppino De Filippo che riesce ad esprimersi finalmente a livelli eccellenti senza per forza dover cadere nell’ombra di Totò, senza dover per forza essere un comprimario da mettere prima dell’“e” come in Totò, Peppino e la malafemmina. Fellini dipinge magistralmente il bigottismo che non vuole guardare in faccia a sé stesso e contemporaneamente trova invenzioni visive e comiche portentose, da vero genio del cinema (al livello, se non superiori di 8½). E ricordate di bere più latte, il latte fa bene a tutte le età.
| Voto (4/5): |  |
138 - Le streghe
Un film episodico tutto dedicato alla metà più dolce del cielo, per esordire con eufemismi triti, ritriti e di pessima fattura. Metà che si scopre, o si vuole far vedere, per le sue caratteristiche senza dubbio meno dolci. Una versione femminile dei mostri che mette alla gogna la vanità, l’accidia e il velenoso rancore che vengono covati dietro lunghe ciglia al mascara e un velo di finta amicizia femminile.
Anche in questo caso se si vuole prendere un esempio negativo bisogna andare a scovare un corto tutto borghese e annoiato. Con un quasi inedito Clint Eastwood, la strega della vanità, della moglie insoddisfatta dalla passione del marito che prova a far carriera, risulta presto noiosa e irritante. Anche se messa alla gogna con insolita cattiveria, non si riesce mai a divertirsi realmente, ad esempio, nell’immaginaria parata dei pretendenti. Si riesce solo a infastidirsi. E vedere Clint vestito da cowboy in una delle innumerevoli fantasie alla Scrubs non può che suonare posticcio.
Di tutt’altro calibro invece l’esplosivo corto di Pasolini, che dirige Totò al meglio delle sue possibilità, superiore perfino al sublime Uccellacci e uccellini. Assieme a Ninetto Davoli mette in piedi un duo pieno di italianità esplosiva e inarrestabile. E’ una fotografia che fa paura per quanto vera, ma che sa dissacrare tutto e tutti con la risata satirica più devastante per i veli di ipocrisia dell’”Italiano brava gente” di milioni di pagine di saggi, filosofi e tromboni. Un corto che riuscirebbe da solo a far valere la visione dell’intero film perfino se il resto della pellicola fosse completamente nera e muta.
| Voto (3/5): |  |
139 - I nuovi mostri
I nuovi mostri è un film episodico del 1977, decisamente fuori tempo massimo per gli anni ’60 quindi, ma che nel suo richiamarsi ai Mostri di Dino Risi del 1963 trova la sua ragion d’essere. E anche la forza che lo rende forse uno degli esponenti migliori della pattuglia dei corti d’autore sulla quotidianità italiana.
Essendo una citazione / omaggio / sequel, questi nuovi mostri ripropongono le caratteristiche salienti dei vecchi mostri originali. E’ quindi difficile fare il gioco dello “spezzone migliore/spezzone peggiore” in quanto una delle caratteristiche salienti è la brevità di alcuni corti, anche di un solo minuto, secchi, spietati, satirici. Verrebbe quasi voglia di promuoverli tutti a miglior spezzone. Di sicuro memorabili quelli del cardinale in panne o del cantante in cerca di successo. Un saggio satirico sull’italiano medio che è il perfetto esempio di cinema popolare post-Totò (Totò e le donne?), laddove ad esempio il Boccaccio ’70 era forse troppo sottile e raffinato. Qui c’è comico, e comico di pancia.
C’è un certo rammarico di fondo però per questi mostri a colori. Per quanto variopinti e azzeccati, perfetto Totò-sequel, non si può chiudere gli occhi di fronte all’opera originale di Dino Risi. Scoprendo che era più di tutto: più graffiante, più ispirata, più saggia. Prima di approcciare questi mostri quindi il consiglio è quello di ripassarsi questo pezzo di storia in bianco e nero. Storia nel vero senso della parola: storia di costumi, di abitudini di quotidianità, storia intesa nel senso di testimonianza annalistica, alla Bloch e Febvre.
| Voto (4/5): |  |
140 - Postal
Uwe Boll è il responsabile di tutte le peggiori trasposizioni di videogame in lungometraggio. Prendete un film tratto da un videogioco: se lo ritenete una schifezza talmente brutta e anonima da non meritarsi nemmeno considerazione (Far cry?) molto probabilmente è di Uwe Boll. E’ matematico. Questo personaggione tedesco è riuscito con la sua incapacità registica, ma abilità di marketing, a farsi un nome e adesso è uno dei registi più odiati (ma conosciuti) nel Web. Tuttavia anche quando si allontana dall’adattamento videoludico (vedi Seed) mostra tutta la sua mediocrità.
Cosa succede quando Boll decide di adattare un gioco già di per sé orribile e sconclusionato? Succede che ne esce un capolavoro. Prendendo in mano Postal Boll sapeva di avere una scaletta ben precisa da seguire: l’assurdo, l’eccesso, il politically uncorret ad ogni costo. E tanta mediocrità realizzativa, che era insita e voluta nello stesso videogame.
Ed è quello che il buon regista pugile ha dato ai suoi spettatori. Postal è un ammasso di scemenze autoreferenziali male pensate e peggio realizzate che riescono a trovare per miracolo un incredibile equilibrio. Il Postal Dude che impazzisce e comincia a menare mitragliate a destra e manca, i terroristi arabi, i nazisti, il creatore del gioco Postal che salta addosso a Boll per vendicarsi sono un concentrato di emerite puttanate talmente evidenti che risultano irresistibilmente esilaranti. Postal è un film da vedere, subito, senza pensarci due volte. Un’oasi liberatoria in cui nulla più rimane di sacro, ed è giusto così. Grazie per questo piccolo momento di lucidità, Uwe.
| Voto (3/5): |  |
141 - Inland empire
David Lynch. Un nome una garanzia. Di cosa di preciso? Innanzi tutto di fascino. E’ innegabile che l’ignoto abbia il suo fascino, e Lynch ne è il perfetto poeta, glielo concedo. Perchè Lynch è bravo, sa raccontare storie e sa far sognare. Quando vuole. Ma è garanzia di incomprensibilità, anche. E già qua iniziano le note dolenti. Perchè lo sapete come la penso, l’ho espresso più volte e anche in occasione della mini recensione di Eraserhead: un regista di un film non può pararsi dietro l’incomprensibilità di una trama e lasciare che sia lo spettatore a fare il lavoro che sarebbe lui stesso chiamato a compiere.
Avvicinarsi a un’opera mastodontica come Inland Empire non è affatto semplice. Tre ore di lunghezza e la perfetta consapevolezza che Lynch si è espresso senza alcun vincolo: di tempo, di spazio e di pudore. E allora comincia il solito valzer dell’inserire elementi a caso e sconnessi l’uno all’altro solo perchè “fa figo” e ci penserà il fanboy a darci un significato. Sit-com di conigli, primissimi piani intensissimi di minuti interi e la solita gara a chi mette più nanetti in un film (ciao, In Bruges!).
Il risultato non poteva che essere quello che io chiamo “Effetto Lynch”, ovvero uno spettatore che esce dalla sala (e dopo tre ore del genere è già tanto riuscire a uscire sulle proprie gambe, beninteso) che esclama: “Non ci ho capito niente, figata!”. Eh no. “Non ci ho capito niente: incapace!” ribatto io.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (1/5): |  |
142 - Ferro 3
Kim Ki Duk è uno di quei registi che sembrano nati per creare un circolo unico e coerente di contenuti. Lo spalleggiano, in questo intricarsi progressivo di film concatenati l’uno all’altro, ad esempio lo Tsukamoto di Tetsuo e Wong Kar Wai di Angeli perduti. In particolare Kim Ki Duk disegna una grandissima parabola che parte dal Wild Animals del 1997 in cui affronta un progressivo distacco dalla realtà per affrontare le sfaccettature dell’interiore, del reale nel suo rapporto con la finzione e delle cose nella scoperta della loro reale natura. Parabola che non è solo di temi ma anche qualitativa. E al cui apice sta Ferro 3.
Immaginate un film il cui protagonista maschile non dice una parola e la cui amante protagonista femminile dice solo due frasi: “Ti amo” e “La colazione è pronta”. Immaginate che questi due amanti viaggino di casa vuota in casa vuota riempiendole con il loro amore, silenzio, musica e ordine (la metafora della vita congiunta) mentre i legittimi proprietari sono lontani. Immaginate una coppia che di fronte alla morte di uno sconosciuto si piega nel fornirgli una sepoltura più che degna.
Questo e molto altro rendono Ferro 3 un’esperienza da vivere prima ancora che da capire. Un film che non vuole insegnare, ma finisce per farlo: insegna la leggerezza di come si affronta una vita (la scomparsa nella prigione). Sull’essere invisibili ma costantemente palpabili. “Non è dato sapere se il mondo in cui viviamo è sogno o realtà”, questo chiude il film. E lo ben rappresenta. Una frase che a seconda di come viene detta può essere incredibile vuoto e banalità, o piena di semplicissime e profonde sfaccettature. Kim Ki Duk la sa pronunciare nel secondo modo.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |
143 - Ghost in the Shell 2: Innocence
Un certo tipo di animazione giapponese è poggiata su pilastri più o meno fissi. Fantascienza più o meno esplicita, contenuti che cercano di esprimere aspetti importanti della filosofia orientale e non, potenza visiva e visionaria, surrealismo e postmodernismo. Uno di questi pilastri si chiama Mamoru Oshii. E questo era chiaro fin da Patlabor, nell’89, senza star a scomodare nomi ben più famosi. Come questo seguito a Ghost in the shell, che nel 2004 ha posto una pietra miliare nell’animazione sancendo un nuovo punto di non ritorno.
Ghost in the shell è una serie animata il cui tema principale è l’anima, il ghost. Oshii si interroga da dove provenga l’animo umano, cerca di studiare il corpo e il cervello per capire che cosa rende così speciale l’uomo. E la sua risposta è pessimistica: secondo lui non c’è nessuna magia, niente di speciale. Perché l’anima dell’uomo può essere tenuta prigioniera, replicata o migliorata. Nel primo Ghost in the shell infatti l’evento principale era la creazione di un nuovo essere senziente emerso autonomamente dall’iperconnessione della rete informativa umana (leggi: Internet, nel 1995!). In questo seguito sono delle bambole (versioni cibernetiche di quelle in carne e ossa di Dollhouse) che sviluppando autocoscienza del loro essere si rifiutano di sottoporsi a continue umiliazioni e all’essere usate come oggetto.
Corpo umano usato come oggetto, altra testimonianza di come, per cercare profondi significati al cinema di Oshii, sia necessario scavare ben più a fondo della patina filosofeggiante che ricopre tutto. Un altro elemento del film, che bisogna ammettere rischia di renderlo eccessivamente pesante a chi si aspetta un action simile agli altri esempi nipponici, è una pletora immane di citazioni estreme ad aspetti della cultura orientale e occidentale. Chiudo invece annotando l’uso della computer grafica come un difetto: è si l’apice del non ritorno estetico nipponico, ma in questo caso è troppo grezza ed evidente per essere funzionale a ciò che si vuole esprimere.
| Voto (4/5): |  |
144 - Donnie Darko
Il film d’esordio del buon Richard Kelly ha avuto fin da subito una vita travagliata, ma si è affermato come un vero e proprio classico del cinema. Se si va ad indagare nei suoi meriti, però, ci si accorge che essi sono piuttosto sorprendenti. I suoi punti di forza infatti non sono rappresentati né dalla fantascienza, né dal mystery o dall’horror. Quello che Kelly è riuscito sapientemente a fare è stato quello di creare un meraviglioso e realistico ritratto dell’aria che si respira nei licei americani.
Sono infatti gli estenuanti insegnamenti stupidi di chi pensa che un insegnante possa essere rimpiazzato da una televisione a dominare parte della scena. O i guru mediatici che pur di raggranellare qualche spicciolo si inventano pagliacciate che costano il futuro degli studenti. Studenti che si ritrovano a dover sperare e puntare tutte le loro forze su bellezza, conformità e spettacolo per il proprio futuro, invece di costruirsi la propria strada con lavoro e merito sulle loro attitudini. Represse da una società troppo conformista (la cui ribellione rappresentata dall’insegnante Drew Barrymore è, ahinoi, la parte più debole e discutibile del film).
A questo punto risulta chiaro dove si collocano gli altri tasselli del puzzle di Donnie Darko che ne hanno fatto la fortuna. Viaggi nel tempo, conigli horror e fine del mondo non sono altro che le fantasie e le inquietudini che prendono corpo e somatizzano il malessere di chi è abbastanza intelligente da capire dove sta andando a finire la scuola e la vita che gli ruota attorno. E ha un disperato bisogno di fuggire da questo triste destino.
| Voto (4/5): |  |
145 - The girl who leapt through time
Compiti in classe e pulizie. Ragazzi che si divertono con te (o di te) e prime cotte. La scuola, soprattutto l’ultimo anno prima di scegliere l’università, è un cocktail assolutamente unico di scocciature, divertimenti, ansie, paure e fascino. E tutti noi abbiamo il segreto desiderio non solo di avere una seconda occasione per tornarci, ma anche di poterla affrontare senza preoccuparci delle scelte da fare. Il potere di tornare all’indietro nel tempo fa sicuramente parte di questo sogno proibito.
Che cosa si scopre quindi viaggiando nel tempo? Si scoprono parti di noi che non sospettavamo esistessero. Si può capire che cosa sono i sentimenti che abbiamo provato per la prima volta, si può avere chiaro che ciò che decidiamo ha conseguenze irreparabili, se non si potesse tornare indietro (cosa che, effettivamente, non si può). La ragazza che salta nel tempo però ci fa capire anche un’altra cosa.
La cosa che ci fa capire è che questo potere è nient’altro che una sventura. Parafrasando Oscar Wilde, la tragedia più grande è ottenere ciò che desideriamo. Poter tornare indietro toglie tutta la magia del rischio, la consapevolezza di essere davvero in gioco. E’ come guardare una partita invece di giocarla. Lasciamo gli spalti agli altri e buttiamoci nel fango si decide alla fine. Questo dovrebbe essere il finale. Cosa che non accade del tutto, dato che questa ragazza alla fine rientra in fin troppo dolciastri clichè da shojo giapponese.
| Voto (3/5): |  |
146 - Elephant
Ci sono dei grossi interrogativi suscitati da Elephant. Questi interrogativi nascono dall’abilità di Gus Van Sant di rendere la telecamera non un occhio esterno, ma uno interno. Scordatevi dunque prospettive a volo d’uccello, narratori onniscienti e perle di saggezza artistica da spandere per il mondo. La telecamera non è un professore, un giornalista o un poliziotto. La telecamera è uno studente.
Perfettamente in tema dunque con la scuola vista dagli studenti. E allora mentre questa telecamera passeggia per i corridoi del liceo vediamo la vita di tutti i giorni di un posto assolutamente banale e normale. Dobbiamo correre, inseguire piccoli frammenti. Inseguiamo ragazze bulimiche per cui la vomitata nei bagni è un rito di normale socializzazione, inseguiamo disadattati che non sono in grado di costruire un normale rapporto sociale con chi gli sta intorno, inseguiamo esseri fragili che si vergognano del loro corpo e inseguiamo feticisti delle armi che fanno strage dei loro coeatanei… Eh?
Sì, perché alla fine si scopre che questo luogo non era così normale come può erroneamente sembrare all’inizio. Che nessuno di questi studenti è normale come può apparire all’esterno. Nessuno di loro lo è. Il che si traduce nel fatto che lo sono tutti. Una delle tante cose che si possono estrapolare dalla creta grezza che è Elephant, sfaccettata e modellabile all’infinito, è anche un certo rifiuto dell’individuo estremizzato e fine a se stesso, le cui conseguenze sono Columbine, Winnenden, Lancaster.

| Voto (5/5): |  |
147 - Non uno di meno
C’è da dire che non amo molto il cinema cinese. Soprattutto quello che va/andava per la maggiore negli ultimi anni, ovvero una rivisitazione più o meno riuscita del neorealismo italiano. I film cinesi infatti sono quasi tutti caratterizzati dal prendere una realtà cinese, quasi sempre lontanissima dalle metropoli, rupestre e tradizionale e raccontarne i problemi, le gioie, la genuinità. Insomma: a parte rari casi, mi viene in mente The sun also rises, molti film sembrano remake dei ladri di biciclette (come Courthouse on the horseback).
Zhang Yimou, prima di diventare famoso in occidente, si dedicava a questo tipo di film. Va da sé che non fosse uno dei miei cineasti preferiti. Però in questo Non uno di meno ci trovo del buono, molto buono. Innanzi tutto, a carattere generale, la storia della bambina a cui viene affidata una classe è ben girata, cattura e riesce, contro ogni aspettativa, a tenere altissimo il livello di empatia con il personaggio principale.
Secondariamente questo è un bell’inno ai valori del lavoro sodo e alla voglia di crescere che un paese bistrattato dai propri capi sa mettere in campo. La promessa di non perdere nemmeno un bambino dalla classe diventa incredibilmente difficile: tanta è la forza con cui gli indifesi vengono attirati nel mondo esterno per lo sfruttamento, le sirene del successo, il degrado e peggio. Forse il miglior Yimou.
| Voto (4/5): |  |
148 - Fear(s) of the dark
Che cosa ci azzecca la paura del buio con l’impegno politico? O sociale? Perché un horror dovrebbe essere incluso nei film che trattano dell’impegno degli autori? Queste domande sembrano poggiare sulle granitiche basi del senso comune, ma si ritrovano ad essere sbriciolate dall’intera storia cinematografica. L’horror, infatti, fin dalla sua nascita è stato caratterizzato da una fortissima carica eversiva contro il sistema, contro il pregiudizio di una morale parruccona, facendosi fautore della più tetra e aggressiva forma politica espressiva. Basti pensare alla Notte dei morti viventi di Romero.
Le paure del buio di terra francese ripescano a piene mani da questo calderone magmatico di socialità, politica e moralità non convenzionale. Il filo conduttore di questi episodi che ritraggono la perdita dell’identità del corpo, l’autoisolamento culturale e/o individuale e temi simili è infatti una voce che scandisce le colpe dell’individuo, dell’occidente e della società quando essa si trasforma in carnefice dei suoi stessi cittadini. L’altro filo conduttore, quello del potere trascinato dai mastini che divorano il popolo, l’infanzia, l’arte e infine se stesso, è di fatto il miglior corto del lotto, sia a livello di sceneggiatura che di tecnica di disegno.
Rimane forse un po’ l’amaro in bocca per alcune altre parti del film, che è realizzato tecnicamente da maestri dell’animazione ben più che geniali. Rimane una povertà in fase di scrittura del filo conduttore della voce fuori campo, che propone un j’accuse fine a se stesso proprio di altre pellicole quali ad esempio Valzer con Bashir.
| Voto (4/5): |  |
149 - Un altro mondo è possibile
Il G8 di Genova visto da una poliedricità di punti di vista differenti, in una raccolta documentaristica diretta realizzata nel momento stesso dell’esecuzione dell’atto (in maniera simile al recente, ma decisamente meno significativo, Cinque registi tra le macerie). Il progetto del documentario in divenire, meglio se con occhio artistico, è intrigante e ambizioso, ma non si può dire che questo mondo diverso sia stato un vero successo pieno.
Fin dalle fasi iniziali la pellicola infatti scade un po’ troppo nel generico. I registi che curano la parte introduttiva non sono stati abili nel riuscire a catturare una vera identificazione culturale e sociale dei partecipanti al movimento no global del 2001. L’arrivo nei treni, la sistemazione nei campi e tutto il resto infatti sembra estremamente impersonale e potrebbe far riferimento a qualsiasi altro meeting o raduno di giovani e meno giovani in giro per l’Italia. Insomma: sembra di vedere un gruppo che potrebbe essere di comunisti o di ciellini e questa non può che essere una clamorosa e imperdonabile svista.
Il film è comunque abbastanza intelligente e onesto da riuscire a dare voce a tutte le parti coinvolte nei fatti di strada che si sono svolti in Liguria a inizio decennio. Non c’è, e non ci deve essere, la voce del potere, che della strada non si cura e non ci si vuole mescolare. Ci sono, anche se forse troppo relegati e circoscritti, i black block e le devastazioni. C’è tanta politica, ingenua quanto si vuole, ma ben esposta nel suo essere naive e pungente.
| Voto (2/5): |  |
150 - 11 Settembre 2001
Un evento centrale degli ultimi anni come l’attentato terroristico più famoso del mondo visto da molteplici paia di occhi sparse in giro per il mondo. E’ un’operazione importante quella di coinvolgere ogni angolo del globo per sottolineare come ognuno ne abbia una visione particolare di questo evento e di questa guerra, per smontare le facili fallacie logiche di chi desidererebbe disperatamente un mondo in cui si sta “o con noi o contro di noi”.
Se difetti se ne vogliono trovare si può andare a cercare fin da subito nelle case della produzione. Tutto il progetto artistico infatti è stato pensato su misura della solita cultura kontro che poco ha a che vedere con l’aspra critica sociale. Il progetto è stato messo nelle mani di registi che sembrano vivere solo per partecipare a progetti del genere e più di un regista infatti ha fatto parte di più di una raccolta di corti a sfondo sociale. Alla fine questa molteplicità di punti di vista non riesce ad emergere forte e decisa e molti registi si sono affidati al cliché rendendo la pellicola troppo ripetitiva.
Tra gli assoluti “worst” c’è di sicuro l’Iñarritu di Amores Perros il cui corto è il fulgido esempio della mancanza totale di idee. Meglio il corto francese sulla donna sordomuta, che si apprezza in ogni singolo aspetto di delicatezza e interpretazione. Decisamente estremo e non so quanto lecito per un extra americano il corto di Penn. Esilarante e riuscita invece la capatina nel Burkina Faso di Idrissa Ouedraogo.
| Voto (3/5): |  |
151 - All the invisible children
All the invisible children non è basato su un evento storico preciso, ma su quella che viene definita un’emergenza sociale della modernità: quella dell’infanzia rubata. Al centro della macchina da presa storie di minorenni che sono attorniati da miseria, guerra, abusi e una società oppressiva che si dimentica di loro. Dietro la macchina da presa artisti del calibro di Kusturica, Spike Lee, John Woo e Ridley Scott.
Non è quindi certamente la qualità tecnica che manca. A parte qualche caso di registi infilati non si sa bene perché, infatti, tutti gli altri sono solidissimi autori dalla tecnica che rasenta la perfezione. Anche alcune sceneggiature non sono affatto male, come il corto affidato a Woo. Meno convincente risulta ad esempio Kusturica, che sembra voler applicare la sua tipica idea di cinema alla Gatto bianco, gatto nero fino alla morte, risultando però poco ispirato quando deve collaborare con un progetto pensato da altri a tavolino.
E’ questo fondamentalmente il problema. Chi ha fatto la commissione. Da una parte c’è l’Unicef, che non può tollerare null’altro che il proprio buonista modo di vedere il mondo relegando in una gabbia dorata le possibile vene più estremamente artistiche della sua squadra di registi. Dall’altra Unicredit che sembra aver voluto investire in questo progetto con l’unico scopo di mettere il suo logo nei titoli di testa e farsi un po’ di pubblicità. O, peggio, potrebbe avere nel suo reparto dirigenziale e di marketing una pattuglia di Helen Lovejoy che non fanno altro che urlare: “Mio Dio i bambini! Perché nessuno pensa mai ai bambini???”

| Voto (2/5): |  |
152 - Il pianeta delle scimmie
Tim Burton è uno di quei registi che rimane vittima della propria fama. Alle sue spalle un grandissimo Batman e uno stile tecnico e narrativo sicuramente azzeccato e non troppo comune. Accade che sforna un grandissimo capolavoro, Big Fish, ma si capisce subito che qualcosa si incrina. Burton progressivamente, vittima di se stesso, diventa l’idolo dell’emo boy.
Eppure ci ha provato il buon Tim. Ci ha provato nel passato a svincolarsi dalla logica del gotico e della stop motion a tutti i costi. Ne è uscito, tra gli altri, questo pianeta delle scimme. Un film in cui è quasi impossibile riconoscere la sua mano. E’ un classicissimo ammodernamento dell’originale con Charlton Heston, niente di più, niente di meno. Un adattamento i cui temi sono il diverso, la vanagloria dell’eccessivo zelo e l’autodistruttività dell’uomo.
Temi che nessuno si aspetterebbe da un regista così fantasy, così dark, così emozionale. E che associati a Burton hanno sempre stonato. Eppure se lo si guarda a fondo ci si accorge che tanto brutto questo pianeta delle scimmie non è. E’ anonimo, indubbiamente. Ma la superba interpretazione di Tim Roth, che riesce ad essere incredibilmente espressivo anche dietro una maschera di gomma, vale per intero il prezzo del biglietto.
| Voto (3/5): |  |
153 - Match point
Woody Allen è invecchiato. E fin qui nulla di male, né di inevitabile. Il caro vecchio zio del cinema però non è minimamente intenzionato a gettare la spugna. Dato che la verve che aveva venti anni fa ormai per lui è assolutamente impraticabile ha deciso di darci un taglio con le vecchie manie (ad eccezione del deludente Basta che funzioni, troppo buonista e parlato per funzionare sul grande schermo). Il risultato è Match point, che è in realtà il capostipite della new wave di Allen.
Innanzi tutto cambia lo scenario. Via America, benvenuta Europa. In particolare l’Inghilterra. E’ riuscitissima l’ambientazione per il buon Woody, molto di più della stessa stantìa Inghilterra, o di una Spagna che non riesce a capire, del suo inevitabile futuro. Match Point funziona, su tutta la linea. Con i suoi discorsi sul caso, con la vita che prende sempre la piega peggiore. Talmente peggiore che il buon Woody, che ancora se la starà ridendo per questo brutto tiro, riesce a farti tifare come un forsennato per un assassino, sperando che ce la faccia.
E Match Point ce la fa. Molto più di tutto il resto. Certo: in Scoop ironicamente Woody si mette sulla barca di Caronte, metaconsapevole del suo destino. Ma Match Point è un film fatto e finito. Di Allen ha poco e niente, ma fortunatamente questo non importa affatto.
| Voto (3/5): |  |
154 - Hiruko the goblin
Una filmografia che della coerenza ha fatto l’arte. Rari sono gli esempi di registi che, come Tsukamoto, hanno saputo evolversi e declinare la propria poetica rinnovandosi costantemente eppur rimanendo forti e classici. Forse il Cronenberg la cui parabola da Crimes of the future alla Promessa dell’assassino. Incredibile però questo inciso a colori e perfettamente inserito nel teen horror giapponese targato 1991.
Ancora più incredibile se lo si vede inscritto tra i due Tetsuo. In realtà è perfettamente spiegabile: dato che Tetsuo è stato girato con una camera, con meno di 20000 euro e con più di tantissima arte, Tsukamoto ha pensato bene di concedersi un film su commissione per finanziarsi il seguito. Va quindi considerato senza arte né parte, questo Hiruko? Assolutamente no. Nella filmografia di Tsukamoto non trova posto, ovvio, ma la qualità che il simpatico regista dagli occhi a mandorla sa mettere in campo risulta sempre superiore a quanto possano sognarsi gli scribacchini della regia di mezzo mondo.
In particolare si rileva in questo Hiruko una fortissima vena ironica e dissacrante proprio nei confronti del teen horror giapponese degli anni ’80. E’ la fine giusta per gli scalmanati studenti tormentati da questo spirito che infesta il loro liceo. Si potrebbe quasi dire, e anzi lo grido a gran voce, che questo film di Tsukamoto rappresenta uno Scream ante litteram.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
155 - La ricerca della felicità
Muccino per anni è stato un bersaglio incrociato. Da una parte i suoi contenuti ultra progressisti lo hanno sempre messo nel mirino di una (non) cultura dell’apparire e della malafede. Dall’altra il fatto che è un pessimo regista, buono solo a confezionare dei gioiellini tecnici, lo ha reso mal digeribile anche a chi poteva apprezzarne i contenuti. Vistosi preso a pomodori in faccia da entrambi i fronti (e il sottoscritto stava in prima fila col carico di ortaggi) ha pensato bene di fare le valigie e partire per l’America come gli italiani di inizio secolo scorso.
Con questo “La ricerca della felicità” da una parte abbiamo l’estremizzazione delle sue capacità tecniche. In America trova una troupe più ricca e preparata, che lo può assistere in suggestivi carrelli e riprese al limite del perfetto. Dall’altra realizza un tradimento colossale di tutto quello che voleva rappresentare in terra natìa. E che ha come risultato il farsi rendere doppiamente antipatico da tutti.
Il cantore del classico trentenne in crisi e del no-global da salotto diventa infatti un clamoroso sostenitore della politica reaganiana. Non esiste l’ingiustizia sociale, non esistono categorie costantemente svantaggiate e tradite: per il Muccino a stelle e strisce, il cui nuovo feticcio è un Will Smith affamato di Oscar, chi è nel fango ci sta perché è incapace o cattivo. Chi fallisce se lo merita e chi trionfa pure, a prescindere dai mezzi utilizzati, che sono tutti leciti se ti portano all’altare del successo. Questa è la sua ricerca della felicità. L’impossibilità di sentirsi realizzati anche nella preziosa mediocrità che ci dà il pane e ci dà da sopravvivere giorno dopo giorno di duro lavoro.
| Voto (1/5): |  |
156 - God of cookery
Stephen Chow è dall’inizio della sua carriera un simpaticissimo anarchico parodistico, spina ridanciana nel fianco della filmografia di Hong Kong. I suoi film, alla fine di tutto, sono molto simili l’uno all’altro. Si basano sull’assunto della parodia, la maggior parte delle volte a sfondo wuxia (o gongfu) pian, anche se non sempre. Cito giusto Shaolin soccer. In God of cookery questo schema viene seguito. E se il cibo è balamente metafora della vita e del successo, il mezzo con cui questo viene raggiunto, il kung fu tra i fornelli, è esplosivamente comico e certamente riuscito.
Non originalissimo, questo c’è da dire. Johnnie To c’è riuscito meglio con il suo Fat Choi Spirit (e più seriamente con Sparrow), che in chiusura si richiamava direttamente a Once upon a time in China. Perché il problema principale di God of cookery è che si affida a una struttura troppo solida e utilizzata. Struttura che ha come componente di base una sequenza facile facile. Inizio col protagonista che ha un successo immeritato, che si monta la testa e vende la sua “arte”, l’arrivo del nuovo sfidante arrogante che lo riporta nella polvere che si meriterebbe, acquisita consapevolezza del valore dell’impegno e dell’animo puro, sfida finale con l’antagonista e trionfo. Quanti film hanno questo schema? Tanti, troppi.
Fortunatamente se Chow non è capace di innovare il genere parodistico, né di creare un film che regga da solo un impianto più abile nel nascondere la mancanza di originalità, questo non si estende alla cosa più importante. E cioè al far ridere. Con God of cookery si ride, tanto e di gusto. E’ un film ripieno di situazioni paradossali e grottesche, queste sì scritte magistralmente, e non potrete fare a meno di amarlo per questo.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
157 - The untold story

Che cosa rappresenta il cibo quando pensiamo alla classica ragazza appena mollata, triste e in pigiama che passa la sua serata con in mano una vaschetta di gelato? Tristezza, forse. Consolazione, probabilmente. Io, da malizioso, penso al rancore. Cibo trasformato, comunque sia, in uno sfogo dei sentimenti, nello sfogo nero e diametralmente opposto a quello propositivo. Vendetta e piangersi addosso. In questo senso possono essere viste, ad esempio, alcune tragedie greche. Penso a Medea, in primis. E a questo Untold story.
Innanzi tutto The untold story è una storia vera. Nel 1978 un tizio uccise un creditore, scappò all’estero e aprì un ristorante. E per farlo trucidò tutti quelli che gli mettevano i bastoni tra le ruote. E nel film questa rabbia contro un mondo che il protagonista non riesce a capire viene sfogata nella furia omicida del cibo. Il suo mancato inserimento lo rende feroce e lo porta a uccidere e cucinare le vittime per i suoi clienti. Il punto di forza del film è dato anche dal fatto che questo terribile serial killer non è per nulla speciale. E’ normale. Normalissimo. Quasi stupido e banale. La stupidità e la banalità dell’orrore vero, quello che trasforma le persone comuni in mostri.
Ancora più grottesco è il film se si pensano ai siparietti comici del reparto di polizia cui vengono affidate le indagini. Purtroppo, a mio avviso, quest’idea della comicità poteva essere sfruttata meglio, per far stridere ancora di più con la parte sanguinosa (gore estremo, ben lontano dalle pagliacciate cartoonesche di film giapponesi come Cruel Restaurant). Così è troppo facilona, banale e non aggiunge il fascino che questo film si sarebbe meritato.
| Voto (2/5): |  |
158 - Mangiare bere uomo donna
L’occasione del dialogo e dell’incontro. Questo è il cibo per Ang Lee, o meglio per il suo protagonista. Il film si incentra su un momento: i pranzi domenicali che sono la delizia della vita del proprietario di un ristorante di Taiwan. Attorno a questo tavolo scorrono le vite delle sue tre figlie impegnate a trascorrere al meglio la loro vita e i loro tormenti sentimentali e non.
Queste vite sono a loro volta indissolubilmente legate al cibo. Il frutto non cade mai troppo lontano dall’albero. E allora abbiamo la figlia di mezzo tenuta lontana dai fornelli in quanto figlia di una società all’antica e oppressiva, o la più piccola impiegata in un fast food. E’ un film che vive di contrasti quindi, nell’accezione più teatrale e classica del termine. Un film che quindi può essere analizzato ed interpretato solo nel suo trasformarsi in metafora ed esempio della vita di tutti i giorni.
Una piccola gemma che però può essere apprezzata poco dal grande pubblico, specialmente occidentale, che può vedere le oppressioni e le frustrazioni dipinte come troppo distanti e diverse dalla sua esperienza (ma grattata la superficie ci si rende conto di come Ang Lee sia capace di universalizzare). Da questo punto di vista è molto più riuscito un altro film di Lee, curiosamente anch’esso incentrato su una situazione culinaria assai particolare e importante: Il banchetto di nozze. Ma allora come ora il cibo è un momento di apertura e di dialogo con gli altri e con se stessi, un momento di riflessione per capire chi siamo, chi siamo stati e chi vogliamo essere.
| Voto (4/5): |  |
159 - Ratatouille
Quando si parla di cibo come metafora si allude quasi sempre, in maniera scontata, all’amore. Raramente alla vita in generale. Eppure la vita tra i fornelli per il suo essere complessa e per il suo richiedere una incredibile dose di talento e tecnica non credo che meriti tutte queste banalizzazioni da bacio Perugina. Se ne accorse la Pixar che, con questo Ratatouille, riuscì a donargli forse la sua rilettura migliore. Cibo visto come cinema e arte in generale, come il cinema e l’arte della Pixar in particolare.
Tutto il film si basa sull’incredibile e sul nuovo. L’incredibile è che un ratto e uno sguattero buono solo a pulire per terra (e, forse, nemmeno a quello) siedano sul trono dell’arte culinaria mondiale. Il nuovo, sottolineato dalla recensione di Gusteau finale (uno dei migliori monologhi del XXI secolo e, di sicuro, il migliore scritto dalla Pixar), è dato dalla distruzione delle certezze di ciò che era. Il nuovo è saper rischiare nell’esaltare ciò che nessuno o in pochi conoscono, di contro ai molti che preferiscono affidarsi alla certezze chiuse e autarchiche di ciò che già sanno, autonegandosi il piacere estremo della scoperta.
Ed è questo che fa la Pixar. E’ incredibile perché nessuno si aspettava una tale profondità, una rivoluzione dell’animazione occidentale, da una casa di effetti speciali in computer grafica. E’ il nuovo perché prende e rileva la sicura e tradizionale Disney, al punto da potersi permettere di comprarla. Temi che alla fine sono diventati un marchio di fabbrica, anche trito, di questa casa, da Toy story ad Up. Ma che in questo caso sono esplosivi e divertenti come non mai. Una lezione di vita che insegna ad uscire dal guscio dell’isolamento e dedicarsi al meticcio, al mescolarsi, allo scoprire.
| Voto (5/5): |  |
160 - Tokyo!
Ah… Il Giappone. Terra di scolarette vestite alla marinara, robottoni e alieni che vogliono a tutti i costi distruggere sempre lo stesso grattacielo di Tokyo. Come non amarlo? Se lo chiedono tra registi che del cinema stanno facendo, a modo loro la storia. Il risultato sono tre mediometraggi che fanno della potenza visiva e dell’originalità di sceneggiatura i loro punti forti. Il più immediato è senza dubbio quello di Carax, che fa una parodia fin troppo esplicita proprio dei grossi mostri che devastano la città, ribaltandone però i cliché: a farlo è un essere che appare simile all’uomo, che viene anche processato e di cui viene, genialmente, annunciato un remake americano.
Salendo i gradini del mio personale gusto troviamo l’opera in apertura di Gondry. In una terra che valuta i propri cittadini sulla scala della produttività come il Giappone sentirsi artisti non è facile. Soprattutto quando l’ambiente attorno a te viene valutato solo per quanto riguarda il parametro dei servizi e della ricchezza prodotta. Una fonte profonda di disagio, non a caso il Giappone primeggia nelle statistiche dei suicidi. E che viene metabolizzata in forma visiva da Gondry in maniera ineccepibile (e pure agghiacciante).
Infine troviamo la parte di Joon-Ho Bong, abituato da sempre a parlare per metafore (come nel bel The host). Joon-Ho ci parla degli hikikomori, un fenomeno comune in Giappone in cui gli individui decidono liberamente di privarsi di tutti i rapporti sociali e di vivere in stato di quasi totale isolamento. Il regista sudcoreano ci dà un ritratto affascinante di una Tokyo ridotta al deserto più completo da questa mania e del terremoto di uno di loro che per amore decidere di scuoterla e uscire da questa situazione. Decisamente il miglior capitolo.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
161 - Paris, je t'aime
Parigi in una ventina di cortometraggi. Ognuno dei quali prende il nome da uno dei posti più celebri della metropoli d’oltralpe. Un progetto ambizioso, vuoi perché è difficile raccontare un luogo in una manciata così sparuta di minuti, vuoi perché coinvolgere un numero così elevato di autori può essere un problema sugli equilibri qualitativi e di ritmo di una pellicola. Difficile anche valutare un film del genere, in quanto molti esempi meriterebbero di essere trattati singolarmente e con fiumi di parole.
Tra gli esempi più convincenti stanno senza dubbio i fratelli Coen, che mediante la muta espressività di un grandissimo Steve Buscemi riescono a far ridere e parlare del versante più caliente del sangue latino. Oppure per il Vincenzo Natali che non ti aspetti: il papà di Nothing dà vita a un piccolo gioiello di fantasy romantico espressionista, svolto in guisa comica e visivamente affascinante. O anche Van Sant, che applica la sua poetica à la Elephant per le strade parigine.
Pollice assolutamente verso per tutti coloro che svolgono un patetico compitino nel raccontare con le solite banalità zuccherose il particolare rapporto multietnico di questa mela europea (e mi rivolgo al corto arabeggiante di Gurinder Chadha). Oppure a Twykler che riesce a banalizzare anche il tema della cecità (in questo deve prendere nota dallo svolgimento di Lelouch in 11 Settembre 2001) e la bellezza della Portman. In sostanza rimane un’accozzaglia più o meno riuscita, che riesce però a scivolare via con piacere, proprio come la città di Parigi.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
162 - Toronto Stories
Suona un po’ fuori posto una raccolta di corti dedicati a… Toronto. Non che abbia qualcosa contro i canadesi. Ma quando si pensa a città che meriterebbero una raccolta di storie d’autore si potrebbe stilare una lunga, lunghissima lista di città affascinanti a cui dedicarsi. E Toronto non è di certo in questa lista. Il che può essere un male (poche cose da dire, poco sottostrato culturale collettivo da cui cogliere), ma anche un bene (possibilità di slegarsi da una banale elegia cittadina, originalità).
Gli autori che si mettono all’opera in questi corti non sono certo conosciuti e affermati in campo internazionale. E non si può dire che le ragioni non si vedano. Gli sviluppi delle storie, oltre ad essere piuttosto slegate dalla città di Toronto, risultano frettolosi, tagliati a metà, incompleti. Il corto iniziale dei due bambini potrebbe essere il migliore del lotto, se non fosse del tutto campato per aria.
Il filo conduttore del bambino smarrito è inoltre privo di fascino e di significato e assume pesi diversi in spezzoni diversi, quando sarebbe lecito pensare che rappresenti una spina dorsale strutturale (un po’ come il personaggio di Rorschach nella versione fumettosa di Watchmen). Senza poi considerare che altri corti invece (specie quello della regista di origine sudcoreana) risultano essere discutibili e noiosetti.
| Voto (1/5): |  |
163 - New York stories
Un dream team di altissimo livello, quello che nel 1989 è stato messo insieme per cantare le storie che abitano la grande mela. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Woody Allen. Curioso scoprire in questi tre corti molti punti in comune, sia strutturali che espressivi, ma soprattutto di situazione extra cinematografica, in particolare la carriera. Tre grandissimi autori che negli anni 90 hanno trovato probabilmente la loro fine.
I corti contengono tutti una fondamentale caratteristica comune: l’irrazionalità. Sia inquadrata dal punto di vista dell’arte (Scorsese e Coppola) che dalle situazioni paradossali e anti-scientifiche (Allen). In particolare il corto di Coppola rivela come sia molto forte l’emergente personalità della figlia. Alla fine il corto risulta non essere niente di che: il padre è imbrigliato nella stanchezza che gli impedisce di governare la scena e la figlia è evidentemente troppo acerba. Ma nelle vicende di Zoe si vedono già gli embrioni della poetica della femminilità che dalle vergini suicide a Maria Antonietta ha reso famoso e personalissimo il cinema della Coppola jr.
Più scarico Allen, la cui comicità comincia ad aver bisogno dei suoi colpi di coda prima del ritiro in Europa. Più grintoso Scorsese, che dei tre è decisamente quello invecchiato meglio, anche se nemmeno il suo corto riesce a decollare dai pochi clichè della vita del famigerato “artista postmoderno affermato”.
| Voto (2/5): |  |
164 - Ricomincio da capo
Il giorno della marmotta è forse uno dei film che meglio può incarnare lo spirito della festività pur non parlandone. Perché diciamocelo chiaramente: il Natale, così come ogni altra ricorrenza fissa da passare con la famiglia, è sempre uguale. C’è sempre la cena dalla zia, lo scambio dei doni, eccetera eccetera. Non cambia mai una virgola.
Ed è quello che succede al nostro povero Bill Murray. Che, come nell’italiano remake E’ già ieri, si trova imprigionato sempre nella solita situazione. Qualcosa di al contempo angosciante e intrigante. E’ intrigante perché sapere esattamente tutto quello che succederà è fonte di potere, nonché di sicurezza. Si sa di avere sempre una seconda opportunità, come nella ragazza che saltava nel tempo. Così come nell’ambito della famiglia natalizia ci si sente al sicuro dietro alle solite chiacchiere e banalità. Sensazione di potere, di controllo.
Eppure ci si accorge ben presto quanto sia soffocante tutto ciò. Quanto si vorrebbe evolvere, crescere. Non soltanto anagraficamente, non soltanto quando si è bambini si vuol crescere per avere regali sempre più grandi e belli, fino ad avere il potere della maturità. Anche quando si è grandi. Perché ricominciare sempre tutto da capo, da zero è frustrante. Si perde sì il dolore e l’incertezza. Ma si perde anche quel tentativo fortunato in cui siamo riusciti a mettere a posto tutto. Si perde il gusto di scoprire come va a finire.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
165 - Le dodici fatiche di Asterix
I galli Asterix e Obelix sono una coppia comico/parodica di cui non sono mai stato un grande amante. Come spesso accade in alcune scellerate serie comiche, i personaggi principali che si ritrovano a vincere sempre e ad essere sempre più furbi, più veloci e più forti sono fondamentalmente antipatici. Ma visceralmente antipatici. E’ il caso, ad esempio, di Jerry in Tom e Jerry, o di Topolino se raffrontato a Paperino. Oppure il personaggio principale è scialbo e piatto, con un celeberrimo caso in Madagascar, in cui le vere star sono i pinguini. Anche nel caso di Asterix e Obelix, a vincere sempre nei cuori di tutti sono sempre e solo i romani.
Tutto quello che viene inserito all’interno e all’esterno del villaggio gallico sa di spocchia e povertà di idee. Come il solito cliché antropico di modernizzare e umanizzare tutto. Vedasi un esempio recente nella società aliena di Planet 51 che è, guarda che sorpresa, un sobborgo alla Beverly Hills. Qui non mancano scelte ampiamente discutibili, come in tutti gli altri episodi della serie.
Queste dodici fatiche quindi sono qualcosa di scialbo che non riesce a sorprendere nemmeno alla prima visione. Figuriamoci di fronte all’ennesimo Natale in cui passa per il piccolo schermo. Uno di quei classici film su cui si rimane sintonizzati solo nelle case in cui c’è la malsana abitudine di tenere accesa la televisione anche quando nessuno la guarda, solo per far rumore e compagnia quando non c’è niente da dire.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (1/5): |  |
166 - Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato
Il solo e unico, inarrivabile anche dal pur onesto e godibile remake Burtoniano. La fabbrica di cioccolato di Willy Wonka è qualcosa che strega ed affascina tutti i giorni e a tutte le ore. Un passaggio televisivo che rimane fresco e sorprendente anche dopo secoli di reiterata visione (si accorgerà Damiano che anche questa, in fondo, è una versione nascosta del mise en abyme? Speriamo di no!).
Intendiamoci che la moraletta dietro il film è qualcosa di squallido ed esprimibile in due righe su un tovagliolo di carta. Ma immaginate questo tovagliolo di carta librarsi in aria e volare. Cambiare colore ad ogni spiffero d’aria. Attaccarsi al soffitto e far piovere ogni tipo di dolciumi. Sparire e riapparire a destra e a mancina. Beh, questo cambia tutto. Una forma colorata e giocosa, un Gene Wilder fantastico ai livelli di Frankenstein jr.
Willy Wonka è un pezzo di cinema da custodire gelosamente. E da esporre in ogni dove, quando l’occasione (che sia natalizia piuttosto che pasquale) lo richieda. Un cinema forse invecchiato, una scatola ripiena di buoni sentimenti tanto démodé. Ma che riesce a ritagliarsi anche un piccolo spazio di cattiveria e di politically uncorrect. Voglio studiare da Oompa Loompa!
| Voto (5/5): |  |
167 - Ghostbusters
Francamente non saprei cosa dire dei Ghostbusters, specie in chiave natalizia. Se non che loro stessi sono un bellissimo regalo che il cinema ha fatto all’umanità intera. Un dream team della risata anni ’80 come raramente se ne sono visti. Bill Murray, l’Aykroyd prima che si tramutasse in un mostro mangiasoldi, la Weaver e Harlod Ramis. Diretti da un Reitman che mai più si sarebbe espresso con una forza e una libertà del genere.
I Ghostbuster sono un dono all’umanità perché sono un concentrato di idee genaili in sceneggiatura, oltre che di scambi di battute epici. Epici ed estendibili, visto che almeno a livello di dialoghi anche il seguito, con cui forma un’indissolubile accoppiata natalizia, tiene botta. Dove il seguito viene a mancare è soprattutto nella scena madre finale. Il motivo è chiaro: la scena madre del primo Ghostbusters è già perfetta, irripetibile ed esageratamente anni ’80. L’enorme mostro di marshmallows non si può né ripetere, né migliorare. La scelta della statua della libertà ne è solido una pallida imitazione.
Ghostbusters sta benissimo nel suo personale eterno ritorno natalizio. Perché è, al pari di film come Pulp fiction, un film che si sa a memoria in ogni sua battuta ma che continua a piacere ogni volta che lo si guarda. Desiderando ripetere all’unisono le battute dei nostri eroi. “Sei tu…” o al diavolo, perchè scriverlo? Vediamolo!
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
168 - Akira
Il film di Otomo è rimasto per moltissimi anni un pilastro centrale dell’animazione Giapponese. Si può dire che il suo ruolo negli anni ’80 sia stato esattamente quello che ha svolto Ghost in the shell negli anni 90: il punto più alto dell’espressione tecnica (l’animazione è a livelli strepitosi, risulta più moderna e accattivante di molte produzioni odierne) e una riproposizione innovativa degli stilemi narrativi (sia di forma che di contenuto) tipici delle produzioni giapponesi.
Otomo trova la perfetta sintesi tra i contenuti del suo manga e l’animazione che mette in atto. Si può dire che questa integrazione raggiunga degli ottimi livelli ed esprima con i migliori mezzi possibili quello che aveva da dire. La stessa cosa non si può dire, ad esempio, per una successiva realizzazione di una sua opera, ovvero il remake di Metropolis. In Metropolis c’è un disperato tentativo di rendere più personale visivamente la veste dei contenuti, che rappresentano troppo spesso una riproposizione pedissequa di ciò che era già stato detto in Akira. Viceversa l’opera degli anni 80 non era solo più genuina in ciò che voleva dire allo spettatore, ma non si avverte minimamente il taglio tra forma e contenuto.
Akira è un tutt’uno molto meglio riuscito, segno di come l’adattamento di ciò che esce dalla matita di Otomo debba necessariamente essere animato da quella stessa matita. Il connubio manga-anime in Giappone risulta, dall’esempio paradigmatico di Akira, un tutt’uno quasi indissolubile e unico, poco riproponibile ed adattabile nella cultura espressiva Occidentale.
| Voto (5/5): |  |
169 - Palle in canna
Il cinema a stelle e strisce è fatto da uomini veri. O dalla proiezione di quello che per l’americano medio dovrebbe essere un uomo vero. Negli anni 80 e all’inizio dei 90 questo stereotipo era molto ben impersonato da Mel Gibson. Arma letale ha fatto il giro del mondo e rappresenta perfettamente queste tendenze piuttosto banalotte. L’essere straordinario che vive per la legge anche se è capace di andare oltre ogni limite per qualcosa di più grande: la Giustizia, che ti porta, qualche volta, anche ad infrangerla, questa vituperata legge,
E’ abbastanza ovvio che questo bersaglio era troppo grande per non essere colpito. In particolare Palle in canna riesce a smascherare in maniera magistrale quali sono le più comuni trappole di esagerazioni d’azione del genere. Basterebbe anche la prima bella scena del sigaro spento con la suola delle scarpe e la sparatoria al supermercato.
Questo film è così: pieno di trovate assolutamente superficiali e idiote. Talmente idiote che un po’ vi vergognerete a ridere così sguaiatamente. Ma il bello è che non ci si può proprio trattenere. Da segnalare anche la presenza intramontabile di un motherfucking Samuel L. Jackson, nella versione ostentata di quello che poi sarà il grandissimo personaggio di Zeus nell’altra grande parodia dell’azione statunitense: Die Hard 3.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
170 - Uccellacci e uccellini
I fan più superficiali di Totò dovrebbero stare alla larga da questo film. Chi si aspetta l’ennesima riproposizione delle solite scenette con Peppino non potrà che storcere il naso di fronte a questa pellicola. Eppure Pasolini è in grado di regalarci, ancora una volta, una delle più commuoventi e geniali interpretazioni del principe della risata italiana. Che poco hanno a che fare con lo scimmiottamento di se stesso che Totò faceva abitualmente di fronte alla macchina da presa.
l centro della vicenda è San Francesco e le sue prediche in giro per l’Italia. Una metafora di chi predica al vuoto, con tanta semplicità e poca gente che lo rimane ad ascoltare. Pasolini è abilissimo, molto più che nel Vangelo secondo Matteo, a mettere in risalto la carica eversiva e rivoluzionaria del messaggio cristiano. Se applicato fino in fondo esso diventa bandiera di libertà, del socialismo idealista, del contrario di quanto si vede applicato ogni giorno.
A tal proposito è ancor più squisitamente satirico il già ben comico personaggio del corvo. La parodia irriverente dell’intellettuale di sinistra radical chic, che già di per sé fa ridere per ogni parola che pronuncia. Ma nel presentare la disarmante maschera di ciò che rappresenta assurge a personaggio centrale e immancabile nel quadro della satira italiana, splendido e modernissimo ritratto del triste teatrino intellettual/politico che siamo costretti a vivere e a vedere ancora oggi.
| Voto (5/5): |  |
171 - Scary movie
L’interminabile sequenza di “Movie” film sembra non riuscire ad arrestarsi di fronte a niente. E se questo per la parodia e per la satira in genere dovrebbe essere un bene, per questa saga di film vale l’esatto contrario. Perchè i muri oltre i quali va si chiamano decenza, buon gusto e buon senso. Ultimamente i vari Hot movie e Disaster movie rasentano il vero e proprio ridicolo e lo spettatore è ormai arrivato a ridere di loro e non con loro.
D’altronde non è ben chiaro cosa aspettarsi da una serie di film che comincia, con questo Scary movie, dalla parodia di una parodia. Scary movie infatti nasce come rilettura satirica e instupidente (neologismi… bah quando passerà questa moda?) di Scream. Il problema è che non si è capito che già Scream era una parodia e una sottolineatura delle stupidaggini di cui era infarcito il teen horror statunitense. Scary movie è dunque la stupidaggine elevata al quadrato.
Intendiamoci: qualcosa mi ha fatto ghignare di brutto, almeno in questo primo capitolo. Il finto trailer di Amistad 2 per esempio era una vera e propria chicca. Ma tutto il resto è francamente evitabile (e ha avuto ben tre seguiti!). A questo punto, se si vuol ridere dell’horror per ragazzetti brufolosi (quello delle uccisioni fuori schermo e delle magliette attillate per guadagnarsi il visto censura dei quattordicenni) allora tanto vale andare dritti alla fonte dell’originale Scream di Wes Craven.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
172 - Frequently Asked Questions About Time Travel
I viaggi nel tempo con conseguenti paradossi sono veramente una delizia per le sinapsi. Posti di fronte a trame scritte da certosini (o presunti tali) lo spettatore si arma di tanta attenzione e prova a cogliere nel sacco chi ci vuole far rimanere affascinati. A tale sforzo, però, spesso non corrispondono prove di qualità sufficienti. Ecco perchè sempre più di frequente si ha la forte tentazione di mandare a quel paese registi e sceneggiatori. Con questa piccola perla di humor britannico è possibile rifarsi da tante frustrazioni in salsa science fiction.
Non cercate un filo logico a ciò che questi ragazzotti inglesi vi propineranno. Se all’inizio il film gioca nel presentare una storia evidentemente stupida, ma con basi concrete, ben presto si capisce che tale filo logico non esiste. Ed è comunque un piacere seguire le esilaranti avventure del terzetto protagonista (la scena di Total eclipse of the heart in bagno è veramente da ricordare negli annali, over and over).
Purtroppo questo FAQ About Time Travel ha un problema. Infatti avrebbe tanto voglia di rifarsi alla tradizione satirica britannica, a quel tal Shaun of the dead di cui da anni ormai si tessono le lodi in ogni dove. Ma se chiamare Shaun una parodia è un crimine, lo stesso non si può dire, con tutta la buona volontà e il divertimento, anche per questa pellicola. Non c’è alcuna possibilità di andare oltre il canone della parodia, ma alla fine non è nulla di cui disperarsi. Il divertimento c’è, ed è grandioso, come ad esempio nella Guida galattica per autostoppisti o in Doghouse.
| Voto (3/5): |  |
173 - Final Fantasy: The Spirits Within
Final Fantasy è una serie di videogiochi giapponese affascinante e controversa. Purtroppo nessuno di questi due aggettivi si possono associare anche ai due film che ne sono stati tratti, di cui questo è il primo. Nonostante al timone ci fosse l’ideatore originale della serie, questo Spirit Within si è rivelato scialbo, poco ispirato e insospettabilmente piatto.
Final Fantasy si spaccia come gioco di ruolo. In realtà la critica che molti gli fanno, e per questo motivo odiano la serie, è che non c’è la libertà di interpretare il proprio ruolo e non ci sono le classiche meccaniche di gioco come in un classico GDR. In Giappone fare un gioco di ruolo significa avere un ruolo e una storia ben delineata davanti e seguirla, come si segue un libro o un film (è il concetto di J-RPG). E la forza che ha fatto emergere Final Fantasy è proprio questa: una storia lunga, avvincente, affascinante, ben narrata e con personaggi ben caratterizzati. Ancora una volta rammarica far notare che questa lunga lista di qualità continua a mancare completamente in questo adattamento creato per mano di Sakaguchi.
Cosa rimane della serie originale? Rimane il fatto che è slegato a qualsiasi altro episodio della serie (un po’ poco). Rimane una tecnica visiva straordinaria per un gioco (del 2001), ma non per un film (del 2001), altro poco. Rimangono i temi di fondo: le infinite variazioni sul tema di Gaia, il ciclo della vita, il profondo senso di potere e sintonia col mondo innato nel protagonista. Ancora poco, pochissimo.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
174 - Hellraiser
Pinhead è è, tra i personaggi creati dalla penna di Clive Baker, forse il più popolare e pervasivo nell’immaginario collettivo. Forse proprio per questa ragione un film dedicato alle sue gesta è stato ritenuto, dallo stesso Baker, qualcosa di troppo importante per sfuggire al suo controllo. E si è messo alla direzione lui stesso. Creando con questo film e con il suo seguito un dualismo da yin e yang dell’adattamento cinematografico.
Hellraiser è un buon adattamento. Riesce a proporre le vicende del libro in forma efficace e anche con un certo gusto ed efficacia nel proporre il “mostro” attraverso l’effetto speciale. Il suo difetto principale è l’essere troppo classico, troppo un film da canone degli anni 80. La vicenda è inquadrata in maniera piatta e non profonda, e lo spettatore non è mai realmente proiettato a vivere la paura che viene proposta sullo schermo.
Viceversa Hellbound (Hellraiser 2) è molto più profondo ed emotivamente coinvolgente. Risultano però suoi difetti quelli che avevano salvato il primo capitolo dall’insufficienza. Ovvero un pacchiano uso dell’effetto speciale, un low budget spiattellato sulla faccia dello spettatore senza alcun minimo talento nel presentare questa situazione con più malizia cinematografica. Baker è assolutamente incapace nel riuscire a trasformare i suoi limiti in maniera funzionale alla storia, fatto che lo rende un regista decisamente mediocre, del tutto incapace di tradursi su pellicola.
| Voto (2/5): |  |
175 - Guida per riconoscere i tuoi santi
Il film di Dito Montiel guadagna punti nella scala di interesse nella storia degli adattamenti cinematografici: non solo il regista adatta un suo libro, ma adatta la sua intera giovinezza. Si può dire che il compito di Montiel diventi difficile al quadrato: posto che ogni opera è, in piccolo, un adattamento di un pezzo di mondo del proprio autore, come si comporta questo autore quando questo piccolo velo di mistificazione fantastica viene a cadere?
Non benissimo. Questa guida per riconoscere i tuoi santi è fondamentalmente un po’ banale. La storia di Montiel è unica per Montiel, ma non troppo per noi. C’è un qualcosa di già visto, c’è un pizzico di Mean streets che poco dovrebbe comparire, se si volesse raccontare una storia vera. C’è anche una certa autoindulgenza retorica e poco efficace in alcuni momenti, che ricorda certe cadute di stile alla American Beauty.
Non ingannino però tutte queste critiche. La componente stilistica del film riesce ad essere a tratti molti cruda ed efficace, sia nel comparto visivo che sonoro (la scena della martellata… ouch!). Assolutamente di spicco su tutti è Martin Compston, che con il poco tempo a lui messo a disposizione batte l’intero cast, da Downey jr allo sbarbatello LaBeouf. Un film che non rappresenta un buon adattamento, ma in generale che val la pena guardare.
| Voto (3/5): |  |
176 - 36
Olivier Marchal ha un’idea di cinema piuttosto ambiziosa. Sente sulle spalle il peso enorme di una tradizione francese che vede in Melville il suo esponente forse più famoso, ma è anche cosciente di quello che la contemporaneità sta offrendo al pubblico. E decide di cercare di soddisfare entrambe queste pulsioni. Prima di questo 36 si può dire che il suo cinema sia stato un fallimento, nel senso che non è riuscito a colpire il grande pubblico. Con la sfida tra Depardieu e Auteuil invece trova il ritmo giusto per esplodere.
Il cocktail è fondamentalmente una specie di mistura tra The heat e Frank Costello, con spruzzate di originalità di tanto in tanto. Si può dire che il risultato sia piacevole alla vista, molto più, ad esempio, del successivo L’ultima missione. Non riesce però a raggiungere le vette che gli permetterebbero di sfondare la barriera del solo intrattenimento. Questo perché Marchal si ferma a un lato più superficiale del raffronto tra la forza della personalità individuale e del bene comune. Porta sullo schermo una sfida tra due poliziotti nell’intendere il proprio lavoro e la propria missione. Ma questo scontro fallisce nel diventare critico, sia nei confronti della loro storia personale che della nostra.
Mann con The heat, e successivamente anche con il bel Nemico pubblico, va molto oltre. Va ad analizzare il complesso rapporto che sta tra il criminale e il poliziotto. Nella declinazione che può essere banalizzata con il famoso concetto: “Senza l’oscurità non esiste la luce”. Ovviamente la macchina da presa di Mann sa arrivare molto più in profondo di questa facciata. Marchal, invece, non lo fa.
| Voto (3/5): |  |
177 - Sbirri
C’è un limite di fronte al quale un progetto cinematografico dovrebbe fermarsi. Questo limite è rappresentato da quanto stupido una produzione crede che sia il suo pubblico. Purtroppo non tutti sono in grado di fare questa semplicissima inferenza e la prova vivente lo è questo Sbirri. Un progetto nato ad uso e consumo di un Bova che sta invecchiando, che ha sempre e saputo fare un ruolo solo e che non è mai uscito dal tunnel dei vari Ultimo o Palemo-Milano e viceversa, non so mai quale dei due è l’originale.
Vederlo agitarsi come un ossesso tarantolato di fonte a una finta ripresa documentaristica non aiuta, affatto. Bova è l’unico elemento dichiarato di fiction in quello che il regista vorrebbe rappresentare il vero. Purtroppo in Sbirri c’è un tragico capovolgimento del discorso metanarrativo del film. Bova assurge quindi a unico elemento vero del film, perché non è in grado di interpretare altro che se stesso.
Rimane desolante invece il suo sfondo. La “realtà” di Burchielli è all’atto pratico completamente finta e farsesca. Gli sbirri del film fanno finta di svolgere il loro lavoro di ogni giorno per le strade con telecamere nascoste. In realtà è palese la recita, volta a mascherare da cinema-verità una realtà che non conosciamo e di certo non comprendiamo affatto meglio dopo la visione del film. E allora tanto vale l’inutile docu-Tarantinismo di Polvere. Un’inutile e patetico spot da pubblicità progresso a cui non abbocca nessuno, nonostante quanto possano credere gli sbirri coinvolti nel progetto.
| Voto (1/5): |  |
178 - Overheard
Il poliziesco di Hong Kong è stato capace di rappresentare per molti anni una validissima alternativa ad alto livello di qualità registica e di intrattenimento al mainstream occidentale. Negli ultimi anni è stato anche testimone di un magistrale ciclone di cambiamento, in grado di rinnovare sotto svariati aspetti la sua poetica. Tale cambiamento è stato gestito da mani sapienti quali quelle di Johnnie To (Exiled), Derek Yee (Protégé) e molti altri. Come l’Alan Mak che sta dietro al trilogia di Infernal Affairs e anche dietro questo Overheard.
Tutto il gioco che scatena la trama sta nelle intercettazioni audio e video. Il gruppo di poliziotti che indaga sui finanzieri è sottoposto a una mole incredibile di dati, tutti filtrati e viziati dall’osservare (ascoltare) da un punto di vista ben preciso e uno solo. Proprio come la nostra quotidianità da bersagli del mass media di turno (che sia la televisione o il web 2.0 poco importa).
Tale parzialità non può che far nascere sospetti, errori di valutazione e disonestà. Se in Infernal Affairs il motore che muoveva la vicenda era sferico e imprimeva un modo di opposta attrazione tra i sue due poli (l’onestà e la disonestà), qui c’è solo spazio per una graduale discesa all’inferno. Che parte dal bisogno di soldi per un figlio malato, al rubare la donna a un amico, fino all’incredibile, mozzafiato e splendidamente tragico tuffo finale.
| Voto (4/5): |  |
179 - Miami vice
Ciò che rende esplosivo Miami vice nell’ambito del poliziesco è come tratta la figura principale del genere: il poliziotto. Non sarà sfuggito a molti il dettaglio che le imprese di Crockett e Tubbs in questo film mancano di una componente fondamentale. Uno dei crismi e dei dogmi inviolabili nella scrittura di una sceneggiatura. I personaggi in Miami vice non vengono introdotti.
L’incipit non ha nessun ritmo particolare, non crea un preambolo, nulla. Sembra quasi scritto da un dilettante. Nelle mani di Mann, tuttavia, questo è voluto e diventa creta da plasmare. Perché nella sua operazione vuole cercare di modernizzare il poliziesco. Di renderlo più reale e attinente a quello che ci sta accadendo attorno. E la prima operazione da fare è spazzare via l’aura di eroismo o di mitologia che sta attorno ai poliziotti da cinema.
Si può quasi dire che l’intento di Miami vice possa essere addirittura satirico e sottilmente ironico. Non necessariamente nell’accezione ridanciana del termine. Ma nel decostruire la mitologia poliziottesca (compito questo che rimane incredibilmente simile ad alcune delle scenette di Palle in canna, il film di Mann crea qualcosa di più. Un coinvolgimento e un realismo senza pari, sottolineato dal solito magistrale uso del futuro delle tecniche di ripresa.
| Voto (4/5): |  |
180 - Labyrinth
Labyrinth rappresenta per una fetta importante dei tardo ventenni e inizio trentenni di oggi una tappa importantissima della loro formazione professionale. La maggior parte di essi ha visto e amato le magie e i messaggi che questo film ha trasmesso alla fine degli anni ’80. Un sottoinsieme di loro inoltre, i maschietti direi, è anche di sicuro stato oggetto di scompensi ormonali da blocco della crescita (o da eccessivo sviluppo) dalla presenza scenica di una giovanissima Jennifer Connely.
Come per quanto riguarda la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, anche in questo caso non ci troviamo di fronte a un canovaccio da letture multistrato e profonde. Eppure Labyrinth riesce ugualmente a stregare e a dire la sua, a tutt’oggi. Innanzi tutto perché gli effetti speciali cartonati riescono comunque a reggere la scena, immersi in un mondo fantastico e infantile che nulla ha da invidiare ad Alice nel paese delle meraviglie in quanto a durata immortale nell’immaginario collettivo. E in seconda battuta perché le tematiche avventurose di Sarah sono un mix letale (in senso positivo) di clichè e modernità.
La ragazzina che sente la voglia di crescere è infatti un topos dell’adolescenza femminile. Ma l’aggiunta del piccolo fardello rappresentato dal fratello da cui ci si liberare è astuta e molto aderente alla poetica dell’egoismo e solipsismo che dagli anni ’80 tanto male ha fatto all’umanità fino ai giorni nostri. Scaltro e lungimirante, Jim Henson riesce a parlarci del presente e del futuro con lo stesso fascino e linguaggio universale del nostro passato reale e fantastico.
| Voto (4/5): |  |
181 - MirrorMask
Neil Gaiman è uno scrittore e sceneggiatore di fumetti assai talentuoso e fantasioso. Tra le sue opere si possono annoverare molti elementi ricorrenti, soprattutto una vena fantasy e dark molto marcata che lo rendono estremamente affascinante agli occhi di chi apprezza questa fantasia. Sfortunatamente tale stile e tematiche non sono molto semplici da riportare su pellicola e gli adattamenti cinematografici delle sue storie sono stati, fino ad adesso, piuttosto deludenti.
Prendiamo questo MirrorMask. Scopo dichiarato del regista è quello di portarci in un mondo incantato e fantasioso, popolato di meraviglie capaci di farci rimanere a bocca aperta. A bocca aperta rimaniamo, sì, ma per l’estrema bruttezza di tutto il comparto di effetti speciali. Una computer grafica plasticosa, insopportabilmente scadente e poco ispirata, non mascherata da una fotografia ridicola, mostrano evidentemente il fianco alle più facili critiche. La sospensione dell’incredulità davanti a un mondo così finto non sopravvive che pochi secondi.
Non è solo colpa del bassissimo budget però. Anche la realizzazione in fatto di rappresentazione e interpretazione da parte degli attori di quanto scritto su carta è poverissima. Così come dovrebbe essere la fase della maturazione della protagonista, impegnata nell’evitare di doversi trasformare in una “regina cattiva”, pensate, che si mette un po’ di rossetto scuro, mascara e osa rispondere a voce alta al padre (Orrore! Orrore!).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
182 - Il labirinto del fauno
Seguito, anche se narrativamente non collegato, del bellissimo La spina del diavolo, questo labirinto del fauno ci porta nel mondo di fantasia che prende vita all’interno della mente di una ragazzina. In questo caso il mondo fatato non corrisponde a una vera e propria crescita interna della psiche della protagonista, quanto più a una sovrastruttura con cui la piccola cerca di sopravvivere agli orrori che la circondano.
Come ne La spina del diavolo, infatti, siamo nella Spagna devastata dalla guerra civile. E gli orrori veri della guerra, tra partigiani, gerarchi franchisti e violenze alla madre vengono rimpiazzati dagli orrori finti delle tre prove del fauno. Una splendida metafora con cui la piccola protagonista cerca di rendersi padrona di una situazione che sfugge al suo controllo.
Nel labirinto del fauno si mescola una potente miscela fatta di fantasia e spettacolarità divina. Una fotografia e un uso dell’effetto speciale che rende unica ogni sensazione di fronte al capolavoro di Del Toro. Un mattacchione messicano che è stato in grado di regalarci, con questo film, alcune tra le più belle immagini viste nel 2006 proiettate su un grande telo bianco.
| Voto (5/5): |  |
183 - Nel paese delle creature selvagge
Max, un bambino come tanti altri. Gioca, ha una grande fantasia. Una madre a cui vuole un mondo di bene. E una piccola cotta da bambino. Max è assolutamente normale e, come tutti i bambini assolutamente normali, sente che il mondo che ha attorno gli va stretto. Da sua madre vuole più amore e attenzioni, dalla sua cotta vorrebbe almeno uno sguardo che ricambiasse i suoi sentimenti. Frustrazione e voglia di crescere lo rendono anarchicamente trasgressivo.
Questa miscela di anarchia e fantasia è dannosa per il mondo. Brucia più a fondo del napalm. Il mondo non è abituato a chi vuole percorrere a fondo la propria strada senza guardare in faccia a nessuno. E lo deve stigmatizzare, indicare, isolare. Max non ci sta e fugge via da una struttura oppressiva e asfissiante. Per trovare posto dove le sue pulsioni e le persone che abitano la sua vita divengono personaggi stilizzati ed enormi mostri da dominare.
Abbiamo quindi il lato tenero e testardo di Max. O la sua voglia di attenzioni. O la figura della madre saggia e protettiva (quanto sono dolci tutte le rappresentazioni che nel film suggeriscono la composizione di un caldo nido in cui rifugiarsi). O dell’amata. Grosse figure che non giudicano, ma sanno vivere in armonia con ciò che sta attorno a loro e che fanno capire a Max quale sia la vera strada da percorrere. Non repressione, ma nemmeno l’estremo opposto rappresentato dall’anarchia distruttiva.
| Voto (4/5): |  |
184 - The Good, the Bad, the Weird
Kim Ji-Woon non è nuovo ad esperimenti che sembrano rielaborazioni al limite della follia. Nel suo passato già c’era infatti un remake del pazzesco musical di Miike, Happyness of the Katakuris. Inoltre questo regista sudcoreano non ha nemmeno paura di affrontare maestri del noir e del poliziesco, come nel suo Bittersweet life. In questo caso la sua scommessa è quella di trasportare tutti gli elementi dello spaghetti western in terra di Corea.
Con piccoli inganni e grande attenzione ai dettagli, Ji-Woon riesce a riproporre gran parte degli stilemi che hanno caratterizzato il celebre film di Sergio Leone. L’epoca e la tecnologia è leggermente differente, ma gli elementi che si discostano dall’epica classica sono ben integrati all’interno del film. L’azione risulta piacevole e scoprire tutte le citazioni è un gioco appagante che può intrattenere lo spettatore.
Tuttavia il film scorre via senza riuscire a lasciare veramente il segno. La tecnica di Ji-Woon più che non essere all’altezza non sembra essere versatile a sufficienza. Si capisce da ogni elemento che non si sta vedendo uno spettacolo di trasformisti, ma solo di gatti travestiti da leoni che cercano di ruggire. Su tutte la recitazione del cattivo, con tutto il suo fard, è ridicolmente un classico sopra le righe coreano, per nulla credibile o coinvolgente.
| Voto (2/5): |  |
185 - The proposition
L’Australia si può facilmente considerare come un immenso West degli Stati Uniti. Viene naturale considerarla quindi un set ideale per un’epica storia di bovari. Quest’idea è frullata nella testa, tra gli altri, di uno scrittore non comune: Nick Cave. Dalla sua penna John Hillcoat ha tratto e diretto, con bravura, una storia che non ha quasi nulla di originale né di imperdibile, ma che risulta estremamente gradevole per lo spettatore.
La storia scritta dall’oscuro cantante è un classico che cerca di andare all’osso della natura umana. Una sofferta scelta tra il sacrificio di due fratelli si tramuta in una guerra personale. E’ un film ben interpretato, da un cast di solidi attori in grado di dare il meglio se diretti con criterio, e ben scritto.
Nick Cave riesce a dare alla sua storia un respiro ampio e regolare, fatto delle giuste pause, proprio come uno sceneggiatore professionista. Allo stesso tempo è in grado di fornire un’impronta personale alla sua sceneggiatura, senza rispettare delle regole che, applicate pedissequamente, divengono solo sterili nozioni. In questo lo aiuta di sicuro la sua carriera di cantautore, che rende l’andamento della sua sceneggiatura molto musicale, fatta di strofe e ritornelli. Grandioso anche il comparto musicale, da lui curato, le cui canzoni meritano senza dubbio un ascolto anche all’esterno della visione cinematografica (fatevi un favore e ascoltate la colonna sonora originale, in particolare Rider song).
| Voto (3/5): |  |
186 - Sukiyaki western Django
L’intero cinema di Miike nasce con l’essenza stessa dello straniante. Il regista giapponese col suo essere anarchico e fuori dagli schemi è in grado di indicare a tutti quali siano le incongruenze e le maschere di ipocrisia della vita. Tuttavia è ben meno innocente del bambino che esclama che il re è nudo. La sua forza eversiva sta nell’estrema rappresentazione della violenza, in accordo con la tradizione di un certo teatro antico Giapponese.
Il western in questo caso viene masticato e digerito secondo questi stilemi, trasformandosi in qualcosa al contempo di tradizionale e di innovativo. Tradizionale perchè si respira l’aria di quel teatro. Innovativo perchè lo è sempre l’arte quando entrano in commistione e nell’ibrido parti che sono sempre state lontane tra di loro.
Gli ingredienti di questo cocktail erano dunque esplosivi. Vedere il non esaltante risultato è dunque un doppio peccato. Sapere di poter vagare tra le stelle quando non ci si alza da terra è piuttosto frustrante. Miike ce la mette tutta per fornire la sua espressività al servizio dello spettatore (l’iper sturazione, le parti di animazione, lo sfondo iniziale). Ma non ce la fa, non questa volta.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
187 - Antonio das mortes
I cangaceiros in Brasile sono una figura non molto dissimile dai briganti che popolavano le strade dell’Italia nel periodo dell’unità nazionale. Un elemento più marcato aggiuntivo dei cangaceiros era la loro connotazione politica, che li rendeva in alcuni casi non dei banditi che colpivano a casaccio la popolazione, ma si conformavano come veri e propri capipopolo.
L’Antonio del titolo è un cacciatore di taglie, un cacciatore di teste di questi cangaceiros. Rappresenta dunque l’immagine della persona che combatte questi capipopolo e ne rifiuta il potere che hanno sulle persone. Si conforma come un liberatore dalle false convinzioni per ripristinare un ordine, lo stato di diritto, che dovrebbe essere superiore.
Ma il tempo passa e i cangaceiros si estinguono. E Antonio diventa un relitto, un uomo del passato, senza uno scopo per cui vivere. Su questo suo maliconico essere un uomo senza uno scopo, e sul ritrovare proprio in un rivoluzionario cangaceiro un rinnovato senso della via si gioca questo film. Che non è affatto facile, né per temi, né per ritmo. Ma è una gioia per l’anima.
| Voto (4/5): |  |
188 - Funny Games US
Il remake del più celebre film di Michel Haneke è qualcosa che va oltre il Bene e il Male. E’ un’operazione talmente smaccata, talmente estrema e dalla forte carica concettuale da correre su un rasoio sottilissimo. Da una parte sta il rischio di essere mandati, letteralmente, affanculo, dall’altra invece sta la possibilità di raggiungere una potenzialità espressiva e dissacrante che sta nelle massime vette dell’arte.
A mio avviso Haneke riesce a ricadere nella seconda branca. Analizzando questo film ci si trova di fronte a qualcosa di spiazzante al quadrato, rispetto all’opera originale già destabilizzante di suo. Se nel primo film la ferocia di una violenza con la facciata della rispettabilità e dell’educazione era spiattellata in faccia a un pubblico trattato proprio come spettatore impotente, qui il gioco viene portato ai suoi estremi. Funny Games US è infatti un remake fotocopia in cui tutto è esattamente come nell’originale. Perfino la villetta in cui è ambientata la vicenda è ricostruita alla perfezione nei minimi dettagli com’era allora.
Lo spettatore viene chiuso in un eterno ritorno dello spettacolo della violenza in sé. E’ rimarcata e sottolineata la sua totale passività e impotenza, imbrigliata in qualcosa che conosce benissimo, sa già come va a finire, ma per cui non ha alcun modo di impedire lo svolgersi degli eventi. Il remake fotocopia è anche un’arte di sottile ironia nei confronti di politiche distributive e di isolamento culturale, che trova nell’americanizzazione di attori e lingua una forte satira che Haneke rivolge verso gli USA.
| Voto (4/5): |  |
189 - Adaptation
Scrivere un film partendo da un’altra opera fatta e finita è un’operazione piuttosto comune nell’industria cinematografia. Charlie Kaufman in questa sceneggiatura riesce a declinare questo aspetto in maniera assolutamente esemplare. Perchè questo Adaptation prende le sue mosse dalla parola, l’adattamento, e la analizza in entrambi i suoi significati: quello dell’adattamento in senso cinematografico e quello naturale, il mutare del proprio essere al mutare dell’ambiente in cui ci si trova.
Come un novello Bergonzoni della celluloide, Kaufman a partire dallo stesso significante riesce a creare un significato unitario, in cui scrivere una sceneggiatura significa risolvere i propri problemi esistenziali, il nostro non sentirci “adatti” al mondo che ci circonda, alla società, alle convenzioni. Un film sul malessere dal pensare troppo, che riesce a divertire e intrattenere pur nella sua estrema vena sagace, ben diverso dal pomposo e irritante Arcand del Declino dell’impero americano.
I meriti enormi di Kaufman (e citiamo ancora tra gli altri la satira sulla produzione Hollywoodiana o il riuscire a scrivere una sceneggiatura esemplare da un libro senza trama) rischiano di schiacciare la pur meno visibile regia di Jonze, più dimesso e sottinteso degli altri suoi film, su tutti il citato Essere John Malkovic.
| Voto (4/5): |  |
190 - The grudge
Takashi Shimizu un giorno ha avuto una bella idea. Non particolarmente originale nella sua terra natale, ma molto forte nel suo svolgimento. Ha preso la classica storia di aragami giapponese, creata sul tema del rancore (una falsariga scintoista): gli aragami sono fantasmi che cercano vendetta per la loro morte violenta. Decine e decine di film hanno questa trama. Ma Shimizu è stato capace di portarla sotto una luce diversa.
Il suo film originale era diviso in sei episodi tutti uguali in cui il protagonista cadeva lentamente dentro le tele tessute da questi aragami. Una volta data la vita a una struttura del genere, Shimizu si è reso conto che questo gioco da eterno ritorno (ma porca miseria! La farò mai una variazione senza Mise en abyme?) poteva essere prolungato all’infinito. E, infatti, lo ha fatto.
I seguiti del Ju-on originale non si contano. Ma più che seguiti si può parlare senza remore di remake. In quanto le situazioni non hanno una vera e propria evoluzione narrativa (si pernsi al seguito). Dove Shimizu cade è nell’import statunitense che qua consideriamo. Perché se rimane l’impianto dell’aragami, cambia tutta l’originalità dell’inquadratura ad eterno ritorno. Piegata alle necessità di linearità e di protagonismo a stelle e strisce, la sua storia diventa povera, sfilacciata, poco efficace e vista altre mille volte.
| Voto (2/5): |  |
191 - Tetsuo 2
Il seguito al celeberrimo Tetsuo non nasce dalla volontà di sapere che cosa succede dopo gli eventi raccontati nel primo film. Tsukamoto ha sempre dichiarato che Tetsuo 2 è semplicemente “quello che sarebbe successo se Tetsuo si fosse trovato in una situazione differente e/o avesse compiuto scelte differenti”. Non più peni-trivella e scontri di volontà di potenza riecheggiati in Meatball machine, ma uno scenario, a colori, totalmente differente.
Innanzi tutto il metallo di Tetsuo si trova inserito più organicamente all’interno del tessuto cittadino. Nella Tokyo cementata e terrorizzante che sarà tipica della poetica del primo Tsukamoto. Vengono poi innestati nel film temi quale il culto e la modellazione del corpo da parte del potere per i propri scopi. Questa volta Tetsuo è più vittima che inconsapevole portatore ed estremizzatore delle proprie volontà.
Vittima di un mondo che con le minacce alla famiglia nel vuole alterare e studiare il corpo. Un’evoluzione di una macchina da distruzione mascherata da innocente competizione (molti sono i rimandi allo sport che torneranno poi in Tokyo fist). Tetsuo 2 rimane inferiore al primo solo in quanto sequel, privo dell’eversione anarchica della giovinezza, della fantasia, della mancanza di mezzi che aguzza l’ingegno.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
192 - L'uomo che sapeva troppo
Hitchcock è l’uomo che sapeva troppo del cinema. A lui si devono moltissime “scoperte” che hanno reso il cinema, di intrattenimento e non, quello che è oggi: un grandissimo spettacolo in grado di emozionare nel profondo. I suoi innumerevoli colpi di genio fondamentalmente si possono riassumere in pochi concetti (invito alla lettura: il dialogo, e non intervista, che ebbe con Truffaut).
Con questo remake la sua intenzione era quella di prendere l’originale ed epurarlo da tutti i piccoli difetti che lo avevano reso meno di perfetto proprio per alcune mancanze in questi principi. Abbiamo quindi, ad esempio, alcune trovate migliori (un ritmo decisamente meglio sostenuto nella scena madre, inquadrature più consapevoli, interpretazione di James Stewart più intensa) che rendono la visione del remake decisamente più appagante dell’originale. Tuttavia questo uomo che sapeva troppo rimane un passaggio sì necessario nella sua filmografia, ma non quella vetta e quell’incredibile miglioramento dell’originale che viene spacciato.
L’idea che sta dietro alla pellicola è quella dell’uomo comune schiacciato da ciò che sa e diviso tra ciò che è giusto per tutti e ciò che è giusto per lui. In questo il divismo di Stewart aiuta poco, e il più dimesso originale, con tutti i suoi difetti (alcuni nemmeno qui risolti del tutto, si veda la straordinaria idea dei piatti ancora non abbastanza esplicita per il pubblico) risulta essere una pietra miliare ben più importante per il cinema.
| Voto (3/5): |  |
193 - Il caimano
Avere una sceneggiatura bomba tra le mani, un argomento scottante e cose da dire, vi mette in cassaforte? Ovviamente no. Nanni Moretti con questo film straordinario ci introduce ai problemi della produzione cinematografica in Italia. E lo riesce a fare in maniera pungente, senza troppi piagnistei o retoriche. Confezionando tra l’altro il suo film tecnicamente più appariscente ed espressionista.
Il caimano ha cinematograficamente i tratti della genialità. Promosso come un film su Berlusconi, è in realtà un film sull’influenza della sua figura. Non c’è spazio per lui nel film, ma solo per gli effetti che lui ha sulla realtà. Ed è stato al centro di numerosissime polemiche circa i suoi contenuti. Il tutto pre-visione, perchè una volta visto ci si rende conto che la satira non è su Berlusconi, ma su coloro che lo attorniano e lo idolatrano. Esattamente coloro che hanno fatto polemica, idolatrandolo, perchè il caimano era contro Berlusconi (geniale).
Nel caimano c’è poi molto di più. C’è la gerontocrazia italiana incapace di dire qualcosa di nuovo e di scommettere sui giovani e su chi quel qualcosa di nuovo ce l’ha. C’è la crisi della famiglia italiana, trattata con tutt’altra retorica rispetto a un ultimo bacio qualsiasi. C’è tutta una serie di contenuti e sfaccettature che chi ha la miopia e la faziosità negli occhi non è in grado di vedere. Non prima che sia troppo tardi.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
194 - Effetto notte
Si potrebbe stare a parlare giorni interi di questo film e della splendida cinematografia di Truffaut in generale. Soprattutto nella scuola di cinema di Five Obstructions. Perchè Truffaut come pochi altri sa essere davvero un maestro di cinema. Non perchè particolarmente bravo, cosa che comunque è, ma nella vera accezione di maestro: colui che si siede accanto a te e ti spiega tutto (lettura obbligatoria: Il cinema secondo Hitchcock, un dialogo tra il maestro e lo stesso Truffaut).
Se una piccola lezione da questo Effetto notte la si vuole ricavare, è quella della preziosità del tutto. “Il regista è uno che si limita a rispondere a domande” o “Davvero ho fatto tutto quello? A me è sembrato di essere stata soltanto seduta” sono battute epocali che fanno intuire in un lampo che noi non siamo nulla senza gli altri. Che l’ordine dal caos, il film dal set, il senso dalla vita vera, lo si raggiunge insieme e se tutti sanno dare il meglio di sé nel piccolo che ci è concesso e che a noi sembra niente.
Per il resto è inutile stare a ricamare troppo sopra questo film. Effetto notte è uno spaccato di vita vera, coi suoi drammi e le sue risate, una ventata d’aria dal cervello al cuore che non può non lasciarvi col sorriso sulle labbra. Pronti a un nuovo “Ciak si gira”, giorno dopo giorno, sapendo dar meglio il peso alle cose che ci circondano.
| Voto (5/5): |  |
195 - Scream
All’inizio degli anni 90 l’horror, in particolare quello americano, era rimasto marginalmente colpito da film postmoderni. Tutto questo fino all’arrivo di Scream, un’opera in grado di rappresentare un vero e proprio spartiacque tra un prima e un dopo. Un’opera che ci aiuta a capire come, da quel momento, un film avrebbe dovuto sempre di più fare i conti con l’ira dei propri spettatori. Scream è un film fondamentalmente dalla doppia anima.
La prima è la genialità e l’originalità di trattare e catalogare tutti gli stereotipi dell’horror anni 70-80-90 e sputarci sopra con un’esplicita sfrontatezza che in pochi avrebbero avuto il coraggio di mettere in pratica. E’ stato un precursore sociale inimmaginabile, anticipando di anni i comportamenti che ha aiutato a diffondere e a dilagare tra il pubblico. Specialmente anticipando di un lustro buono l’esplosione dei tipici comportamenti online su forum e social network.
La seconda è ovviamente intimamente collegata alla prima. E’ veramente un pregio l’essere gli anticipatori della distruzione della sospensione dell’incredulità e dell’omologazione a Scream succeduta? Scream poteva essere un punto di inizio per l’originalità. Invece è stata la pietra tombale dell’horror mainstream statunitense, al punto da non riuscire a distinguere i suoi seguiti da uno scary movie qualunque.
| Voto (2/5): |  |
196 - Encounters at the end of the world
Preannunciato dal simile L’ignoto spazio profondo, questo film di Herzog è esattamente il manifesto di come desidererei invecchiare. Da sempre l’occhio dei documentari di Herzog è stato in grado di riconciliare l’occhio dello spettatore con l’uomo a cui assiste. Si può non condividere, si può perfino non capire, ma non si può negare di aver raggiunto un contatto empatico fortissimo con quello che si guarda. Tuttavia qui si va oltre.
Herzog questa volta non rappresenta in realtà la storia di qualcuno. Ci sono, è vero, le persone che abitano la base artica. Ma questo documentario è fin dai suoi intenti un documentario su Herzog stesso. E’ lui in prima persona che cerca di stabilire il suo proprio contato empatico con lo spettatore. Gli vuole far provare quello che prova lui stesso, da novello sessantacinquenne. E quello che prova quest’uomo alla soglia dell’anzianità è qualcosa di infinitamente poetico e commuovente.
Herzog, e lo spettatore con lui per via della magia del suo cinema, regredisce allo stato infantile. E’ un occhio in grado di meravigliarsi di qualsiasi cosa. Di vedere le bellezze di un angolo sconosciuto del pianeta, di stupirsene come in un paesaggio alieno, di trovarsi alle soglie di un mondo nuovo o alla fine di uno vecchio ma ancora carico di infinite meraviglie da scoprire.
| Voto (5/5): |  |
197 - Segreti di famiglia
L’ultima svolta che ha preso la carriera di Francis Ford Coppola si può rapportare come diametralmente opposta a quella di un altro grandissimo e suo eterno “rivale”: Martin Scorsese. Scorsese con film quali The departed e Shutter island ha deciso di mettere il suo talento e la grandiosa esperienza maturata negli anni al servizio di film commerciali, d’impatto e grande distribuzione. E lo fa alla grande con risultati eccellenti, dai quali ognuno a Hollywood dovrebbe trarre qualche lezione.
Coppola ha deciso di andare nella direzione opposta. Ha deciso di essere un autore intoccabile e ha cominciato a filmare solo ciò che gli aggradava. Da Youth without youth ha cominciato un percorso intimo all’interno dei temi e degli stilemi espressivi che più lo interessano e appagano come professionista. Impossibile non notare l’enorme differenza distributiva delle opere di questi due autori, una dicotomia tra pubblico e privato assolutamente inconciliabile.
Questo Segreti di famiglia ne rappresenta l’ennesima potenza. Coppola parla delle radici, della famiglia, del ritorno alle origini come e meglio del precedente film con Tim Roth. E’ questa la direzione intima che prende il suo cinema. Affascinante e realizzato come solo lui sa fare. Tuttavia rimane il dubbio su quanto questo suo ripiegarsi su se stesso sia effettivamente una scelta in grado di generare i frutti migliori: si notano ogni tanto alcuni difetti troppo autoreferenziali (gli sbarluccichii…), troppo poco in grado di reggere al di fuori, appunto, della testa di Coppola. Io continuo a preferire la via scelta da Scorsese, più capace di lasciare il segno. Per quanto il pur bravissimo Di Caprio mai sarà come il gigantesco e magnifico Vincent Gallo di questo film.
| Voto (3/5): |  |
198 - La terza madre
Avete presente i vecchi che stanno seduti sulle panchine del parco brontolando a ogni persona che passa e raccontando interminabili aneddoti su quanto erano forti e intrepidi da giovani. Ecco: Dario Argento è esattamente così. La sua filmografia passata lo ha fatto, giustamente, diventare uno dei Masters of horror. Anche se svariate rivalutazioni verso il basso sono state fatte, anche dal sottoscritto, ciò non toglie che il suo stile e il suo talento non abbiano trovato un posto e una valutazione più che dignitosa.
E poi… E poi è tutto finito. Non è chiaro ben il motivo, ma è tutto passato. Siamo stati costretti a sorbirci sul grande schermo delle oscenità come < href='http://www.imdb.it/title/tt0330691/'>Il cartaio con Silvio Muccino e questa terza madre. E la cosa più tragica è che se si analizzano gli elementi, soprattutto di quest’ultimo film, ci si rende conto che lo stile di Argento, sotto sotto, non è cambiato. La costruzione delle scene, la fotografia e la colonna sonora non si distaccano molto da quelle che avevano rese grandi pellicole come Suspiria.
E’ dunque colpa dello spettatore se esso si è allontanato da questi elementi stilistici? Non credo. Dario Argento con la senilità ha mostrato una totale incapacità ad adattarsi ai tempi che cambiano. Ha preso il suo vecchio cinema e lo ha portato di peso negli schermi moderni. E il risultato è troppo lontano da noi, troppo anni ’70-’80. Rimane simile più a una parodia di se stesso che non al tentativo di dire davvero qualcosa, non dico di nuovo, ma almeno di degno erede di ciò che è stato.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (1/5): |  |
199 - Ponyo
Lo studio Ghibli è uno dei più grandi regali che una persona potesse fare all’umanità. Miyazaki ha creato qualcosa che con il suo genio va ben oltre quello che è stata la Disney in America (e ora lo è la Pixar). Il buon Hayao pare negli ultimi anni essersi voltato indietro per vedere ciò che ha fatto e trarre le sue conclusioni. Può essere letto in questo senso il bello rifacimento di buona parte della sua filmografia con Il castello errante di Howl.
Curiosamente con questo Ponyo la carriera di Myiazaki assume un inusuale parallelismo con i suoi film. E’ opinione comune infatti che, a parte alcune eccezioni, i film di Miyazaki abbiano finali frettolosi, poco connessi con il resto della storia e quasi sospesi (basti vedere quello del già citato Howl, uno dei più imbarazzanti). E’ lo spirito di riconciliazione, la sua anima shintoista, la sua grande attenzione al pubblico infantile che lo portano a tali esiti. Spesso pregevoli, altre volte no. Ponyo è tutto questo: è l’inizio del finale della sua carriera.
E come tale diventa per la sua intera durata un inno di riconciliazione con il padre lontano, con lo spirito scintoista ed ecologista del signore del mare e questa volta quasi esclusivamente dedicato all’infanzia. Se opere come La città incantata stanno tranquillamente a fianco di libri come Alice nel paese delle meraviglie per l’incredibile profondità psicologica e filosofica messa in un’opera dedicata ai più piccoli, questo non si può dire per Ponyo. Forse il film di Miyazaki col target più chiaro, ma non per questo il migliore.
| Voto (3/5): |  |
200 - Number 23
Il film di Joel Schumacher fa proprio parte di tutta quella stuoia di numerologi che cercano di stupire la gente comune con dei falsi sofismi sull’ubiquità delle combinazioni di numeri “esoterici”. In particolare qui il protagonista è ossessionato dal 23: tutto ciò che lo circonda sembra essere riconducibile al numero 23.
D’altronde avendo a disposizioni un sacco di operazioni (somme, differenze, divisioni, moltiplicazioni, eccetera) e una buona fantasia si può derivare tutto da tutto. Un po’ come fa il dottor Agliè mettendo in corrispondenza la distanza Terra-Sole, il pi greco, la battaglia di Poitiers e la formula della naftalina con la lunghezza del ripiano di un chiosco per strada. Le due cose sono fondamentalmente equivalenti. Per cui: che cosa fa diventare Eco un genio e questo film una delle peggiori scemenze che potreste mai vedere sul grande schermo? L’ironia e la satira. Eco ne è pieno, questo film non ne ha nemmeno un po’.
Schumacher è convintissimo di quello che mette in scena. Crede alla sua serietà e prova a montare sul 23 una grande tensione e disperazione, tra l’altro mal interpretata da un eccessivamente enfatico Carrey. E siccome questa tensione poggia sul niente, su balle e posizioni ridicole, tutto quanto cade come un castello di carte. Eco ti fa ridere con lui, Schumacher ti fa ridere di lui.
| Voto (1/5): |  |
201 - Pi
Il pregio più grande di Pi è quello di trattare la numerologia e l’ossessione verso di essa in maniera matura. Ovvero scindendo la sua componente soggettiva da quella oggettiva. Nella componente soggettiva i numeri rappresentano l’ossessione della mente malata del protagonista che cerca di declinare la realtà secondo essi. Tutto questo avviene dentro di lui e nella sua interfaccia con il mondo.
All’esterno le cose che accadono sono molto diverse. Aronofsky ce ne dà la visione da una piccola, ma completa, finestra. Ciò che funziona è la previsione dei numeri sui numeri, l’autoreferenzialità della matematica. Ovvero la previsione dei risultati di borsa, niente più e niente meno del ben poco esoterico data mining che si fa in ogni laboratorio informatico. Quando entra in gioco il misticismo, la cabala e la religione i giochi cambiano.
Il divario tra soggettività e realtà vuole essere annullato, cercando di declinare la seconda con le logiche della prima. Cercandone un misticismo divino nascosto. E tutto ciò inevitabilmente fallisce. Come un trapano che vuol fare uscire i pensieri dal cervello. Ma si sa bene qual è l’unico risultato che un’operazione del genere può portare. Ecco: Pi è maturo nel far capire che cercare complottismi numerologici nella realtà è proprio come cercare di far uscire pensieri da una testa con un trapano…
| Voto (4/5): |  |
202 - Numb3rs
Numb3rs prende la cabala e cerca di vestirla di nuovo. Basterebbe semplicemente questa frase per liquidare l’intera serie e passare ad altro. Ma sono buono e svilupperò un po’ il concetto. Il punto di partenza di questa serie è semplicemente declinare secondo modernità un genere che ha sempre avuto luogo nel fantastico (o, al limite, nella ricostruzione storica). Numb3rs è per la cabala quello che il genere dello “scienziato pazzo” (Re-animator?) è per la storia orrorifica di streghe e orchi.
Ovvero si prendono gli stessi topoi narrativi e si cerca di dargli una connotazione autoritaria, scientifica, credibile. E’ questa un’operazione riuscita nel caso Numb3rs? Sostanzialmente molto dipende non tanto da episodio a episodio, quanto da spiegazione a spiegazione. Certo, è un po’ ridicolo che il personaggio protagonista riesca e mettere in campo una cultura che va ben oltre a quella della matematica e sconfina praticamente in ogni branca dello scibile umano, ma questo fa parte delle necessità della funzione narrativa (serve un personaggio solo, averne dieci non ha senso) e si può liquidare con un po’ di abuso della sospensione dell’incredulità. Peccano veniale, rimandato a Settembre.
Dove molti non perdonano Numb3rs, né opere dello stesso genere, è nell’inesattezza di quasi tutti i concetti scientifici che vengono presentati. Se questo è vero, è anche vero che tutto questo rientra comunque nella sospensione dell’incredulità: nessuno dovrebbe trattare queste finzioni come oro colato: sono tutti adattamenti spettacolarizzanti, come in ogni altro genere. Bocciare Numb3rs per questo è pura miopia. La sufficienza non la raggiunge per pura piattezza tecnica realizzativa. In televisione ormai si vede molto di meglio, non la si può più prendere come scusante, oltre al già citato eccessivo abuso di qualcosa da usare con saggezza e parsimonia: il mutuo patto tra finzione e spettatore.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
203 - La nona porta
La nona porta rappresenta forse uno dei punti più bassi della filmografia di Polanski. Anche perché era una buona occasione per la grandissima ironia che il personaggio ha saputo mettere in alcune delle sue pellicole più riuscite (cito ad esempio l’ottimo Per favore non mordermi sul collo). Di più: era un’occasione perfetta: il soggetto della cabalistica, dei misteri esoterici, mostrava e mostra il fianco con un’ostentazione ammirevole. Ma Polanski ha deciso di non farlo.
La vicenda mal interpretata da un Depp scialbo come non mai è un classico thriller sovrannaturale che porta il suo protagonista ad entrare nelle maglie di grandissime cospirazioni segrete quasi per caso. Viene trascinato dentro dal suo lavoro che lo connette con libri antichi e dai non meglio chiariti poteri occulti. E quando era il momento di far crollare tutto il castello di carta, Polanski comincia a inserire elementi fumosi e poco chiari, testimoni del fatto che non ha intenzione di rendere più ridicoli di quanto già non siano i vecchiardi incappucciati che pensano di richiamare il diavolo al plenilunio.
A questo punto, permettetemi, io vado a preferire quella faccia da pirla (in senso di positiva simpatia) di Nicholas Cage il cui Mistero dei templari diretto da Turtlelab non è una satira esplicita, ma è talmente ridicolo e autoreferenziale da essere una satira implicita. Insomma: più stupido dello stupido che sa di essere stupido c’è lo stupido che fa l’intellettuale (e io parlo per esperienza diretta, appartenendo alla seconda categoria).
| Voto (1/5): |  |
204 - Aspettando il sole
Per fare un tristissimo gioco di parole con il titolo, questo è un film che proprio non ti aspetti. Se non ci fosse stato un mostro sacro come Bellocchio probabilmente con questo esordio il buon Panini si sarebbe portato a casa lo scettro del 2009. Intendiamoci: il film non è un capolavoro assoluto, di ben altra caratura era, ad esempio, l’esordio di Sorrentino. Quindi non sto celebrando la nascita di chissà quale grande autore italiano. Ma un bravo cineasta, questo sì.
I personaggi di Panini animano uno sperduto hotel/capannone della periferia in una notte come tante altre. Ciò che è affascinante e sensibile nell’occhio del nostro esordiente è la facilità con cui riesce a dare un aspetto crepuscolare al suo film. Ci si trova ad abitare con essi in una terra di mezzo, senza un vero scopo se non quello di “passare la nottata”. Un’umanità un po’ allo sbando, un po’ persa, un po’ senza motivo.
Un po’ come il film stesso può rapportarsi alla cinematografia italiana contemporanea. I suoi personaggi non sono altro che registi e autori che si trovano in un albergo decadente, corroso dall’interno da termiti sciocche e spietate. Autori il cui unico scopo è aspettare il sole: mezzi e sensibilità con cui esprimersi in un mercato meno chiuso alla novità. Il fatto che qualcuno ci riesca non esclude che in molti siano persi in questo limbo.
| Voto (3/5): |  |
205 - District 9
Blomkamp è riuscito a fare ciò che quasi tutti gli autori sognano: poter esordire con ingenti finanziamenti, mezzi a volontà e con il progetto che si porta avanti da sempre. Un po’ come se Tarantino fosse riuscito ad esordire immediatamente e direttamente con Pulp fiction, per intenderci. District 9 infatti è la versione ricca e lunga del suo Alive in Joburg, cortometraggio eccellente e assai promettente.
Si può dire che il regista sudafricano sia riuscito a pieno nel suo intento? Analizzando il film si possono trovare moltissimi elementi positivi. La realizzazione tecnica è al limite del perfetto, gli effetti visivi sono spettacolari, così come le scene d’azione. La sceneggiatura, figlia diretta del cortometraggio d’esordio, è originale al punto da consegnarli la palma del miglior film di fantascienza d’azione del 2009. Sì, è un successo professionale. Ma dubito che sia un successo personale.
Alive in Joburg aveva più idee nei pochi minuti che aveva a disposizione. Il suo essere un cortometraggio gli dava dei limiti, ma entro quei limiti giocava alla perfezione. In District 9 il dover avere un ampio respiro genera alcuni cortocircuiti (la divisione tra umani e alieni cercata per tutto il film, il non perfetto amalgamarsi dei molteplici punti di vista sulla trama, …) che ne minano le basi.
| Voto (3/5): |  |
206 - Halfway
La giapponese Kitagawa pensava di trovarsi le spalle ben coperte per il suo esordio al lungometraggio. La pellicola narra la storia di una coppia di amici del liceo che presto vedrà la separazione, in quanto Shu, da sempre amore di Hiro, ha deciso di trasferirsi a Tokyo per l’università. Hiro arriverà a chiedergli di non partire per non perderlo. Spalle coperte perché la sua sceneggiatura è stata firmata da Iwai Shunji, che da Ghost soup sembra sia nato per scrivere e dirigere storie del genere.
Il film non riesce a funzionare appieno. Kitagawa arranca scena dopo scena, ingarbugliandosi in un ginepraio dal quale non riesce ad uscire senza una abbondante e scontata dose di banalità giapponesizzanti assortite. E fa impressione dover annotare, accigliati, che probabilmente la colpa maggiore non è sua. E’ proprio l’ingarbugliata sceneggiatura di Iwai a fare acqua da tutte le parti. E questo, al buon Shunji, è ben difficile da perdonare.
Non sono quindi da imputare alla Kitagawa le peggiori pecche di un film che non riesce a convincere o a far provare empatia per i propri protagonisti. La sua macchina da presa non è comunque capace di operare tale piccola magia, e lascia ben pochi spazi a speranze per il futuro.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
207 - Handphone
Può un film essere salvato dai suoi ultimi quindici minuti? Questa sembra essere una domanda ricorrente nella Corea del Sud. In questo mercato cinematografico, infatti, è facile trovare molti esordienti alle prese con grandi produzioni, anche di genere. Un mercato esploso agli inizi del decennio scorso sia per la qualità (Oldboy) che per i grandi blockbuster (2009: Lost memories) che per l’intersezione tra i due precedenti insiemi (The host).
Tuttavia in quest’esplosione è molto comune vedere dei progetti abbastanza standardizzati in molti aspetti: recitazione, regia (sempre di altissimo livello, ma poco variegata e poco dedita a riletture personali, proprio come in questo Handphone) e passaggi di sceneggiatura. Ed è proprio questo il punto peggiore di Handphone. Il film dura abbondantemente più di due ore e per queste due ore i due protagonisti non fanno altro che farsi i dispetti. Giuro: quella che dovrebbe essere una sfida sanguinosa tra due uomini uniti e messi contro puramente dal caso sembra una baruffa dell’asilo.
Alla fine si scopre il motivo per cui è stato girato il film, cosa che era assolutamente incomprensibile per tutta la durata della pellicola, con il money shot finale. Il problema di Handphone è che si regge solo su due idee: quella iniziale non è molto originale e quella finale sarebbe anche in grado di farvi saltare sulla sedia, se non vi foste addormentati un’ora e mezza prima…
| Voto (2/5): |  |
208 - I diari della motocicletta
Fin dallo slogan che fa da sottotitolo al film (“Before he changed the world, the world changed him”), Walter Salles mette subito in chiaro che cosa vuole essere il film. Mette in chiaro fondamentalmente che, anche se il protagonista di questo film si chiama Ernesto Guevara De La Serna, questo non è un film sul Che, ma è un film on the road dall’inizio alla fine e non c’è spazio per altro nella pellicola.
Salles mette in scena il Viaggio puro e semplice. E tutte le altre considerazioni che possono essere fatte sulla figura del Che vengono di conseguenza da quella meravigliosa invenzione che è il Viaggio. Il viaggio è “spostarsi da un punto all’altro”, ma nel Viaggio tutto questo sapore asettico non c’è. Nel Viaggio ti sposti da un punto all’altro anche nella tua visione del mondo. Ovvero abbandoni una visione solo teorica, stereotipata, rinchiusa nel tuo recinto di terra e abbracci le cose per come sono realmente, allarghi il tuo orizzonte.
Insomma: nel Viaggio scopri la realtà per quello che è, non per quello che dovrebbe essere secondo la tua personale visione della vita. Questo è quello che racconta Salles nel suo film. E quello che trasforma un ragazzo con qualche ideale e una carriera di medico davanti in Che Guevara. Salles in fondo ci dice che per essere il Che non serve essere un simbolo da stampare nelle magliette (come invece suggerisce il Soderbergh nella sua agiografia). Serve solo vedere il mondo.
| Voto (4/5): |  |
209 - Into the wild
La vita di Chris McCandless è per molti un enigma incomprensibile. E’ la storia di un ragazzo che aveva nella sua gioventù il mondo ai suoi piedi e ha deciso di mettercelo davvero, questo mondo sotto ai piedi. Ha abbandonato tutto quanto di borghese aveva costruito fino a quel momento e ha deciso di viaggiare, solo con se stesso e con le sue forze più primitive ed elementari. Un gesto che viene spiegato, da chi non lo capisce, come egoismo o codardia.
A mio avviso la giusta lettura è la prima, l’egoismo. E Sean Penn con questo film dimostra di pensarla come me e come lo stesso Supertramp nella sua epifania finale. Un’epifania tragica e liberatoria girata come pochissimi avrebbero saputo fare, con un climax meraviglioso e ben sottolineato (come tutto il film) dalle musiche di Eddie Vedder. Penn gira alla perfezione la storia e il messaggio di una vita esemplare, nel senso di esempio, non certo da ripetere.
La cronaca del suo egoismo e dei suoi errori sono un passaggio necessario da attraversare per giungere alla consapevolezza finale. McCandless parte da una morale da operetta (“Se vuoi una cosa alzati e prendila” e bla bla sulla falsariga della ricerca della felicità) fino a una verità molto più profonda. Nulla di bello ha valore se non è in comunicazione e in condivisione, se questo bene non può essere trasmesso a tutti. E il film di Penn sottolinea questa morale con maturità, senza falsi pietismi o toni da maestrina.
| Voto (5/5): |  |
210 - La dea del '67
Questo misconosciuto film australiano narra la storia di due viaggi ortogonali. Da una parte c’è un desiderio di spostamento geografico di possesso da parte del protagonista maschile. Dall’altra c’è il viaggio temporale attraverso le pieghe di un passato scomodo e difficile da elaborare e digerire da parte della controparte femminile del film, un’adolescente. Il mezzo su cui i due si spostano è la leggendaria Citroen Ds.
Entrambi i protagonisti hanno ciò che vuole l’altro. Lei ha l’oggetto del desiderio, lui l’idea di una stabilità e una normalità entro cui poter trovare pace per i demoni del proprio passato. Inevitabilmente quindi dal primo burrascoso e sanguinoso incontro, le due vite vengono intrecciate indissolubilmente. Il film di Clara Law pecca quindi su un terreno troppo accidentato. E’ ben scritto, ma è troppo ben scritto. Tutti gli elementi della trama sono dove devono essere, in attesa di essere usati.
Il problema è che questo film sembra un pezzo di teatro. Si vedono tutti gli elementi che su un palcoscenico vengono filtrati dalla mente dello spettatore, ma qui rimangono presenti in qualcosa che dovrebbe essere la realtà. E’ troppo palese la finzione, è troppo palese la ricostruzione in vitro delle emozioni umane. E quindi il film non può catturare.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
211 - Avere vent’anni
Fernando Di Leo è soprattutto noto per noir e polizieschi di altissimo livello all’inizio degli anni ’70. Nessun suo film può essere dunque bollato come poco interessante o leggero, anche se si tratta di un on the road un po’ sexploitation, un po’ erotismo di casa nostra, un po’ commedia di serie B tipicamente italiota. Perché dietro a zinne e battute di bassa lega (quando non pericolosi stereotipi della sinistra fricchettona che fu) si nasconde un film dalla caratura superpiù (qualsiasi cosa questa frase voglia dire).
Di Leo infatti dipinge un film che appare un semplice omaggio ai generi più bassi ai quali si è sempre dedicato solo per far ridere e un po’ di cassa con due dei corpi femminili italiani degli anni ’70 più mozzafiato che si possano ricordare. Invece Avere vent’anni si dimostra ben più profondo di quanto non appaia. Complice anche una svolta nel finale di una brutalità inaspettata e ferocemente fuori dagli schemi (roba alla Deodato “soft”, dove per Deodato “hard” si intende Cannibal holocaust).
Avere vent’anni rappresenta il brusco risveglio da un sogno. Un sogno che non aveva il minimo contatto con la realtà. E un risveglio che fa male, molto male. La cronaca di un fallimento i cui effetti si sentono ancora ora (e non sono sicuro che finiranno presto). La pellicola non decolla per il già citato eccesso di stereotipo e una realizzazione da B-movie che, per quanto voluta, in questo caso non riesce a raggiungere la perfezione da cassetta di un Il boss.
| Voto (3/5): |  |
212 - Wristcutters
“Questo misero modo tegnon l’anime triste di coloro che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”. Se di limbo vogliamo parlare, la citazione più autorevole che può essere usata è quella di Dante in persona (anche se questo pezzo è scritto per l’Antinferno, ma pazienza). E’ così che può essere etichettato questo Wristcutters: non c’è una sola buona ragione per condannarlo, ma si faticano a trovare anche ragioni per promuoverlo.
E dire che l’idea che fa muovere tutta la vicenda non è affatto male. Di più: è intrigante. Un luogo nell’al di là in cui finiscono tutti coloro che hanno commesso suicidio. Un luogo dove è vietato sorridere che fa da sfondo a un on the road movie pieno di elementi interessanti. C’è la ricerca di “quelli che comandano”, c’è un buco nero sotto il posto del passeggero che ingloba tutto, c’è perfino un sornione Tom Waits.
C’è una morale forse un po’ troppo preconfezionata sui miracoli, e sullo sforzarsi di ottenere ciò che deve venire per caso (e quindi fallire). C’è anche una certa dose di ironia, sebbene questa non riesca mai a far diventare alcuno scambio di battute degno di essere ricordato. Forse è questo il difetto peggiore del film: una tecnica di ripresa assolutamente televisiva e attori decisamente non in grado di creare empatia (da telenovela piemontese, se cogliete la citazione). Peccato, perché dalle premesse iniziali questo on the road nell’al di là aveva le carte in regola per sorprendere.
| Voto (2/5): |  |
213 - After life
Koreeda immagina il suo al di là con la tipica dolcezza amara che ha caratterizzato parte della sua filmografia (penso prima di tutto a Nobody knows). La dolcezza è data dall’immagine che vuole creare. Parte dall’idea che, dopo la morte, l’anima di una persona possa spendere una settimana in un centro specializzato in cui alcuni funzionari la aiutano a ricostruire un ricordo. Tale ricordo sarà l’unico pegno che l’anima potrà conservare della propria vita da lì fino all’eternità.
Proprio come le anime del film, anche Koreeda non è interessato a un intreccio o a una storia, ma al creare un’immagine. Una foto che rappresenti un film e una carriera per l’eternità. E ci riesce a pieno, descrivendo con un’incredibile leggiadria una vera e propria macchina che ricostruisce i sogni. E’ delicato, Koreeda, nel descrivere la dolcezza del più bel ricordo di una vita assieme all’amarezza dovuta alla consapevolezza di perdere tutto il resto (una montagna di videocassette che racchiudono un’intera vita: un’immagine che vale più di mille parole).
C’è un altro retrogusto amaro in After life. Ed è la visione della costruzione del ricordo da parte di una specie di corporazione dell’al di là. Lontano dal renderla una possibile satira con un’industria moderna, il tutto assume invece il punto di vista non delle anime che ricostruiscono il proprio sogno, ma dei burocrati per il quale questi ricordi sono pratiche di routine. Ci mettono impegno e partecipazione. E’ una situazione vissuta con sofferenza e pietà. Ma non si può negare che essi passino da un fascicolo all’altro settimana dopo settimana ricostruendo in serie pezzi di presunta unicità.
| Voto (5/5): |  |
214 - Izo
L’al di là disegnato da Miike rappresenta qualcosa in cui l’unione tra la filosofia orientale del karma e Nietzsche trovano un punto paradigmatico. Per Miike dopo la morte c’è un eterno ricomporsi delle vicende della vita, delle sue caratteristiche tipiche che l’hanno resa quello che era. E questo non significa necessariamente una cosa buona. Questo Izo infatti ne è la conferma: una strada sanguinaria e piena di violenza.
Izo non è un horror, anche se abbonda di sangue e di particolari macabri. E’ un viaggio di una profondità inaspettata (e ostica) all’interno della psiche di una macchina da guerra che ha dichiarato il suo odio verso tutto e tutti: che siano uomini, angeli o demoni questo odio si comporta in maniera assai democratica. Che cosa distingue il limbo di Izo da un inferno di sangue e violenza (dove è lui stesso il primo carnefice e vittima)?
Un aspetto fondamentale è la possibilità di salvezza. Miike ci vuole suggerire che perfino una catena che appare immutabile ed eterna (in quanto senza inizio e senza fine) può essere spezzata. Ci sono momenti in cui Izo placa la sua sete di sangue che lo dilania dall’interno e cerca di ricomporsi con la propria umanità. Che riesca nel suo intento o fallisca sia lo spettatore a scoprirlo. Ma è il fatto che questa scelta ci sia sembra essere la cosa importante per Miike. Speranza nel più oscuro dei suoi film? Una trappola? O forse solo ingenuità?
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
215 - Inferno
Un kolossal prodotto e girato in Italia che mette assieme l’opera di Dante con una voglia di spettacolo e regia, assieme al comparto di effetti speciali, in pari con lo stato dell’arte contemporaneo alle riprese? A dirlo oggi suonerebbe assai strano. Di più: assolutamente impossibile, dato che il miglior tentativo che si è visto negli ultimi anni in tal senso è stato Barbarossa, il che è tutto dire. Eppure questo Inferno lo è. Anche se è stato girato nel 1911.
All’epoca, evidentemente, c’era qualcuno che aveva voglia di osare anche nella cinematografia dell’italico suolo. Difficile dunque riuscire a recensire tale film secondo l’occhio di una critica moderna. Di sicuro il bianco e nero viene utilizzato in maniera assolutamente consapevole e rifugge il più possibile le logiche teatrali che all’epoca ancora dominavano la scena. Non siamo a livello dell’uomo che sapeva troppo di Hitchcock ma, a parte che quel film è di vent’anni dopo, vi siamo ragionevolmente vicini.
Il bianco e nero risalta anche la costruzione dell’inferno dantesco secondo una note di stile scelta ben esplicita da parte di Francesco Bertolini e Adolfo Padovan (i registi). L’immagine viene costruita per ricalcare la potenza visiva delle incisioni di Gustav Doré: è ben più che un omaggio, è una traduzione in immagini in movimento.
| Voto (4/5): |  |
216 - Jurassik Park
Il film di Spielberg rappresenta forse uno dei tanti padri morali degli anni ’90. E’ la fine del cinema anni ’80, quindi dell’effetto kitsch e della soluzione preconfezionata che deve durare un’inquadratura stretta di pochi secondi. Con Jurassik park si cominciano le corse a perdifiato in enormi campi renderizzati, si comincia a puntare sull’effetto che deve stupire non in quanto in sé, ma in quanto parte del tutto.
E’ la ricerca a tutti i costi dell’”effetto wow”, molto più potente di quella vista negli anni ’80 in cui l’attenzione aveva al suo centro l’uomo e il corpo (vedi Predator, ma anche tutto il cinema di Cameron da Terminator, ad esempio). Di fronte a un tirannosauro l’uomo scompare come piccola particella del caos. Non è un caso se i protagonisti sono Sam Neill e Jeff Goldblum: non certo una coppia di Schwarzenegger!
E’ da imputare a Jurassik park e a film del genere se ormai il cinema mainstream di Hollywood è un patinato in cui solo per caso ci sono facce di attori veri in mezzo ai render di un computer. Questo non è necessariamente un male di per sé se i prodotti avessero una loro indipendenza e valenza autonoma. Ciò purtroppo non è sempre vero, e il mare magnum della piattezza per un intrattenimento fine a se stesso trova qui le sue radici da estirpare.
| Voto (2/5): |  |
217 - Titanic
Come ogni film di Cameron che si rispetti, anche Titanic ha tutto per piacere al grande pubblico. Se facessi una variazione con un campione di incassi o di considerazione nell’immaginario collettivo per decade, probabilmente potrei farla solo con film di James Cameron. Che cosa rende i suoi film così incredibili macchine per fare soldi?
Intanto c’è la storia semplice. Lui ama lei, il mondo li ostacola. Più lineare di così si muore. C’è poi uno stile di regia pomposo, ma non autocompiacente, chiaro ma sostenuto, avanzatissimo tecnologicamente ma al servizio di un’apparenza tradizionale. Tutte note stilistiche che mandano in estasi i neuroni di chi al cinema cerca solo intrattenimento e pochi pensieri. Nel caso di Titanic abbiamo anche lo status symbol del momento, Leonardo “Bistecca” Di Caprio. Il momento più basso della sua carriera, che da quel momento in poi si sarebbe rivelato un disperato tentativo di rimettersi in piedi un’immagine che per tutti era diventata solo “il figone che piace alle bimbe protoemo”.
Ciò che affascina di Titanic è che si immedesima perfettamente negli anni ’90 al punto da esserne quasi simbolo. Al contempo è impossibile non notarne i punti in comune con gli anni ’80 (Terminator) e gli anni ’00 (Avatar) di Cameron: un’immutabilità che sembra prescindere lo spazio (cinematografico) e il tempo.
| Voto (1/5): |  |
218 - Armageddon
Come detto e ripetuto più volte, Armageddon è Michael Bay nella sua forma più pura e isolata dalla maggior parte dei suoi (enormi) difetti. Assieme all’altrettanto puro, ma non così ben riuscito, The rock, Armageddon rappresenta tutto il cinema migliore di Bay. Dall’altro punto di vista, Bay è, se non il padre, almeno lo zio degli anni ’90. Sommare le due cose fa diventare Armageddon la poetica totale che ha imperato dal 1991 al 2000. Agghiacciante.
Abbiamo davvero vissuto una decade del genere? La decade del “c’è il tipo buffo, l’arrapato, il belloccio con la bellona, il superuomo tutto d’un pezzo, lo straniero divertente e il nero gigante”? La decade del “pretendo che le assurdità della fisica siano credibili”? La decade del “non importa cosa succede ma ci sarà sempre un discorso del presidente degli Stati Uniti al tramonto quando decolla qualcosa”? La decade del superuomo a stelle e strisce che fa buchi nei fondali marini e salva il mondo da un asteroide perché la Nasa non sa andare a fare un buco nello spazio (poi ci si sorprende della chiazza di petrolio nel golfo del Messico: per forza! I trivellatori bravi vanno nello spazio)? La decade, Dio ci salvi, di BEN AFFLECK?!
Sì, c’è stata. E, al contrario di quanto cantano gli Afterhours, ne siamo usciti vivi. Un po’ acciaccati, ma vivi. E allora la domanda che vi chiedo è: un film che riesce ad ammassare una tale quantità di elementi tipici di un’epoca può essere considerato brutto? Sì: è orrendo. Ma è un accrocchio talmente brutto che sembra un capolavoro d’arte moderna. Michael Bay: ripensaci. Dopo Armageddon è stato un fallimento continuo. Per la prossima decade torna ai ’90. Lascia stare i Transformers e dacci Bad boys 3 con Will Smith e Silvio Muccino.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
219 - Il sesto senso
Il sesto senso, uscito nel 1999 e primo lungometraggio di M. Night Shyamalan ad aver ricevuto attenzione dal grande pubblico, segna praticamente il colpo di scena della trama chiamata “anni ’90”. A modo suo è un film che racchiude sia la fine della poetica degli anni ’90, sia l’inizio di una filmografia che definire paradigmatica è usare un eufemismo.
M. Night Shyamalan è infatti un regista di pura appartenenza agli anni ’00 e in questi anni ha disegnato una parabola ideale finita con la parodia di se stesso in due episodi. Ad esempio con Lady in the water il suo famoso “colpo di scena finale” è l’assenza del colpo di scena. Una precisa conclusione di quanto iniziato col sesto senso: decostruzione totale dei ’90. The happening ne è poi parodia, in cui gli esasperati toni da tragedia definiti per la prima volta da questa storia di fantasmi si scontrano con un umorismo non facile da percepire.
E infatti se i toni del sesto senso risultano popolari e anticipatori della fortuna tipicamente ’00 dei fantasmi giapponesi, The happening chiude la cordata di questa decade, aprendo la filmografia a qualcosa di totalmente diverso come The last airbender. Forse a qualcuno il nuovo corso di Shyamalan può lasciare indifferente o addirittura far schifo. Eppure era necessario un cambiamento. Perchè il sesto senso rimarrà tra i film “indimenticabili”: ovvero un concetto tipicamente anni ’90 e ormai privo di significato (se mai uno l’abbia avuto).
| Voto (3/5): |  |
220 - L'albero della vita
La filmografia di Darren Aronofsky è ben difficile da inquadrare con poche semplici linee di testo. Ogni film pare essere completamente diverso dal precedente per tematiche, stile, approccio alla storia e ai suoi personaggi. E’ quasi impossibile dunque trovare un parallelismo tra questo film con Hugh Jackman e il successivo The wrestler.Però un minimo di parallelismo e di temi in nuce del successivo Leone d’oro si riescono a trovare.
L’albero della vita è, fin dal titolo, una ricerca con caratteri epici, fantascientifici e filosofici della natura umana. Con l’intento di scoprirne falle e correggerle, con i mezzi e le capacità di cui abbiamo disponibilità. E’ un affresco gigantescamente Klimtiano nella sua potenza visiva di un bacio immortale. Freschi di visione si rimane estasiati dalla tecnica che Aronofsky sa mettere in ogni inquadratura e da un uso maturo dell’effetto speciale come non mai.
E, non appena visto The wrestler, si capisce finalmente a pieno che cosa non andava in questo albero della vita. The wrestler è ancora volontà di potenza, desiderio di immortalità o quantomeno una seconda giovinezza. Magari più introiettata verso il sé che non nel precedente film di Aronofsky. Ma sa essere più sottile, più implicito, suggerisce meglio questa volta per sottrazione e non per aggiunta. L’albero della vita ha un’infantile voglia di stupire, proprio come è infantile la voglia di immortalità. Pecca di immaturità e di voler rendere le cose troppo facili ed esplicite. Questo ne mina i risultati finali, pur facendoli rimanere di livello eccellente (ma non da Leone d’oro).
| Voto (4/5): |  |
221 - Hulk
Fino a poco tempo fa il miglior film tratto da un fumetto della storia del cinema. Superato da Watchmen (e queste sono già due affermazioni belle pesanti che mi rinfacceranno), il film di Ang Lee ha rappresentato per moltissimi anni una vetta a cui pochi sono riusciti ad ambire. E ha dimostrato, ma questo si sapeva già da tempi di Burton e Raimi, che il cinefumetto è roba seria, in grado di dare a veri e propri Autori un palcoscenico di tutto rispetto (quasi al livello della tragedia greca, e non sto scherzando).
E di tragedia greca si parla, in questo Hulk. Perché anche in questo caso c’è lo scontro fortissimo tra due volontà di potenza. Ma soprattutto un duello edipico che ha dell’epico (mi si perdoni l’assonanza). Tutto questo potrebbe far generare sbadigli: “Ma come? Vogliamo un ‘Hulk spacca!’ e tu ci parli di tragedie greche e conflitti Freudiani?”. La cosa assolutamente fantastica di Lee è che questo è un film in cui Hulk spacca. E spacca tutto alla grande (ricordo gli aneddoti di Lee che faceva vedere in prima persona ad Eric Bana come sfasciare un carro armato: impagabile!). Ang Lee usa lo spazio dello schermo come se fosse la pagina di un fumetto, con ritmi, split screen e chine saturate da cardiopalma.
E se nel successivo Brokeback mountain rinuncia alla spettacolarizzazione per tornare a temi a lui cari come Mangiare bere uomo donna non gli se ne faccia una colpa. Ma alla storia dei cowboy gay, che è geniale riadattamento delle fantasie da zitella di qualcuna, FiveObstructions continua a preferire il gigante verde che spacca tutto. Spero che mi perdoniate.
| Voto (5/5): |  |
222 - Intervista col vampiro
Intervista col vampiro è uno di quei classici film cult più o meno underground che sono stati osannati da una non meglio precisata generazione dei primi anni ’90. E si che gli anni ’90 sono stati un periodo sventurato del cattivo gusto (non tanto quanto negli ’80, ma almeno lì la cifra stilistica era chiaramente riconoscibile e un po’ più onesta, per quanto innegabilmente di peggior fattura). Non è che questo debba condannare necessariamente il film, ma francamente non trovo molti elementi della mano di Neil Jordan a cui attaccarmi.
Non mi riferisco tanto al successivo Michael Collins, premiato più per l’attualità al momento dell’uscita che per meriti cinematografici, immagino, ma per film che una volta liberati dalla patina “novantina” risultano essere inni alla fantasia visiva e alla finezza con la macchina da presa (penso all’ottimo Breakfast on Pluto). Discorso che non vale per il film interpretato da Pitt e Cruise. Che, sorvolando su cosa ne pensi la Rice di Cruise (far interpretare Lestat da Cruise è come far fare Rhett Butler a Danny De Vito, queste più o meno le sue parole), poco riesce a fare al di fuori dell’ombra del romanzo originale.
E’ un adattamento troppo piegato alle logiche del romanzo per riuscire a dire di qualcosa di nuovo come opera artistica indipendente. Non riesce ad essere un vero riadattamento, ma solo un tributo al divismo Cruise-Pitt e al passaggio di testimone tra i due. Nessuno credo si sarebbe aspettato un Leone d’oro dopo un film del genere, nemmeno Jordan stesso.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
223 - Rebels of the Neon God
Questo è il primo vero lungometraggio con cui comincia la carriera di Ming-liang Tsai e l’epopea del sempre presente nei suoi film Hsiao-Kang (interpretato costantemente da Kang-sheng Lee al punto da rendere assai difficile scindere uno qualsiasi degli elementi di questo triangolo). E, per essere un inizio che avrebbe portato a un Leone d’oro, le tinte di Rebels of the Neon God risultano essere cupissime e quasi senza alcuna speranza per il futuro.
Il titolo di per sé dice già tutto quello che c’è da dire: i ribelli del Dio dell’insegna al neon, giovani che girano in scooter per una Taipei illuminatissima ma buia dentro, senza una vera ragione per andare avanti. Ragione che viene trovata da un mix di sentimenti nei confronti di Ah Tze e la sciocca vendetta per un ancora più sciocco sgarro ai danni del taxi del padre di Hsiao-Kang.
Un film che vive di episodi e tragicità molto più dei seguenti film di Ming-liang Tsai, che puntano maggiornamente sul surrealismo e la composizione della sequenza perfetta. Anche i tempi di regia sono decisamente differenti, più incalzanti e meno dilatati, rendendo questo film forse non un perfetto Ming-liang Tsai al 100%. Il che non si traduce necessariamente in un difetto (è più scorrevole e adatto a un pubblico non elitario), ma ne fa perdere alcune delle caratteristiche più gustose (l’ironia surreale del Gusto dell’anguria, o gli splendidi e potentissimi affreschi postmoderni di The Hole e Goodbye Dragon Inn).
| Voto (3/5): |  |
224 - Il banchetto di nozze
Premiare il banchetto di nozze nel 1993 significava avere l’occhio veramente lungo su Ang Lee. Il film è molto bello, sa affrontare temi molto cari al regista (che ritornano, tanto per dirne uno, in Brokeback mountain) evitando i drammi esistenziali e trattando tutto con l’ironia che diventa uno dei caratteri principali di Ang Lee (anche se trattare il film come una commedia con Adam Sandler, quale pare dal pessimo trailer americano, è un po’ troppo).
Sa mettere in campo, inoltre, un doppio adattarsi da “stranieri”: sia l’outing omosessuale che l’outing dell’emigrante in terra straniera, che cozza con le abitudini e il sentire comune della strada. Lee sa trattare l’argomento omosessualità con la leggerezza tipico del saggio cavalcantiano, con le scene giuste che solo dopo di lui diventeranno cliché. Tuttavia confermo quanto detto in apertura: premiare il banchetto di nozze non era facile. Non era assolutamente scontata quella scommessa poi rivelatasi vincente, dell’Ang Lee come maestro non solo degli anni ’90, ma anche e soprattutto del 2000 con il già citato Brokeback mountain e Lussuria, entrambi trionfatori a Venezia (e non sono molti quelli che possono vantare ben due leoni d’oro sullo scaffale del tinello).
Tuttavia il banchetto di nozze contiene in nuce tutto Ang Lee: sia degli anni ’90 (Mangiare bere uomo donna) che oltre. E se Brokeback mountain è più un saggio tragico sul cambiamento dei tempi, questo banchetto di nozze vince a piene mani nel capitolo di godibilità e spensieratezza, aprendo un circolo chiuso idealmente da Motel Woodstock.
| Voto (4/5): |  |
225 - Pulp fiction
Quentin Tarantino con Pulp fiction ha dato un discreto scossone al modo di fare cinema negli anni ’90, con importanti ripercussioni che si avvertono fino ai giorni nostri. Questo accade fondamentalmente per la sua doppia abilità. L’aspetto meno percepito, ma comunque famigerato, di Pulp fiction e di Tarantino in generale è la cinefilia: ondate su ondate di citazioni ricoprono il minutaggio di Travolta e compagni. Questo si traduce in qualcosa di molto meno sterile della semplice “caccia alla citazione”: è metacinema allo stato puro, un discorso culturale di ampio respiro che va a scuotere le fondamenta di tutta questa popolare arte.
A questo aspetto culturale poco percepito dai più sta anche un gusto commerciale innegabile, che rende Pulp fiction appetibile per tutti i palati. C’è una certa dose di azione, ironia a profusione e tantissimo ritmo, capace di cullare anche le menti più lontane dal piacere cinefilo delle cultura per la cultura, che comunque è soddisfatto. Reggendo queste conclusioni: perché Five Obstructions non lo promuove a pieni voti?
Due sono le ragioni. La prima è che la rivalutazione in basso del classico intoccabile del passato fa sempre bene ed è in grado comunque di far apprezzare di più quanto di bello aveva da dire. La seconda è che il seme di Pulp fiction ha sì fatto molto bene, ma anche molto male all’industria cinematografica. Il dialogo “pulp tarantiniano” è diventato una vera e propria malattia anche e soprattutto tra tutti quei cineasti e sceneggiatori che francamente non se lo possono permettere (a naso uno dei pochi a usarli nel modo giusto è il Rob Zombie de La casa del diavolo). E un albero si deve giudicare anche dai suoi frutti, non solo dal suo magnifico fusto.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (4/5): |  |
226 - Titanic
Includere Titanic anche nei film di successo per la critica dopo l’inclusione per successi commerciali ha uno scopo evidente. Infatti serve per mettere una determinata luce di fronte a quella che viene considerata “critica” ad Hollywood. La Academy, infatti, non è altro che un organo che applica un voto di maggioranza da una non meglio precisata elite, di cui non è chiaro chi faccia parte e perché.
Il risultato sono clamorose votazioni all’unanimità come nel caso di Titanic o The hurt locker. Qui si cerca di fare luce sul Titanic trionfatore degli anni ’90, ma ben poco si può dire nel film sotto quest’ottica. Perché non c’è effettivamente quasi nessun elemento che lo possa distinguere sostanzialmente da qualsiasi altro grande trionfatore Academy di qualsiasi epoca. C’è l’effetto speciale tirato al suo massimo di lucidità in maniera prettamente finalistica (con il fine dell’abbindolo per pubblico e non visto come mezzo per una forma espressiva nuova come può essere quello di Nolan in Inception).
C’è anche il gretto divismo fine a se stesso nel voler prendere due icone in costruzione e dargli proprio quella stessa costruzione voluta dal pubblico (mai perdonerò Cameron per aver fatto sprecare a Di Caprio degli anni fondamentali per la costruzione della sua figura attoriale, fortunatamente riscattata da Scorsese). C’è infine una trama semplice e lineare, in forma ridotta per venire incontro alle limitate facoltà mentali del pubblico, almeno secondo quanto Cameron pensa del pubblico.
| Voto (2/5): |  |
227 - Hana-bi
Ad Hana-bi si deve il definitivo affermarsi di Kitano come autore internazionale. Un premio, questo Leone d’oro, che arriva un po’ in ritardo: il grande Kitano nasce negli anni ’80 (Violent cop, ma soprattutto Takeshi’s Castle) e raggiunge il suo apice invece molto dopo (Dolls). Visto in questa prospettiva, Hana-bi è dunque un film “sbagliato”.
Come sbagliato è il suo protagonista, stretto tra i fuochi di un passato che ritorna incessantemente a tormentarlo e un presente/futuro senza speranza e foriero solo di dolore (la moglie malata). Una spirale di disperazione senza via d’uscita che non trova giovamento nemmeno nel personaggio (autobiografico) di Horibe, che vive con tranquillità la sua disgrazia attraverso l’occhio salvifico della sua arte (in questo caso la pittura).
Hana-bi è tanto sbagliato come sono stati sbagliati gli anni ’90: dopo la fine delle ricostruzioni, delle ideologie e del culto del corpo e del commerciale fine a se stesso si rimane orfani di un orrendo passato e un presente senza motivo d’essere. E per questo è l’unico film a poter essere promosso con punteggio pieno come rappresentante vero di un’epoca senza rappresentanti.
| Voto (5/5): |  |
228 - Buongiorno, notte
L’operazione che Bellocchio fa sul caso Moro è quello che qua sulle spiagge di Five Obstructions consideriamo cinema puro. Non è molto diverso da un remake o dall’adattamento di un libro con mezzi cinematografici. E’ una presa di elementi oggettivi, sotto gli occhi e il giudizio di tutti, e la loro tramutazione in chiave artistica, di pura espressione dell’artista che non guarda in faccia a nessuno.
Ma l’operazione è ancor più coraggiosa e dagli effetti straordinari in quanto il caso Moro non è affatto un libro o un classico del passato da modernizzare o rileggere. E’ uno dei più tristi capitoli della storia dell’Italia contemporanea: ci sono dietro fatti e speculazioni, nonché ripercussioni dalla portata difficilmente quantificabile in poche righe. Il coraggio di Bellocchio si eleva al quadrato quando egli, su soldi RAI, decide di prescindere dalla cronaca e di fare arte. La sua arte, con le sue proprie regole e il suo messaggio.
Buongiorno, notte è un manuale di cinema, di ciò che dovrebbe essere l’arte. Una freccia pura e diretta, senza se e senza ma, al cuore dello spettatore. Per provocargli emozione, pensieri e reazioni. Su tutte, spicca una colonna sonora forse non originale, ma dalle scelte straordinariamente sagge. Shine on you, crazy diamond.
| Voto (5/5): |  |
229 - La meglio gioventù
Il logorroico film di Marco Tullio Giordana non vorrebbe trattare principalmente di terrorismo. Rappresenta un affresco gigantesco di tutto ciò che è stata l’Italia dal dopoguerra ad oggi. Un susseguirsi di vita dagli anni ’60 ad oggi intervallata dai grandi eventi della propria epoca. Spesso questi eventi sono trattati con estremo realismo, ovvero filtrati dal mass media, ma entrano comunque a fondo nella vita di due fratelli dall’opposto approccio a essa.
Alla fine Giordana rischierebbe di far diventare il proprio film un Forrest Gump italiano. C’è la stessa idea manichea di sdoppiare il proprio personaggio in modo da presentare entrambi gli approcci alla vita che dilaniavano, e dilaniano anche se in forma diversa, l’Italia in due o più correnti di pensiero apparentemente inconciliabili. Se il film si riassumesse in queste poche righe ci sarebbe poco di cui compiacersi.
Giordana invece riesce ad andare oltre. Riesce a creare, pur in mezzo a situazioni che rischiavano di diventare da operetta, un monte di vita vera. Di quella che commuove, fino all’osso. Merito anche di un Lo Cascio in stato di grazia, come ai tempi di Peppino Impastato dei Cento passi. Le scene verso la parte finale, in cui fa capolino la sua canizia, le ricordo ancora a distanza di anni come un concentrato di commozione, tenerezza e pateticità (nel senso buono del termine, il pathos). Un’opera decisamente superiore al simile 1900.
| Voto (4/5): |  |
230 - La Prima Linea
L’immagine della piccola processione di tre macchine scassate, lungo strade dritte e immerse in una leggera nebbia padana alle porte di Padova, credo che mi rimarrà impressa a lungo nella testa. Ben rappresenta un momento dell’Italia nebuloso e surreale, in cui osservare il panorama con pretese di oggettività risultava assai difficile.
Racconta anche di un’epica certamente non positiva, ma che fa riflettere su che cosa avessero nella testa coloro che decisero di rispondere con le bombe alle bombe. De la prima linea, ben prodotto dai fratelli Dardenne di Rosetta, rimane anche un bellissimo monologo iniziale. La battuta “avevamo scambiato il tramonto per l’alba” dipinge magistralmente e con una lucidità da fare paura che cosa accadeva negli anni di piombo. Tanto più che viene pronunciata con uno sguardo fisso in camera, come in uno stato di trance di lucidità, ben interpretato da Scamarcio.
E ci si risparmi lo sbertucciamento incivile nei confronti di questo attore che messo in ruoli seri fa alla grande il suo lavoro (mi viene in mente il simile Mio fratello è figlio unico, nel quale, ahilui, purtroppo scompare di fronte al solito gigantesco Elio Germano).
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
231 - Piazza delle cinque lune
Se Buongiorno, notte pone sul caso Moro un affresco puramente artistico rinunciando alla cronaca per portare un messaggio nuovo, questo Piazza delle cinque lune opera, se vogliamo, nella direzione opposta. La chiave di lettura migliore del film sta probabilmente in come Martinelli ha deciso di dirigere la recitazione di Sutherland.
Il suo protagonista infatti è animato dalla voglia di fare luce sul caso, di sapere la verità. E con questa voglia contagia tutti coloro che gli stanno di fianco. Gli elementi per arrivare a questa verità gravitano attorno a lui: alcuni cadono nella sue mani altri no. Ma sembrano sempre a portata di mano per svelare il mistero. E’ questo il modo in cui Martinelli tratta il caso Moro: un mistero da svelare. Dietro questa concezione, la presunzione di voler raccontare, pur coi suoi dubbi e lati oscuri, la Verità.
Piazza delle cinque lune non è molto diverso dai film sul Vajont o su Barbarossa. Un concentrato di presunzione proprio nelle questioni che richiedono la massima umiltà. Un approccio dall’alto, per verità rivelata quasi divinamente, che non può non risultare stucchevole e, letteralmente, sbagliato.
| Voto (1/5): |  |
232 - La sottile linea rossa
Esiste un magico parallelismo tra lo stile di Malick nel gestire le proprie scene, in particolare ne la sottile linea rossa, e nel gestire la propria carriera. Questo film esula dal film di guerra ed assurge ad altro. Per farlo, Malick attua una dilatazione estrema delle scene che le trasfigura dal loro inizio fino a mutare completamente. Per questo si parte dal combattimento e si arriva all’intima natura umana, alla sopravvivenza, a qualcosa che va oltre un’isoletta del Pacifico.
Chi cerca coerenza storica in un film del genere, sostenendo che lo svolgimento dei fatti è tutto sballato, ha sbagliato film. Nel dilatare la scena, Malick ci suggerisce che essa deve arrivare a dire quello che vuole dire, non quello che le logiche di altri (spettatori, mercato, produttori) vogliono che dica. Proprio come la sua carriera: dal suo genio tutti, da certo pubblico di nicchia alla critica, esigerebbero una produzione più fitta dei quattro film in cinquant’anni che ha fatto. Ma Malick vuole dire quello che ha da dire e, soprattutto come e quando vuole dirlo.
Questo autore è capace di cambiare il cinema con solo tre ore di lungometraggio, come ampiamente dimostra la sottile linea rossa. Ma per farlo la sua scrittura ed esperienza di vita deve dilatarsi quanto le sue scene, inglobando la vita e dandogli un significato.
| Voto (5/5): |  |
233 - Youth without youth
Come ritorna Francis Ford Coppola dopo un’assenza sulle scene internazionali così lunga? Stiamo parlando di uno che ha girato Il padrino, una delle colonne portanti della seconda generazione di cineasti. Cosa ha portato il suo lungo silenzio meditativo? Come si confronta questa colonna con la terza generazione? Semplice: non si confronta.
Il buon Coppola con questo film decide di ignorare completamente il mondo che gli sta attorno. Decide di ripiegarsi su se stesso e sull’indagine del suo passato. Se nel film successivo tale ricerca del passato raggiunge la piena maturità andando a cercare proprio ciò da cui è scaturita (la famiglia) senza reticenze né false ipocrisie con lo spettatore, lo stesso non si può dire per Youth without youth. I due film hanno praticamente lo stesso tema, ma in questo, in italiano tradotto come “Un’altra giovinezza”, Coppola forse si vergogna di questa sua autarchia e cerca di mascherarla.
Si erge a poeta dell’universale (l’umanità) quando in realtà guarda il particolare (se stesso, la sua poetica e tutto ciò che gli gravita attorno). Nessuno credo possa trovare difetti nella sua concezione di cinema, nel suo modo di narrare e inquadrare una scena che procede inesorabile nello sviscerare l’enigma del passato. Tuttavia questa reticenza nell’affrontare quello che davvero sta più a cuore a Coppola tarpa le ali all’intero lungometraggio.
| Voto (3/5): |  |
234 - Sopravvivere con i lupi
Vera Belmont torna dietro la macchina da presa 10 anni dopo Marquise e per continuare una carriera diradata tanto quanto quella di Malick. Tuttavia i paragoni tra i due cinesati si possono fermare qui perché in nessun caso la Belmont può arrivare alle stesse vette espressive del regista americano. Anche se questa pellicola aveva tutti gli elementi per poter essere trattata con la stessa delicatezza che ha animato così sapientemente The new world.
Se quindi la storia di Misha e del suo branco di lupi ci racconta di qualcosa di intimamente collegato all’umanizzazione della natura e all’incomunicabilità umana, questo non viene fatto con troppa consapevolezza e lucidità. Più che assomigliare alla storia ben interpretata da Colin Farrell, questa pellicola sembra una versione sporca e drammatica de La volpe e la bambina. Un po’ poco per l’aura di autorialità e drammaticità che vuole permeare dal film.
Risulta altresì un po’ irritante vedere personaggi che si rivolgono a lupi e costoro capiscono. Senza il giusto tatto scelte del genere risultano irritanti come le persone che parlano ai propri animali come se questi gli rispondessero.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (2/5): |  |
235 - Eyes Wide Shut
Eyes wide shut può e non può rappresentare la ciliegina sulla torta di una carriera che tende all’assoluto e alla perfezione. Può perché ha tutti i tratti della chiusura di un ciclo. Kubrick per i progetti seguenti si stava già interessando a un ritorno alla fantascienza, quindi al passato. Il suo tocco su tutti i generi del cinema (horror, fantascienza, guerra, storico, …) aveva esaurito il suo compito e lo sapeva bene: da qui i numerosi ammiccamenti a tutte le sue produzioni passate nel film (Bowman, Blume, wing C room 114 …).
Non può essere la giusta conclusione del suo cinema per un motivo ben preciso. Tale motivo si distacca dalla considerazione banale che il film non sia “compiuto” o “pienamente kubrickiano” data la sua morte prima dell’uscita. Queste sono considerazioni da uomo della strada. A mio modo di vedere Eyes wide shut non può essere un punto di arrivo perché contiene dentro di sé ancora tantissima voglia di dire. Non a caso è uno dei pochissimi film di cui Kubrick si disse pienamente soddisfatto al punto da considerarlo il suo migliore. Se piaceva a Kubrick significa che era un punto di inizio, e non di fine.
I due anni di riprese, l’immensa post produzione e i rapporti tra girato e lunghezza del film dicono il resto. Eyes wide shut non è un ritorno in grandissimo stile, come testimonia il voto che gli do sotto questo aspetto, ma l’inizio di un cinema nuovo. Che, sfortunatamente, non vedremo mai.
| Voto (4/5): |  |
236 - Nel nome del padre
Jim Sheridan conosce alla perfezione la ricetta per essere sommerso da premi e nomination in giro per il globo (almeno prima di impazzire completamente dirigendo un film con 50 Cent). D’altronde questo film col bravo Daniel Day Lewis non arriva del tutto inaspettato: a spianargli la strada ci fu già Il mio piede sinistro, con lo stesso protagonista. Tutta la forza di questo film da sette nomination all’Oscar (e nemmeno un premio vinto) sta nel ruffiano paravento che fa da premessa a tutto quanto: la storia vera.
Sheridan racconta la storia verissima e romanzatissima di Gerry Conlon, imprigionato ingiustamente dal governo inglese dietro tortura e minacce con la falsa accusa di essere il responsabile di una strage in un pub. Qui non si vuole certo negare né la veridicità degli eventi presentati, né tantomeno la gravità delle azioni di servizi di governo deviati, pronti a crocifiggere con montature e falsità chiunque metta in discussione un potere che si vuole quanto più assoluto possibile, in barba a realtà e volontà del popolo. Il punto è che schermarsi dietro a questo messaggio innegabilmente giusto con un piglio da cavalieri senza macchia e senza paura e senza mai instillare dubbio e umiltà nei propri spettatori è non solo disonesto, ma anche del tutto sbagliato.
Come in Goodbye bafana ritorna il motivo del raccontare in maniera sbagliata qualcosa di giusto. Che risulta essere peggiore e fare più danni del raccontare qualcosa di sbagliato: perdi presa in coloro che sono coesi con la realtà e la giustizia. E offri un aggancio per coloro che invece contro questa giustizia combattono tutti i giorni e siedono nelle poltrone comode dei grandi palazzi.
| Voto (2/5): |  |
237 - Bloody sunday
Questo film di Greengrass rappresenta la prima pietra di una poetica ben precisa con la quale il regista inglese svilupperà i nuovi canoni della branca più promettente dell’action di inizio secolo. Seguito dal più rotondo e completo United 93, questo Bloody sunday mira a farci diventare nord irlandesi per un’ora e mezza e ci immerge nella marcia di protesta che, a causa della repressione inglese, costò la vita a tredici persone.
Greengrass sviluppa l’idea della camera a spalla dentro l’azione. Prende in prestito da Mann uno stile sgranato e atto a riportare su pellicola, o su digitale che sia, l’impressione della totale realtà documentaristica. Diversamente da Sheridan, in Greengrass assistiamo a un cortocircuito tra la realtà della finzione e la realtà vera, al punto da distinguere difficilmente tra l’una e l’altra tanto la resa è ottenuta con sincerità, chiaroscuri e zone d’ombra. Una no man’s land ambigua che di fronte al bianco e nero di chi non accetta il minimo dubbio sulla propria ragione risplende di onestà e oggettiva qualità.
Manca l’elemento massmediologo che sarà poi uno dei cardini fondamentali di United 93, probabilmente la vetta di Greengrass. Ma non si può negare che ciò che caratterizza l’adrenalina dell’azione e la poetica della sceneggiatura dell’ottimo Green zone abbia qui le sue radici e il punto di svolta di un’intera cinematografia.
| Voto (4/5): |  |
238 - Il vento che accarezza l'erba
Sul fatto che un film del genere tutto meritasse tranne che la Palma d’oro a Cannes credo che siamo più o meno tutti d’accordo. Non si riesce a capire come mai venga premiato un film del genere, che è nazional popolare nei suoi contenuti in quanto rappresenta proprio per tutta la sua durata personaggi nazional popolari. Non certo perché questa è la linea del pensiero di Loach (regia) e Laverty (sceneggiatore), una coppia di ferro ormai inscindibile dai tempi di Carla’s song, s’intende.
C’è da dire che l’accoppiata Loach-Laverty è sempre se stessa: in ogni occasione. Loach è incapace di fare capolavori, ma allo stesso tempo è incapace di fare brutti film. Un po’ la stessa cosa che amo dire di Winterbottom. Loach parla col cuore ed espone con la sbagliata passione di uno sprovveduto armato di tanta buona volontà una vicenda che lo tocca nel profondo. Non ne può uscire altro che un fiume di banalità: di banalità buone, detti popolari, imprecazioni per un mondo che va sempre più alla rovina.
Non vale la pena cercare simbologie e significati reconditi in un film di Loach. Anche il destino dei due fratelli che da prima combattono fianco a fianco e poi si trovano su due diverse barricate non rappresenta, in realtà, per nulla un doppio destino dell’anima d’Irlanda. Loach vuole più che altro dire: “Shit happens”. Se davvero sei disposto a morire per una causa, beh… Non ti puoi certo lamentare se alla fine ci muori per davvero.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
239 - Michael Collins
Così come il vento che accarezza l’erba di Loach, anche il Michael Collins di Neil Jordan si trova appuntato al petto un premio non indifferente (se il primo si meritò la Palma d’oro, a Michael Collins andò il Leone d’oro a Venezia). Bisogna dare atto a Jordan di avere messo in piedi un film completo e piacevole a tutto tondo, e di aver diretto un Liam Neeson in stato di grazia praticamente alla perfezione.
Rimane il concetto di non abbassare il capo di fronte alle ingiustizie, ma, soprattutto, di non farlo in maniera furba. Rimanere ancorati a romantiche idee di onore nei confronti del nemico quando questo nemico non aspetta altro che giocare sporco per schiacciarti al tappeto è fondamentalmente un errore grossolano. Certo: Jordan in questo pecca nel non voler scavare più a fondo cosa significa farsi carico di una lotta del genere e sacrificare la propria dignità per la libertà altrui.
In altre parole il suo Michael Collins ha grandi pretese autoriali, che perfino gli sono state riconosciute dalla giuria di Venezia. Ma a tali pretese non corrispondono effettive qualità: tutto è dove ci si aspetta che sia. E questa è proprio l’ultima cosa che dovrebbe essere premiata in un autore che decide di raccontare qualcosa di così controverso.
| Voto (3/5): |  |
240 - Mad Max
Non sarà l’inventore del futuro post apocalittico, ma di sicuro la pellicola di George Miller, prima di una trilogia, si è ritagliata uno spazio ben più che dignitoso nell’immaginario collettivo. Non brilla praticamente per nessuna scelta originale, nemmeno nello stile, eppure la somma di tutte queste non originalità ha avuto la sua presa sul grande pubblico.
Ad esempio viene rispettato in pieno il cliché dell’uomo duro e puro devoto alla giustizia e al rispetto delle regole che decide di uscire da queste regole per ottenere la soddisfazione della vendetta dopo un enorme torto subito. Un rilettura in stile Fallout dei film con Charles Bronson, insomma. Meglio senza dubbio di pellicole bollite come Giustizia privata, in quanto almeno riesce ad inserire questo soffritto di banalità in una cornice inusuale per il genere. Ma ben lungi dal riuscire a dire qualcosa di più interessante.
D’altronde Mad Max è stata anche la pellicola che ha definitivamente lanciato Mel Gibson. Data questa considerazione, esiste forse una sola ragione per salvare il film? Ci ha condannato a sopportare Gibson come Terminator: salvation ci ha condannato a Sam Worthington: un peccato mortale.
| Voto (2/5): |  |
241 - Metropolis
Allontanarsi così tanto dai nostri tempi significa avere per forza di cose previsioni meno precise su quali saranno i destini dell’umanità. Si parla d’altronde di quasi 90 anni: che ne sappiamo di cosa avverrà nel 2095? Tuttavia ciò che è differente investe anche linguaggi narrativi a noi particolarmente alieni. Per quanto Verne sia il padre della fantascienza, è innegabile che oggi un Viaggio sulla luna appare prima di tutto letterariamente ostico.
Di Metropolis c’è da dire che, nonostante l’avvento dei cyborg umanoidi sia ancora di là da venire, il quadro dipinto della società del XXI secolo non è tanto impreciso quanto lo si potrebbe superficialmente considerare. Lo stesso personaggio di Maria, il robot mediatore tra coloro che progettano e coloro che costruiscono (dualità eterna all’interno dell’umanità), può finalmente essere interpretato a livello metaforico. E rappresenta l’aspetto positivo che nella società moderna può avere la tecnologia che sta dietro Internet.
Perché Internet, come Maria, è fatto per la comunicazione, per la messa in comune di esperienze e punti di vista da condividere. Per la creazione di un tutto che è superiore alla somma delle sue parti complementari. Una volta che questo flusso comunicativo è in grado di dare a chi progetta una visione sul come si fanno le cose, e viceversa, uno dei grandi problemi dell’umanità può dirsi risolto. Peccato solo per l’eccesso di utopismo (non ultima l’eterna tribolazione per la difesa della net neutrality, non lontano da cosa accade attorno a Wikileaks e all’Operation Payback…).
| Voto (5/5): |  |
242 - 2001: Odissea nello spazio
Il film di Kubrick è una pellicola sulla quale, al pari di Pulp fiction, gravita un’enorme quantità di pregiudizio e di giudizi dati un po’ troppo alla leggera. Rientra, per farla breve, in un ristretto numero di film “intoccabili”, dei quali non si può parlare male o si sarà soggetti di squadrate dall’alto verso il basso gonfie di spietato giudizio riguardo la nostra superficialità. Non che questo influenzi molto la valutazione dell’effettivo valore del film, ma è una cosa che va detta.
Anche perché riguardo a 2001 non ci si ferma generalmente nell’annoverare i suoi effettivi pregi (grandissima qualità registica, uso pionieristico e affascinante dell’effetto speciale, un’ottima sceneggiatura dotata di tanti strati di lettura quanto la Divina Commedia, …). Bisogna annoverare ogni singolo aspetto del film tra i suoi pregi. In particolare, il fan di 2001 si crogiola nel considerare anche quanto la pellicola sia piena di piccoli elementi tecnologici che si sono poi realizzati anni dopo, nei nostri tempi.
Un ben misero pregio, a mio avviso. Che accomuna il film più che a una vera occhiata d’autore sulla possibile società del futuro (il nostro presente, in questo caso stereotipato e non troppo azzeccato) a una misera raccolta di gingilli tecnologici alla Star trek. Non è prevedendo Skype o l’iPad che si dà una visione e una critica a ciò che diventeremo, e questo è ciò che 2001, tra gli infiniti altri suoi pregi, non ha volontà di fare.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (3/5): |  |
243 - Fahrenheit 451
Questo film di Truffaut è forse la visione del futuro che più si può avvicinare a quanto effettivamente si sta realizzando. Non tanto per alcuni piccoli elementi contingenti dell’intreccio più espliciti che possono sembrare demodé, o apparenti previsioni errate, quanto per lo spirito di fondo che permea la pellicola. Fahrenheit è un film d’atmosfera, un lavoro di regia che prescinde molti dei suoi elementi narrativi per farsi diretta comunicazione con lo spettatore (e in questo supera il romanzo di Bradbury).
Del futuro rimane l’immagine in cui l’informazione e la cultura è al centro del potere. Ovviamente per manipolare la massa ed orientarla verso la sudditanza di situazioni sulle quali è illusa di non aver alcun controllo. Se nel film ciò che trionfa è il pensiero unico della televisione, non bisogna farsi ingannare e pensare che questo periodo sia scampato grazie all’illusione di potere comunicativo che ci dà il Web.
Perché è proprio il 2.0 ad essere la nuova televisione. Se dare una forma e un contenuto web orizzontale può essere come nel finale del film l’impararsi a memoria un aspetto di pluralità a immortale testimonianza per il futuro, con il nuovo Fahrenheit 3.0 ciò lo si vuole distruggere, rendendo il web uno specchio solo per l’immediato e lo stereotipo frase fatta per collezionare tanti “Mi piace”. Truffaut non poteva certo prevedere e parlare di Social web e di Facebook, ma quanto la sua televisione riesce a far suonare questo campanello d’allarme perfino ora.
| Voto (5/5): |  |
244 - Munich
Sebbene il film di Spielberg sia dedicato interamente al post-Settembre Nero, risulta essere un po’ fuorviante l’enorme carenza della parte introduttiva, ovvero della scintilla che ha innescato il tutto. In questo aspetto la pellicola prende la paga sotto tutti i punti di vista dal meraviglioso documentario One day in September di Kevin MacDonald. Questo perché per capire il post-Settembre Nero è necessario ricostruire il clima di quella Olimpiade e la pur onesta rappresentazione della breccia nella sicurezza non è certo sufficiente.
Il minutaggio a disposizione del film era sufficiente per uno scopo al quale, evidentemente, Spielberg non ha dato il giusto peso. Pur sbilanciata, però, la pellicola assurge a una delle sue migliori opere. Testimoniando che, alla fine dei conti, la sua fama di cineasta, pur sopravvalutato, del tutto immeritata non è.
In particolare Spielberg sa rappresentare con efficacia sia la normale e giusta determinazione di chi subisce attacchi di difendersi con tutti i mezzi possibili, sia le perversioni e i crimini in cui si cade se tale diritto fa perdere la bussola della ragione. In particolare, Daniel Craig sovrasta il pur bravissimo Eric Bana, con il quale riesce a mettere in scena alla perfezione questo indissolubile dualismo. Due ore abbondanti ben spese nella, probabilmente, migliore pellicola mai diretta da Spielberg.
| Voto (4/5): |  |
245 - La terra dell abbondanza
Wenders decide di creare un finto thriller per mettere una nota di genere in una carriera autoriale che di genere non ha mai avuto granché. Difficile dunque inquadrare una sua pellicola in una cornice, in quanto fluida, fuori dagli schemi. Il suo mettere elementi qua e là ad uso e consumo di un cinema che non gli è proprio direi che è forse uno degli elementi peggiori della pellicola
Quello e, probabilmente, l’aria da moralismo un po’ troppo superficiale da poetica di MTV. Di fatto, la scelta di affidare parte della colonna sonora agli U2 non è decisamente un buon segno. Rischia di trasformare la pellicola nel buonismo bianco contro nero in cui troppo semplicemente si affermano valori che, per quanto veri, hanno bisogno di un processo necessariamente più profondo e complicato per essere circostanziati ed interiorizzati.
Di buono c’è da dire che Wenders ne è capace, pur stordito da un progetto che, probabilmente, non è andato nella direzione che avrebbe voluto. D’altronde il film viene dopo la splendida svolta documentaristica e la non troppo prolifica amicizia con Bono. Insomma, un film un po’ noioso, superficiale nei contenuti, ma perfetto per rappresentare le reazioni di parte di una società che si interroga, genuinamente sorpresa in quanto non parte del sistema di comando, che cosa abbia mai fatto di sbagliato.
| Voto (3/5): |  |
246 - World trade center
Oliver Stone prosegue inesorabile nella sua idea di cinema. Quell’idea per cui ogni snodo cruciale della storia deve essere da lui rappresentata all’interno della sua concezione artistica. Se questa strategia in passato ci ha dato ottime prove, queste non sono state altro che intervalli a singhiozzo in un panorama piuttosto monocorde e niente affatto profondo come potrebbe sembrare.
Se la terra dell’abbondanza di Wenders riflette il bidimensionale addossarsi le colpe e scagionare i colpevoli di certo estremismo radical chic, Stone sta nel mondo a stelle e strisce diametralmente opposta. E cioè quella degli sciacalli per cui ogni tragedia è da inquadrare sotto il punto di vista dello spettacolo. Ed ecco che il crollo delle torri è un melodramma quasi Bollywoodiano, la Grande Tragedia dei Grandi Eroi coperti di polveri, superumani dai supersentimenti
Tra World Trade Center e un reality show sullo stile del Grande Fratello non c’è molta differenza. E’ la spettacolarizzazione inutile di ciò che spettacolare non è. Le uniche differenze depongono, incredibile dictu, a favore del Grande Fratello e non del film di Stone. Perché almeno il Grande Fratello ci fa rimanere attaccati al terra terra quotidiano. Stone, invece, ha la pretesa di trattare questo pezzo pornografico come se fosse. Lo può essere solo nella logica di Fox News.
Leggi la scheda del film >>>| Voto (1/5): |  |
247 - Die hard 3
Nei tempi di un terrorismo cupo attuale e pervasivo nelle vite di ognuno, si può anche chiudere con una chiosa allegra sui bei vecchi tempi. I cari vecchi terroristi naturalizzati americani che, almeno coerentemente con l’ambiente in cui vivono, non si muovono se non per una montagna d’oro. Die hard è film di terrore americanissimo, sia in quanto puramente a stelle e strisce sia in quanto profondamente critico sull’americanità.
Non a caso infatti la trilogia trova il suo punto debole nel secondo episodio che, al contrario del primo e del terzo, non ha visto alla regia un solidissimo McTiernan. Profeticamente infatti il buon John McLane critica aspramente l’icona classica dell’action ’80, quella indistruttibile il cui ingresso nell’ambiente rende una macchina intoccabile capace di distruggere tutto e tutti. In Die Hard è McLane stesso ad essere distrutto progressivamente sullo schermo, mentre lo scenario rimane immutabile. Segno prima dei tempi della “distruttibilità” che il terrorismo avrebbe inflitto a New York.
Ad aggiungere ulteriore sale alla cosa, sta la connotazione aurea del terrore americano: non tanto legato a bombe (finte) quanto alla (finta) scomparsa di ricchezza sul quale costruire una fortuna alle spalle di tutti. Ah, se avessimo avuto McLane a Wall Street negli ultimi anni…
Leggi la scheda del film >>>| Voto (5/5): |  |





















































































