Dei falsi e dei veri bisogni
Su Cracked l’altro giorno è comparso un bell’articolo che riesce a dare una divertente impronta visionaria a quello che sta succedendo alle nostre economie con l’avvento e l’affermazione di una tecnologia digitale sempre più estrema. Trovo l’articolo molto ben scritto, ma non riporto qua solo il link perché mi pare che abbia un fondamentale difetto. Essendo rivolto al pubblico di Cracked il suo scopo non è tanto quello di approfondire la materia trattata, ma fornirne un punto di vista parodico e satirico. E quindi si ferma dove in realtà comincia un intero mondo. Vale la pena dunque parlarne qui per spiegarvi dove sta, secondo me, l’importante punto di partenza.

Inoltre l’articolo è molto incentrato sull’aspetto economico di quello che il Web ha portato sulle nostre tavole. Mentre a me interessa prettamente il punto di vista artistico. Non che non abbia le mie idee sull’economia, ma non essendo esperto in materia probabilmente ciò che penso è fin troppo naive e, quindi, poco interessante.
Partiamo da un riassunto. I punti fondamentali dell’articolista sono i seguenti:
- Un incredibile ammontare di bisogni umani con le nuove tecnologie del Web possono essere soddisfatti integralmente e in maniera infinita senza uscire di casa, semplicemente pagando un collegamento Internet;
- Queste tecnologie permettono una distribuzione gratuita e illimitata di moltissimi prodotti e l’unico modo che il business, per come è concepito adesso, ha di continuare a fare profitti è convincere tutti che questo non sia vero, che questi prodotti sono in quantità scarse e insufficienti per tutti e, dunque, bisogna pagarle (la scarsità forzata, FARTS in inglese, eheh);
- Un incredibile ammontare di prodotti nascono già con tutte le loro proprietà avanzate, ma con dei blocchi che possono essere rimossi solo pagando un extra;
- Questo processo non coinvolge solo i musicisti o i registi messi in difficoltà col P2P, ma chiunque: la maggior parte dei lavori di oggi possono essere digitalizzati e automatizzati con poco sforzo;
- L’unico modo di salvare l’attuale modello di business è quello di inventare un monte fumante di bugie sulla maggiore qualità dei prodotti e della loro scarsità forzata: non importa che il prodotto creato con procedimenti elettronici sia lo stesso di quello fatto a mano, il secondo avrà valore maggiore e potrà essere comprato a un prezzo esorbitantemente più alto.
Di tutti i punti il 5 mi piace particolarmente, perché va a colpire il classico luogo comune che vuole il prodotto fatto a mano portatore sano di una non meglio precisata maggiore qualità. Anche se di tale qualità nemmeno ci accorgiamo. A tal proposito ricordo l’aneddoto che riguarda il marketing dei profumi: una percentuale esorbitante di persone non ha la minima capacità olfattiva per percepire le differenze qualitative di due profumi prodotti con due formule leggermente diverse. Ma tutti sarebbero pronti a giurare sulla testa della propria madre che quello che appare più raffinato, costa di più e ha l’aria genuina è migliore. Son cose che fanno riflettere.
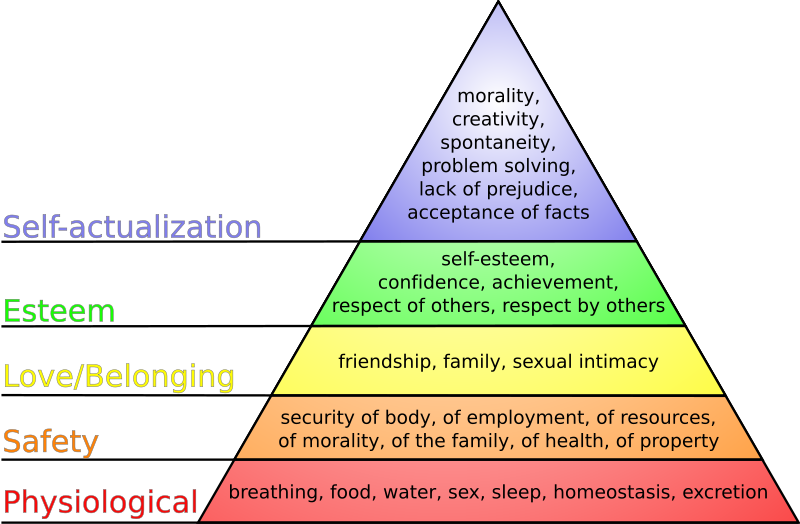
I punti sui quali sollevo il mio spirito critico sono fondamentalmente il secondo e il quarto. Innanzi tutto, e qui c’è la mia personalissima teoria economica, non credo sia per nulla necessario salvare l’attuale modello di business. Prima che pensiate che sia un malvagio kommunista amato di falce e martello sappiate che io nel capitalismo ci vivrei bene, se solo ci fossero due o tre cosette aggiustate. Ma la crisi economica che vede una crescita praticamente zero tra il ’99 e il 2010 per l’Italia non credo sia frutto di un sistema perfetto. D’altronde tutto il capitalismo si fonda sul fatto che è conveniente creare un’industria per soddisfare un bisogno. Tutto perfetto: il problema però nasce quando questo bisogno scompare.
Qui il capitalismo, se fosse coerente, farebbe scomparire anche l’industria. E invece no: deve costruire un falso bisogno e tempestare di terrorismo la popolazione che non sente più questo bisogno perché altrimenti il sistema stesso crolla (come sta facendo). Ovviamente tutto questo appare malsano a chiunque abbia un po’ di senso critico. E’ successo con l’auto (se non ci fossero gli incentivi statali la metà della fabbriche avrebbe già chiuso), ma a me interessa quello che è successo alla musica.

L’industria musicale è nata perché qualche manciata di decenni fa si è creato il bisogno della diffusione di questa meravigliosa arte. E sono nate delle organizzazioni che si preoccupavano di registrare e distribuire queste registrazioni dietro un sacrosanto compenso. Ma il bisogno che soddisfavano non era quello della fruizione della musica: era quello della sua diffusione. Una volta che questo bisogno sparisce, per via del progresso tecnologico, l’industria non ha più senso di esistere e deve dunque sparire. E invece preferisce divenire mafia (la RIAA, la SIAE) e fare del terrorismo.
Ma la distribuzione P2P non ha arrecato nessun danno agli artisti: mai come negli ultimi anni c’è stata un’offerta tanto varia e tanto vasta in tutti i generi. Sulla qualità non posso dir niente perché non me ne intendo, ma c’è anche da ricordare che l’indipendenza tra la qualità artistica e i soldi investiti è talmente evidente da non meritare di spenderci del tempo per ricordarla pari a quello di scrivere questa frase. D’altronde il mercato è evoluto nei vari iTunes e simili che, guardacaso, nella maggior parte dei casi con RIAA ed etichette discografiche pochissimo hanno a che fare. E’ il medesimo scenario di transizione che ci fu per la mobilità urbana dalle carrozze alle automobili. Non un singolo produttore di carrozze si è messo a fare automobili e sono tutti falliti. Qualcosa vorrà pur dire.

Perché accade ciò? Perché il bisogno vero per quanto riguarda la musica (e, probabilmente, il resto dell’economia) non risiede nei vecchi bisogni drogati dallo spirito conservatore, ma in quelli che persistono o diventano nuovi. In un mondo in cui l’interazione diviene virtuale, perché rivoluzionata proprio da coloro che ne sono l’antitesi incarnata (ciao Zuckerberg, tra poco leggerete anche la mia recensione di The Social Network) la fruizione diretta dell’emozione è un bisogno vero. La musica vera vive di spettacoli dal vivo: è lì che l’artista fa la differenza e ottiene i propri guadagni. Del grasso sui CD da regalare alle etichette ne fa volentierissimo a meno.
Il confine tra questa considerazione e il punto 5 dell’articolista parrebbe labile. Il discorso su quanto bella sia l’esibizione dal vivo potrebbe essere considerato parte della pila di cazzate che gli alfieri del marketing saranno costretti ad inventarsi. In realtà la differenza è importantissima. La soluzione disonesta è quella di prendere un finto bisogno ormai estinto ed edulcorarlo, tenerlo in vita oltre l’accanimento terapeutico. Questo porta a fossilizzarsi su una staticità che è solo la punta della campana della crescita che poi porterà al baratro. La soluzione corretta è quella di analizzare costantemente dove stanno andando i bisogni vivi e dove si creano quelli nuovi. E soddisfarli. Se Facebook non fosse nato su un nuovo bisogno, i suoi 25 miliardi di dollari di valutazione con il quale ha creato un immane numero di posti di lavoro non sarebbero mai esistiti. E sarebbero rimasti nelle tasche di chi droga mercati morti e letteralmente pompa via denaro senza dare niente.

Purtroppo, ahimè, non vedo nel cinema al momento un futuro roseo come quello della musica. Ma questo, fondamentalmente, perché l’alternativa tecnologica che libera l’arte dalle catene di un bisogno circostanziale non è ancora stata inventata. Il P2P al momento funziona bene per la musica, ma malissimo per il cinema. Ma sono abbastanza sicuro che prevedere un progresso, nella prossima decade, riguardante gli attuali bisogni del cinema non sia altro che scontato. E forse libererà il percorso dagli artisti ai fruitori del film di qualcuno degli inutili passi della sua attuale catena distributiva. Che renderà tutto sostanzialmente migliore. A patto che non vincano le pile di letame che cercano di sommergere l’assenza dei reali bisogni.
Saluti,
Michele



in realtà per il cinema c’è uno scoglio molto molto maggiore: è davvero difficile diventare prosumer. Se musicalmente con poche migliaia di euro posso fare un grande disco e distribuirlo da solo, fare un kolossal senza un produttore è davvero difficile. Nel cinema l’intermediario porta valore, nel senso che investe, nella musica sempre sempre meno
Che è esattamente il mio punto. Ma un domani… chissà.